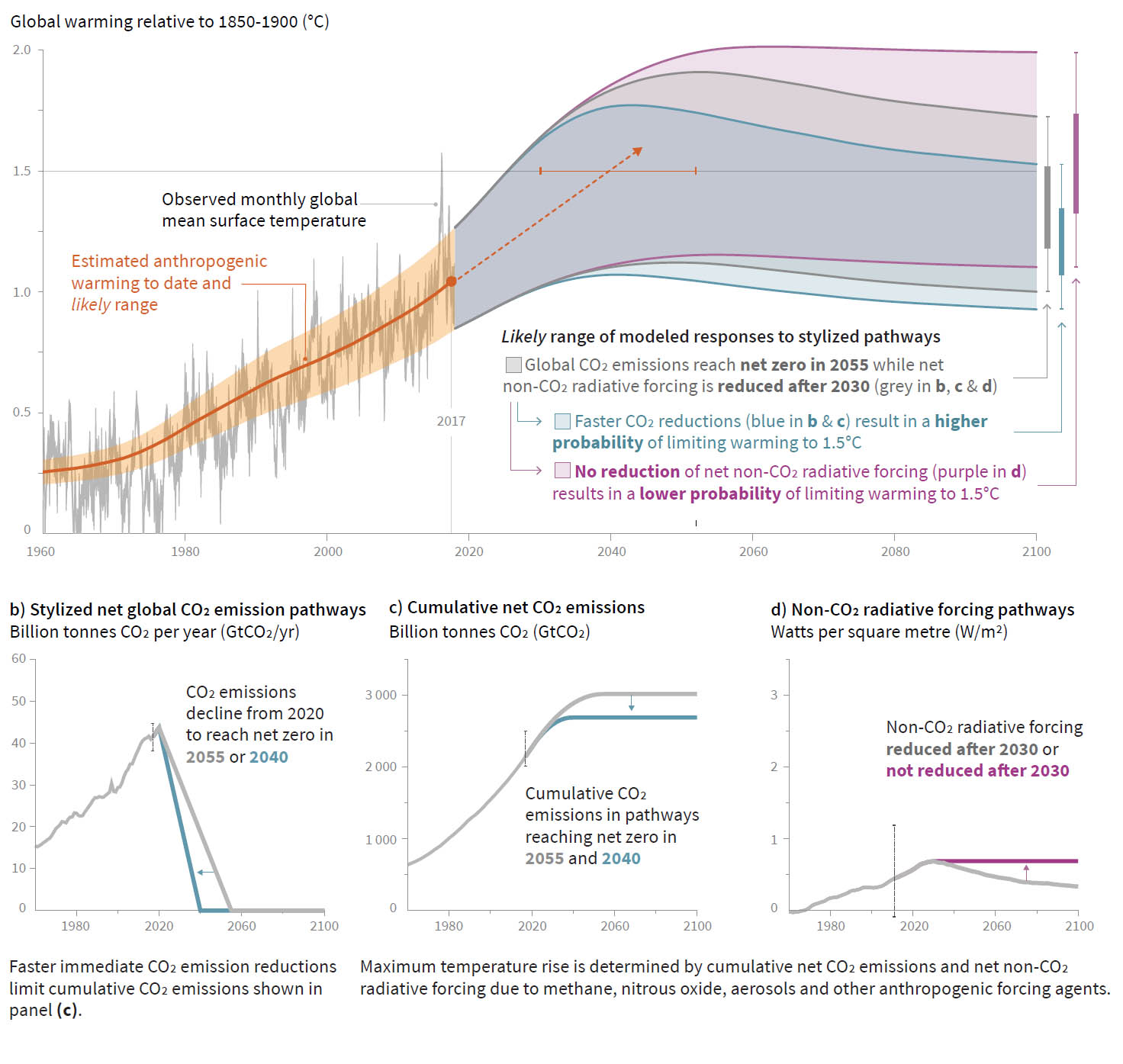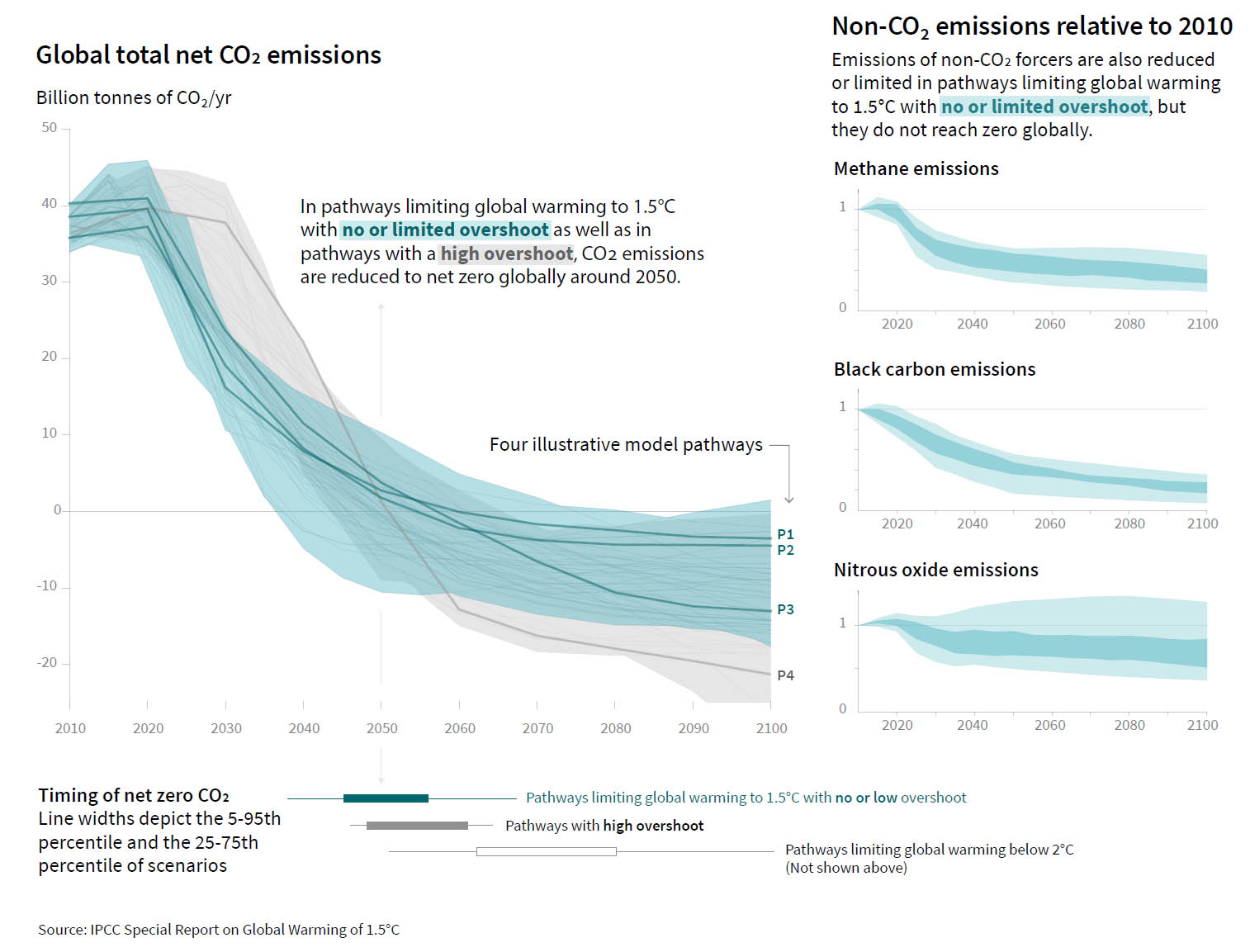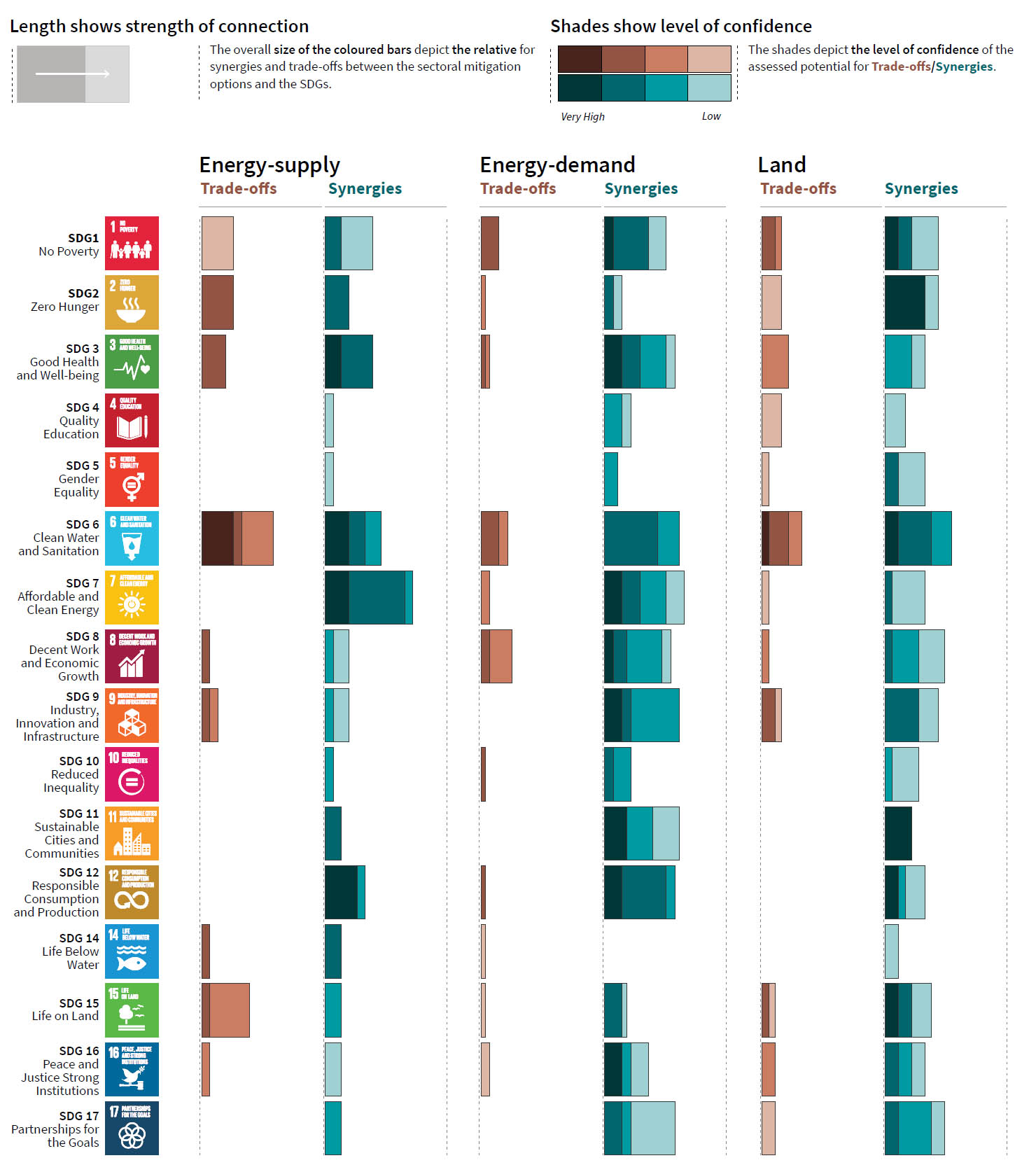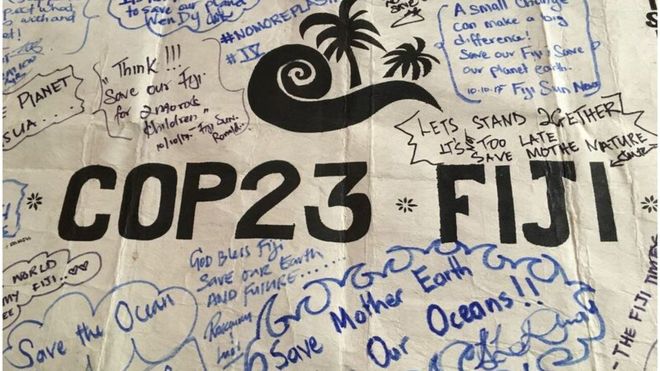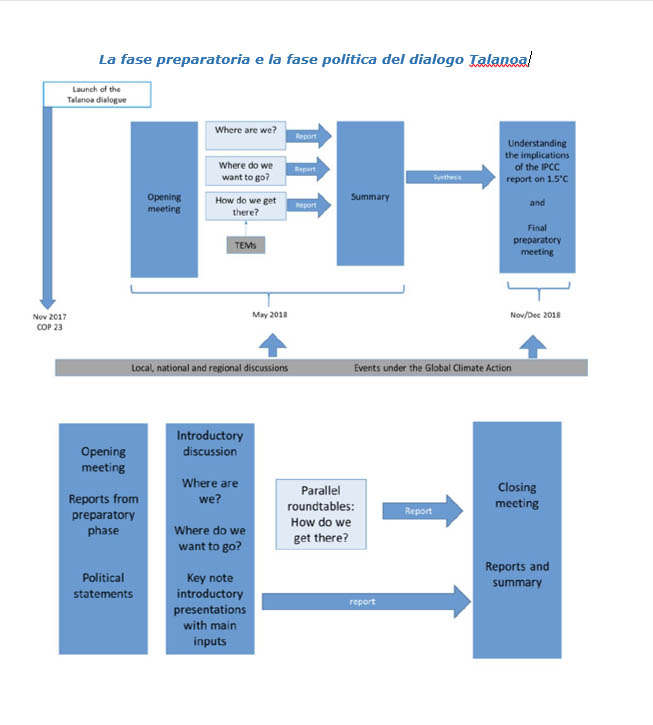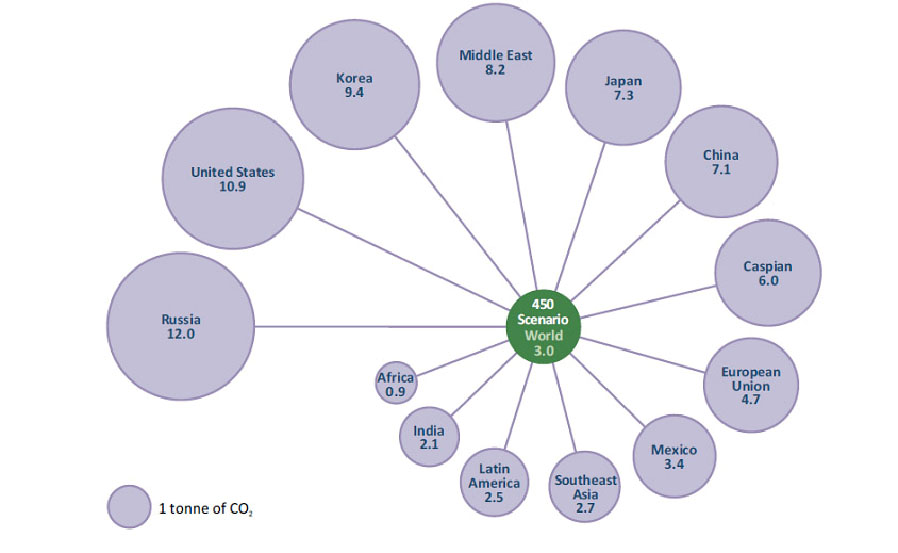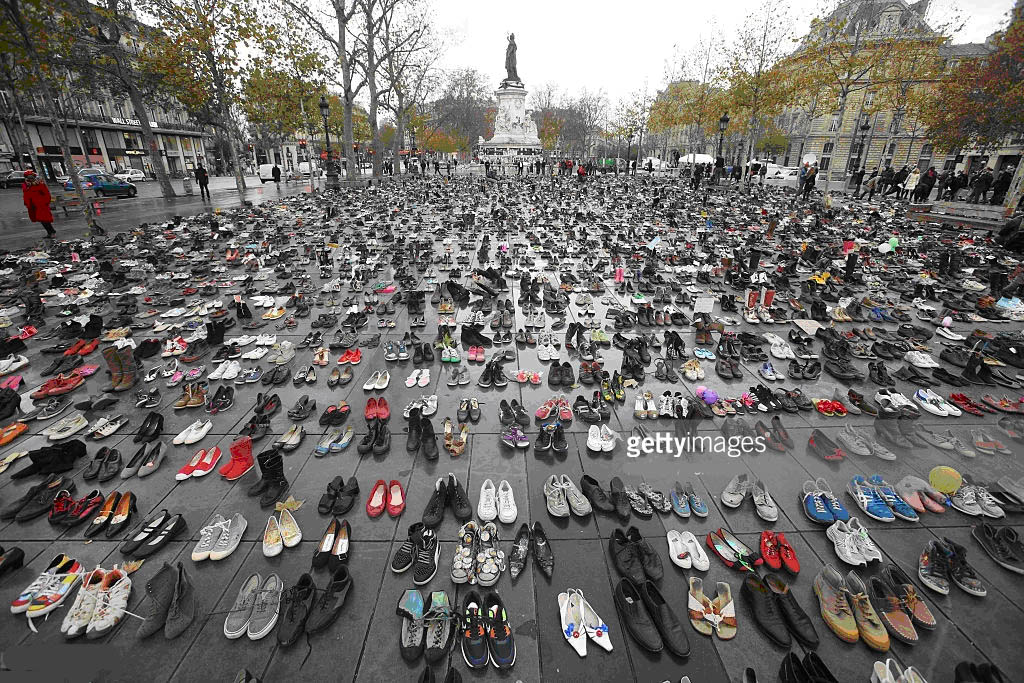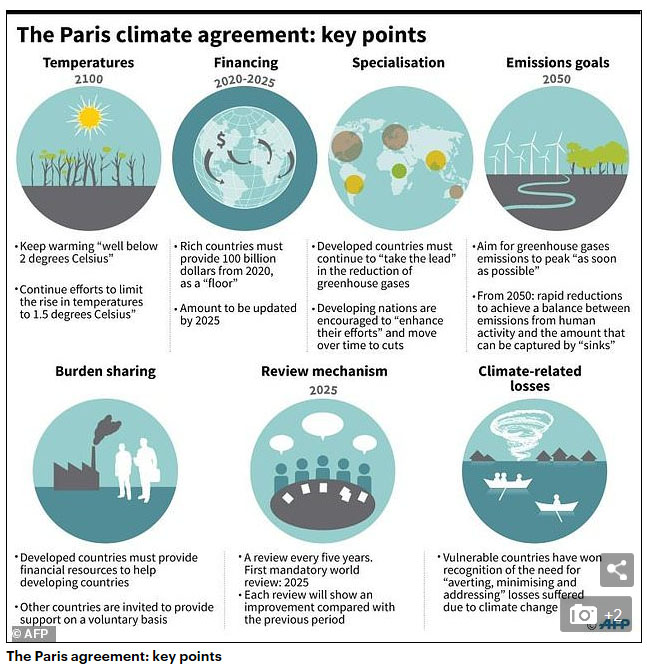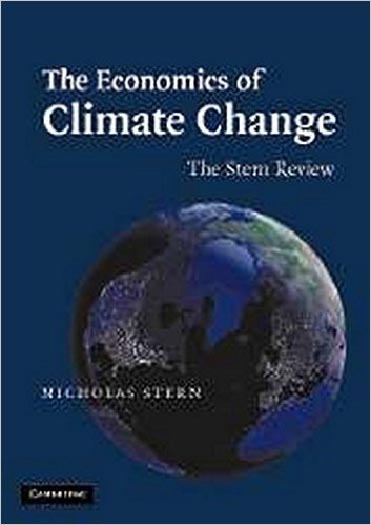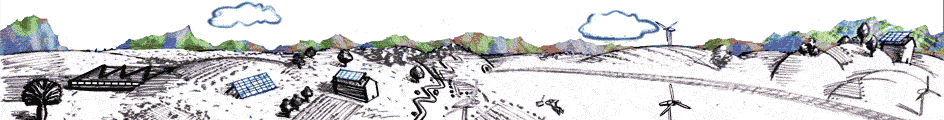|
Aggiornamento 29-nov-2025
|
Comitato Scientifico Comitato di redazione I link Rapporti
ieri Guernica oggi Kiev e Gaza |
|
Lo Sviluppo sostenibile: Storia e tendenze La Green economy Agenda 2030 Bibliografia |
|
|
I cambiamenti globali: Clima Energia Trasporti Territorio |
|
|
Homepage del Comitato scientifico > Clima > I dati globali I dati italiani |
|
| IL CLIMA GLOBALE, LA SFIDA PRIMARIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | |
|
IL NEGOZIATO MULTILATERALE PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO a cura del Comitato scientifico della Fondazione per lo sviluppo sostenibile
2025, 27 NOVEMBRE. RIPARTIRE DALLA COP 30 di Toni Federico
Si è conclusa la COP 30 di Belém con alcuni significativi passi in avanti:
Ma senza risultati apprezzabili in molte materie, in particolare:
Il posizionamento sulla materia delle associazioni come la nostra si è dimostrato più che efficace e capace di individuare correttamente i temi ed i posizionamenti. Una parte della stampa e le associazioni italiane hanno dato resoconti chiari ed approfonditi della COP 30, in particolare I4C, ECCO, CGIL su Collettiva, WWF, e con essi alcuni giornali, La Repubblica, La Stampa, il Manifesto, il Fatto, il Domani. L’interesse del pubblico, in particolare dei giovani, resta da decifrare. Dunque che altro c’è da dire? Una risposta viene evocata dall’immagine di Gaza, ora colpita anche dalle piogge estreme, una metafora vivente del dramma dell’umanità nell’intreccio tra clima e guerra. Quale sostenibilità, quale lotta ai cambiamenti climatici senza cancellare le guerre dalla faccia della terra? Nessuno può sottrarsi da una scelta militante contro la guerra, secondo i dettami anche della nostra Costituzione. Quando fu approvata erano trascorsi più di due anni dalla fine della seconda guerra mondiale e la barbarie del conflitto si era rivelata tale da far ritenere la pace una soluzione obbligata per il futuro, perché un’altra guerra di simile portata si sarebbe combattuta con le pietre (A. Einstein). L’art. 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” è stato concepito in questo clima di necessaria fiducia per una condivisa opzione pacifista. Una scelta dettata anche dal senso di colpa di essere stati noi, purtroppo, a fare uso e abuso dell’elemento guerra nella vita dei popoli. Durante il Leaders’ Summit che si è svolto poco prima della COP 30, il presidente brasiliano Lula ha fatto riferimento ai conflitti in corso nel mondo, affermando che spendere il doppio in armi rispetto a quanto facciamo per l’azione climatica sta spianando la strada all’apocalisse climatica e che non ci sarà sicurezza energetica in un mondo in guerra. Non ha prodotto il risultato sperato. Infatti il programma della COP 30 non sembra riflettere le sue preoccupazioni, dato che non è menzionata alcuna iniziativa di pace nel calendario ufficiale e non c’è stata una giornata tematica dedicata alla pace, una differenza evidente rispetto alle COP 28 e 29, quando Baku aveva invocato una tregua globale per tutta la durata del vertice. Eppure non sono mancate nei corridoi della COP 30 le discussioni sul militarismo e sul suo costo per il pianeta. Uno studio multistakeholder ha mostrato come le forze armate globali producano il 5,5% di tutte le emissioni di gas serra. Se considerate come un paese, sarebbero il quarto maggiore emettitore, superate solo da Stati Uniti, Cina e India, producendo più emissioni dell’intero continente africano. La COP 30 è scivolata ai margini di una tempesta geopolitica, alimentata anche da promotori dell’economia cosiddetta oil&gas. Il legame tra scienza ed osservazioni climatiche e negoziato è di nuovo messo in discussione e sembra spezzato in favore di approcci politici basati sulle convenienze. Nessuno si salva, fatte rare eccezioni. La presidenza del Brasile ha scontato le forti contraddizioni interne, pur avendo perseguito risultati ambiziosi. Il paese è entrato a far parte dell’OPEC nel febbraio 2025, a pochi giorni dall’inizio della COP ha autorizzato nuove estrazioni di petrolio al largo della foce del Rio delle Amazzoni e ha ancora un problema aperto per la delimitazione dei territori indigeni. Il Sud del mondo rivendica giustamente una finanza riparativa, un sostegno tecnologico e un impegno prevalente nella decarbonizzazione da parte dei paesi ricchi del nord globale che hanno la responsabilità storica delle emissioni. Il Nord del mondo si è viceversa sbriciolato rispetto al vecchio impegno che i paesi sviluppati si erano assunti a Rio, oltre 30 anni fa, di farsi carico degli impatti e dei danni climatici di cui sono responsabili universalmente riconosciuti. La domanda di risorse a loro carico per il ripristino dei danni arrecati e dell’adattamento migra via via nel mondo dei sogni. Al Nord la cultura della sostenibilità non si è affatto spenta e alcune gerarchie sono ben riconoscibili. UK e Nord Europa restano i primi attori e hanno cercato di trascinare l’Europa in una posizione di leader mondiale con l’ausilio, va detto, di alcuni paesi mediterranei tra i quali manca ostentatamente l’Italia. Senza tanta convinzione e coerenza, visto che sta smantellando il Green deal a favore del riarmo, puntando tutto sulla neutralità tecnologica. La Cina sta cogliendo l’opportunità di mettersi alla guida di tutto il processo green ma la sua impostazione è infida, basata sulle convenienze commerciali, peraltro acquisite meritoriamente, così come il dominio dell’innovazione e della ricerca scientifica. L’India, forse, segue ma con il passo lento e numeri ancora piccoli rispetto al suo primato demografico. Da Australia e Giappone più ombre che luci. Ci sono poi gli arabi e gli altri petrostati, divenuti maestri nelle loro COP di un occasionale doppio gioco a differenza della Federazione russa che di gioco ne fa uno solo. Gli Stati Uniti, ufficialmente negazionisti, si sono sfilati dal processo negoziale e dagli obblighi finanziari. A lavorare per conto delle oil&gas hanno mandato i Paesi amici e i lobbisti. Il punto è che parlare dei governi del Nord del mondo non basta. Occorre mettere in questione tutta l’economia che conta e l’economia, si sa, è ortogonale rispetto ai sistemi di governo. Non diremo certo che questi ultimi non hanno parte in causa ma suggeriamo di andare a vedere dove nell’economia si annidano conservatori ed innovatori. Si usa dire che economia vuol dire capitalismo e, francamente, non troviamo argomentazioni contrarie. Sulla questione climatica di capitalismi ne vediamo almeno due Non sono diversi sui principi dell’accumulazione e sull’uso dei mercati e delle leve finanziarie. Forse le differenze si trovano nella visione del mondo e del futuro che guidano i rispettivi interessi. Chi deve vendere il gas e il petrolio, i fossili, può andare in conflitto con chi vuole salvaguardare la sopravvivenza nel tempo del proprio ruolo e dei relativi vantaggi. Abbiamo dato a questi ultimi l’ottimistico appellativo di green economy cui il mercato sembra sempre di più dare ragione, spinto dalla convenienza delle fonti energetiche rinnovabili e dell’economia circolare. Dalla Cina viene un messaggio che Belém ha messo a nudo: in assenza di un forte slancio politico per una maggiore ambizione, l'agenda climatica sarà guidata meno dal processo COP e più dalle forze economiche che si stanno sviluppando nel mondo reale. Non così la politica, sempre più retrotopica e short-termista. Resta la società civile, un magma ricchissimo di iniziative resistenziali e progressive. Le nuove tecnologie che, come l’AI, avrebbero dovuto interpretare la seconda transizione della modernità ecologica, sono in realtà finite nelle mani del ricchissimo sistema politico-militare mondiale portandosi dietro anche parte dell’innovazione green. Per garantire una giusta transizione serve un radicale cambiamento di sistema che superi l’attuale modello di uso, distribuzione e consumo delle risorse, in grado di garantire pace, equità, giustizia sociale, un’equa ripartizione delle risorse e della ricchezza, a livello globale e inclusivo e di tutelare i beni comuni e il benessere collettivo delle persone e della natura. In questa luce dove concentrare lo sforzo e gli impegni futuri? Battere in Europa il Black Deal montante, spinto da uno dei paesi più retrivi, l’Italia. Mantenere in Europa la leadership sulla sostenibilità e l’Agenda 2030. Al Parlamento UE è l’ora del Black deal: i popolari votano con l’estrema destra, con 382 voti a favore, 249 contrari e 13 astenuti affossano la sostenibilità per le imprese. L’intesa a destra si consuma sulla responsabilità e sulla rendicontazione delle multinazionali (due diligence): due direttive concepite per la tutela ambientale e dei diritti dei lavoratori contenute nel primo dei provvedimenti Omnibus. La direttiva si applicherà ora solo alle aziende con oltre 5.000 dipendenti e con un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi: via l’obbligo per le imprese di richiedere informazioni sulla sostenibilità della filiera alle aziende partner, via anche la richiesta alle imprese di preparare un piano di business compatibile con gli obiettivi climatici stabiliti dagli accordi di Parigi. Ma in Europa sentiremo l’anomalia termica più che altrove e, stando alla visione concorde degli scienziati, confermata da Guterres alla COP 30, siamo ormai in overshoot, un terreno di alte anomalie termiche che ci porterà eventi estremi, alluvioni, ondate di calore, specie aliene in risalita, nuove malattie e quant’altro. A Belém si è detto che dovrà durare il minimo ma si è fatto poco Eliminare i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e i vantaggi di sistema per i fossili. Finanziare l’adattamento in casa e nei paesi poveri Nel 2009 i governi del G 20 si impegnarono a eliminare i sussidi inefficienti ai combustibili fossili. Poi, a margine della COP 26 di Glasgow, 35 paesi, fra i quali Italia, Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e 5 istituzioni finanziarie pubbliche firmarono la Dichiarazione Clean Energy Transition Partnership, Cetp, il primo impegno politico internazionale per porre fine entro il 2022 ai finanziamenti pubblici a progetti energetici fossili privi di tecnologie di cattura della CO2 e a dare priorità alle energie green. In realtà gli onnipresenti combustibili fossili e il loro utilizzo hanno generato nel 2024 il 90% delle emissioni climalteranti globali. Il FMI ha stimato una cifra record: globalmente, 7.000 miliardi di incentivi sono arrivati al settore nel 2022, ovvero il 7,1% del Pil mondiale. I governi hanno sostenuto consumatori e aziende durante la crisi provocata dalla guerra in Ucraina e per il recupero economico post-pandemia. Per il 18% si è trattato di sussidi espliciti, diretti o indiretti, al comparto fossile ai suoi diversi livelli; mentre l’82% riguarda i sussidi impliciti. Il dato IISD dice che nel settore fossile sono stati investiti nel 2022 dai paesi del G20 in risposta alla crisi energetica 1400 miliardi di dollari in sostegni, sussidi, prestiti pubblici; più di quattro volte la media annuale del decennio precedente. Gran parte destinata ai consumatori, ma un terzo per la produzione fossile. E nella cifra non sono comprese le esternalità negative a carico di ambiente e salute. Fra il 2020 e il 2022 al comparto fossile sono arrivati direttamente finanziamenti pubblici per 142 miliardi di dollari. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha prodotto 237 milioni di tonnellate di CO2 in tre anni, mentre il conflitto a Gaza ha già superato le emissioni annuali combinate di Costa Rica ed Estonia. La guerra in Afghanistan è stata responsabile di ben 400 milioni di tonnellate di CO2, e il riarmo dell’Unione Europea potrebbe comportare altri 200 milioni di tonnellate di CO2, principalmente attraverso la produzione e il trasporto di armi, attività ad alta intensità di carbonio. Contrastare i falsi slogan come la neutralità tecnologica (trasporti, energia) e le false soluzioni, la CCS e i biocombustibili. Neutralità tecnologica e biocombustibili sono stati i contenuti della presenza italiana alla COP 30. Gli stakeholder dei fossili, in particolare da noi, fanno vaghi riferimenti al principio della neutralità tecnologica, se di principio si tratta o non piuttosto di un generico concetto o, anche meno, di uno slogan o di un modo di dire. La verità è che la neutralità tecnologica è sottoteorizzata e, di conseguenza, poco compresa. Pochi la hanno concettualizzata, e i legislatori lo hanno adottato senza un'indagine critica. Sebbene la neutralità tecnologica sia riconosciuta con diversi gradi di approfondimento dal WTO nel commercio di servizi, per gli ostacoli tecnici al commercio o per difendere la proprietà intellettuale e ora anche nel vocabolario dell’UE, spinta certamente da paesi come il nostro, il suo status nel diritto commerciale internazionale non è chiaro e resta tutto da definire, massimamente nei contesti complessi e multidisciplinari come l’energia, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Ci sono poi le vere e proprie false soluzioni come la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS, idrogeno blu, nucleare) che sono ugualmente oggetto di incentivi. Spesso spacciata per soluzione climatica soprattutto per i settori hard-to-abate come acciaio e la chimica pesante, la CCS viene usata in primo luogo per estrarre riserve difficili da raggiungere in una pratica chiamata Enhanced oil recovery (Eor). Rispetto alle rinnovabili, è una vera scappatoia, il cui costo ricade su contribuenti e consumatori. Italia e Brasile hanno lanciato a Belèm una campagna 4X per quadruplicare la produzione di biocombustibili. Il Brasile ha uno territorio incolto pari all’Etiopia e una grande produzione di canna da zucchero, ma l’Italia, povera di territorio, vuole solo garantire i suoi motori endotermici, immaginando probabilmente di comprare altrove i terreni per il biofuel, magari con il Piano Mattei, esportando insostenibilità come già accaduto con l’olio di palma indonesiano. Gli impatti ambientali possono essere generati in tutte le fasi della produzione e della lavorazione delle biomasse per i biocarburanti, ma tendono a predominare i processi legati al cambiamento dell’uso del suolo e all’intensificazione. Inoltre, convertire le foreste per la coltivazione di qualsiasi tipo può rilasciare quantità di gas serra che superano di gran lunga i potenziali risparmi derivanti dai biocarburanti (FAO). Merita ricordare che ’Italia presiede la Global Bioenergy Partnership (GBEP), lanciata alla 14° sessione della UNCSD nel 2006. Oltre 100 membri della comunità scientifica globale, inclusi rappresentanti del WRI e della Union of Concerned Scientists, in vista della COP 30 hanno firmato una lettera che invita i leader mondiali a limitare la pericolosa espansione dei biocarburanti. Bioenergy is a false solution conclude De Smog.
2025, SABATO 22 NOVEMBRE. I RISULTATI DI UNA COP 30 IN TONO MINORE
Tralasciamo la cronaca dei sussulti finali della COP 30, che non si sono fatti mancare manifestazioni oceaniche, un incendio e una valanga di critiche anche alla gestione brasiliana, cronache largamente documentate dai media e dalle agenzie specializzate, per riferirvi la sostanza delle conclusioni, con l'aiuto puntuale di un team meritevolmente messo su dagli inglesi di Carbonbrief. Global mutirão. La COP 30 ha visto i paesi concordare su una nuova decisione "global mutirão", un testo che chiede di triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035, una nuova "Missione di Belém" per aumentare le azioni collettive volte a ridurre le emissioni e, con grande delusione di molti paesi, nessuna nuova roadmap sulla transizione dai combustibili fossili e sull'inversione della deforestazione. La prima bozza del testo "global mutirão" è apparsa nelle prime ore di martedì mattina. Mutirão è una parola portoghese, che ha origine nella lingua indigena Tupi-Guarani, e si riferisce a persone che lavorano insieme per un obiettivo comune con uno spirito comunitario, qualcosa che la presidenza della COP 30 era desiderosa di sottolineare. La presidenza ha anche voluto chiarire che il testo mutirão non era un cover text. Tuttavia, come un testo di copertura, cercava di riunire questioni importanti che non erano all'ordine del giorno formale con obiettivi negoziati, proponendosi come l'accordo chiave della COP 30. La prima bozza riuniva le quattro grandi questioni: finanza, commercio, trasparenza e ambizione. Per la maggior parte degli elementi principali, la prima bozza elencava diverse opzioni. Ad esempio, il paragrafo 56 elencava tre diverse opzioni su come i paesi sviluppati potessero triplicare la spesa per i finanziamenti per l'adattamento, mentre il paragrafo 35 proponeva tre opzioni per una possibile roadmap per il phaseout dei combustibili fossili, inclusa una che diceva semplicemente nessun testo. La prima bozza ha suscitato l'immediata condanna di un gruppo di 82 nazioni che volevano un appello più ambizioso e certo per una roadmap sui combustibili fossili inclusa nel mutirão. Tuttavia, la CEO della COP 30, Ana Toni, ha dichiarato in una conferenza stampa, che una grande maggioranza dei gruppi di paesi consultati (non si sa quali) considerava una tabella di marcia sui combustibili fossili una linea rossa. Lula è tornato a Belém mercoledì e, mentre le speranze di un accordo rapido svanivano, ha trascorso il suo tempo conducendo incontri bilaterali con delegazioni di diversi gruppi negoziali con la speranza di far progredire i negoziati. Nessun nuovo testo mutirão è emerso entro giovedì, il giorno dell’incendio. Venerdì mattina presto, è emersa una seconda versione a lungo attesa della bozza. Questo testo chiedeva sforzi per triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2030, una Missione di Belém per gli 1,5 °C guidata dalla presidenza e un acceleratore di attuazione volontario, oltre a una serie di dialoghi sul commercio. Non faceva riferimento a una tabella di marcia sui combustibili fossili, scatenando la condanna di paesi e attivisti. Con i diversi paesi ancora distanti anni luce sulle questioni chiave del mutirão, i negoziati si sono protratti per tutto venerdì. A un certo punto del pomeriggio di venerdì, i colloqui erano degenerati nel caos, quando la presidenza ha cercato di spostare le discussioni in tre riunioni informali su commercio, finanziamenti per l'adattamento e ambizione. Molti paesi si sono opposti alla mancanza di un punto sui combustibili fossili, mentre l'Arabia Saudita ha affermato che l'idea di prendere di mira il settore energetico era fuori discussione. Dopo una pausa, i colloqui sono ripresi, con la formazione di quattro gruppi, incluso uno sui combustibili fossili. Alle 10:00, la presidenza ha inviato un'e-mail ai delegati dicendo che un nuovo testo sarebbe stato presto diffuso e che sarebbe seguita una plenaria di chiusura. È emersa la versione finale del testo mutirão, che chiedeva un triplicamento dei finanziamenti per l'adattamento, ma senza una chiara linea di base e con una data obiettivo fissata al 2035, cinque anni dopo rispetto a una bozza precedente. Non conteneva ovviamente la tabella di marcia sui combustibili fossili. Nella plenaria di chiusura, il testo è stato adottato senza obiezioni. Dopo un breve applauso, Corrêa do Lago ha riconosciuto che alcuni paesi speravano in risultati più ambiziosi dal testo. Ha poi annunciato che la presidenza della COP 30 avrebbe presentato alla prossima COP due roadmap, sulla transizione dai combustibili fossili e sulla deforestazione. Ha aggiunto che la tabella di marcia sui combustibili fossili sarà guidata da una prossima conferenza sulla transizione dai combustibili fossili ospitata da Colombia e Paesi Bassi ad aprile. Corrêa do Lago ha poi rapidamente battuto il martelletto su altri testi chiave della COP 30, inclusi quelli sull'obiettivo globale sull'adattamento (GGA) e sui programmi di lavoro per la transizione giusta e la mitigazione. Tuttavia, Panama, sostenuta da altri paesi latinoamericani e dall'UE, è intervenuta in plenaria per dire che il suo tentativo di sollevare un intervento prima che il GGA venisse approvato con il martelletto è stato ignorato dalla presidenza brasiliana. Anche la Colombia è intervenuta, per dire che il suo tentativo di sollevare una bandiera prima dell'adozione del programma di lavoro sulla mitigazione è stato anch'esso ignorato. La plenaria di chiusura è stata sospesa per un'ora per consentire ulteriori consultazioni tra la presidenza e le parti insoddisfatte del processo di adozione. Dopo la ripresa della plenaria, i delegati hanno trascorso altre sei ore a battere il martelletto su altri testi, inclusi quelli sull'uguaglianza di genere e una serie di elementi più tecnici, oltre ad ascoltare ulteriori dichiarazioni da paesi e osservatori. In totale, sono state adottate più di 150 pagine di testo decisionale attraverso i vari organismi riuniti alla COP. La COP 30, l'undicesima conferenza sul clima più lunga della storia, si è ufficialmente conclusa alle 20:44 di sabato sera. Adattamento. Uno dei maggiori risultati negoziati alla COP 30 ha riguardato gli sforzi per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, con Corrêa do Lago che l'ha definita la "COP dell'adattamento". In particolare, i negoziatori avrebbero dovuto concordare un elenco di indicatori che consentissero ai paesi di misurare i loro progressi nell'ambito dell'obiettivo globale sull'adattamento (GGA). Alla fine, alla COP 30 è stata concordata una serie di indicatori molto ridotta. Tuttavia, le richieste di un nuovo obiettivo per i finanziamenti per l'adattamento hanno rapidamente catalizzato l'attenzione. Il documento finale chiede ai paesi di triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035. Nel 2021, alla COP 26 a Glasgow, era stato concordato l'obiettivo di raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento portandoli a 40 miliardi di $ entro il 2025. Tuttavia, un recente rapporto dell'UNEP ha rilevato che, nel 2023, le nazioni sviluppate hanno fornito solo 26 miliardi in finanziamenti per l'adattamento alle nazioni in via di sviluppo. Questo segna un calo rispetto ai 28 miliardi del 2022 ed è ben al di sotto del fabbisogno annuale di finanziamenti per l'adattamento per queste nazioni, che l'UNEP stima in circa 310 miliardi all'anno fino al 2035. L'UNEP ha avvertito che, in base alle tendenze attuali, le nazioni sviluppate non raggiungeranno l'obiettivo di Glasgow. Un negoziato su un nuovo obiettivo per i finanziamenti per l'adattamento per gli anni successivi al 2025 non era incluso nell'agenda della COP30. Nel corso della prima settimana, un nuovo obiettivo è stato proposto nelle discussioni sul GGA, sui Piani Nazionali di Adattamento (NAP) e sul Fondo per l'Adattamento. La proposta degli LDC di triplicare i finanziamenti portandoli a 120 miliardi entro il 2030 è stata sostenuta dagli Stati insulari di piccole dimensioni, dal gruppo africano, dal Grupo Sur e altri. Ha incontrato opposizione principalmente da parte dei paesi sviluppati dell'UE e dell'Environmental Integrity Group (EIG), che ha osservato che il riferimento a tale obiettivo sarebbe stato interpretato come un tentativo di rinegoziare il nuovo obiettivo quantificato collettivo (NCQG). Non avendo una sede ufficiale, la questione di un nuovo obiettivo per i finanziamenti per l'adattamento è stata affrontata nell'ambito delle consultazioni della presidenza. La prima bozza del mutirão includeva una serie di opzioni, tra cui quella di stabilire un obiettivo per i paesi sviluppati di triplicare la loro fornitura di finanziamenti per l'adattamento, con opzioni per far sì che ciò provenisse esclusivamente da fonti pubbliche e scadenze proposte del 2030 o 2035. C'erano anche proposte meno ambiziose, che si limitavano a esortare un triplicamento dei finanziamenti per l'adattamento o a riconoscerela necessità di un aumento generale di tali finanziamenti. Contemporaneamente, sono iniziati i negoziati sul GGA. Negli ultimi due anni, gli esperti hanno lavorato per trasformare un elenco di 10.000 potenziali indicatori per il monitoraggio dell'adattamento in soli 100. Il gruppo africano ha proposto un processo biennale di affinamento politico prima dell'adozione degli indicatori. I paesi latinoamericani ne hanno chiesto l'adozione alla COP 30. Il gruppo africano ha sostenuto che gli indicatori erano invasivi e che i paesi africani necessitavano di maggiori finanziamenti per adottarli. Gli indicatori non dovrebbero violare la sovranità dei paesi, chiedendo ai paesi di cambiare le loro leggi, le loro strategie. Si osservava che 48 degli indicatori richiedevano sostegno e finanziamenti per essere attuabili. Altre aree di disaccordo all'interno del GGA includevano visioni opposte su argomenti come la roadmap di adattamento di Baku e il concetto di adattamento trasformativo. Tuttavia, il principale punto critico sono rimasti gli indicatori. La questione è stata complicata dalla continua divisione all'interno dei gruppi di paesi in via di sviluppo. I ministri latinoamericani hanno sottolineato la necessità dei finanziamenti per l'adattamento, ma hanno continuato a enfatizzare la necessità di adottare gli indicatori. Le bozze dei testi negoziali hanno mostrato pochi progressi nella seconda settimana, con il numero di parti del testo non decise e tra parentesi che è raddoppiato arrivando a quasi 100. L'elefante massiccio nella stanza è la mancanza di finanziamenti per l'adattamento. Mentre i negoziati si avvicinavano alla conclusione, un nuovo testo ha apparentemente trovato un punto d'incontro. Includeva 59 dei potenziali 100 indicatori, sottolineando che essi non creano nuovi obblighi o impegni finanziari. Il testo conteneva anche piani per una visione Belém-Addis biennale per affinare ulteriormente gli indicatori. Questo testo è stato rilasciato lo stesso giorno e includeva un linguaggio indebolito che si limitava a chiedere sforzi per triplicare i finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2025 entro il 2030. Il testo finale del GGA ha mantenuto l'adozione dei 59 indicatori e il programma biennale volto a sviluppare una guida per rendere operativi gli indicatori di adattamento di Belém. Il GGA è stato approvato con il martelletto durante la plenaria di chiusura, ma ha incontrato una risposta mista. Sebbene ci siano stati applausi nella sala, i paesi latinoamericani, l'UE, il Canada e altri hanno espresso critiche e hanno detto di non poter sostenere il risultato. Panama, ad esempio, lo ha definito una bozza affrettata e ha sostenuto che non è così che si raggiunge un obiettivo globale sull'adattamento. La dichiarazione è stata accolta da un applauso. Dopo una pausa della plenaria, Corrêa do Lago ha richiesto un ulteriore lavoro sul GGA ai colloqui sul clima di Bonn nel giugno 2026. Il testo del GGA ha mantenuto un placeholder per un obiettivo di finanziamento per l'adattamento all'interno del testo finale del mutirão. In definitiva, questo ha riaffermato l'obiettivo di raddoppio di Glasgow, chiesto sforzi per triplicare i finanziamenti per l'adattamento e esortato i paesi sviluppati ad aumentare la traiettoria delle loro forniture finanziarie, rispecchiando in gran parte la bozza precedente. Tuttavia, la scadenza per l'obiettivo di triplicazione è stata posticipata di cinque anni e il riferimento al 2025 come linea di base per questo obiettivo è stato rimosso. Oltre al GGA e ai finanziamenti per l'adattamento, i negoziati sui NAP hanno fatto seguito a sessioni tese alla COP 29 e a Bonn, entrambe concluse senza accordo. All'interno dei negoziati sui NAP, la finanza è il problema principale. Alla fine, nella plenaria di chiusura della COP 30 è stata adottata, una decisione segnando la fine dello stallo nei negoziati sui NAP. Inoltre, si sono svolti negoziati nell'ambito del Fondo per l'Adattamento, con i paesi che hanno annunciato impegni finanziari verso il proprio obiettivo annuale di $300 milioni. Il testo finale nota con preoccupazione che l'obiettivo non è stato raggiunto e sottolinea l'urgenza di aumentare le risorse finanziarie. Mercati del carbonio ai sensi dell'Art.6 di Parigi. I mercati del carbonio, in particolare quelli relativi alle foreste, erano attesi come una priorità chiave per la presidenza brasiliana alla COP 30. Il 7 novembre, la presidenza brasiliana ha lanciato una coalizione globale sui compliance carbon markets, approvata da 18 paesi. La coalizione si propone di esplorare opzioni per promuovere l'interoperabilità dei mercati del carbonio di conformità nel lungo termine. Sebbene i riferimenti espliciti alla natura e ai progetti di crediting del carbonio basati sulla natura siano stati rimossi in una seconda bozza emessa a fine giornata del 15 novembre, il testo chiedeva comunque all'organo SB di di valutare la fattibilità economica dei suoi standard. Alla fine il punto è caduto perché molti paesi hanno visto lo sforzo di fornire indicazioni dettagliate all'organo di supervisione come un tentativo di microgestire il suo lavoro, creando incertezza per gli attori del mercato. La decisione finale sull'Articolo 6.4 ha concesso ai progetti di crediti di carbonio registrati sotto il CDM una proroga di sei mesi, fino a giugno 2026, per passare al nuovo mercato del carbonio dell'Accordo di Parigi. Ciò potrebbe consentire a ulteriori 760 milioni. La decisione richiede che il SB rafforzi i suoi processi di consultazione informando, contattando e includendo i popoli indigeni, le comunità locali e altri che non possono facilmente partecipare al complesso meccanismo. Sebbene ci siano meno regole che disciplinano lo scambio di carbonio da paese a paese ai sensi dell'Articolo 6.2, i paesi avrebbero dovuto presentare Rapporti iniziali di questi accordi bilaterali di scambio di carbonio per la revisione da parte di esperti tecnici prima della COP 30. Le prime sei revisioni sono state completate prima del summit. Una questione particolare in discussione alla COP 30 era il fatto che, fino ad oggi, tutti gli scambi ai sensi dell'Articolo 6.2 finora sono stati segnalati con incoerenze durante la revisione degli esperti. La decisione della COP 30 sull'Articolo 6.2 si limita a prendere atto di queste incoerenze e esorta i paesi a risolverle. Chiede inoltre ai revisori di spiegare chiaramente eventuali problemi riscontrati e come risolverli. Misure commerciali unilaterali. Dopo diversi tentativi falliti di inserire all'ordine del giorno delle precedenti COP le "misure commerciali unilaterali" legate al clima, come la regolamentazione sulla deforestazione e il CBAM dell'UE, la questione è stata affrontata a Belém nell'ambito delle discussioni guidate dalla presidenza e si è riflessa nel risultato chiave del summit. Questa decisione istituisce tre dialoghi annuali sul commercio, che si terranno durante le riunioni intersessionali di Bonn nel 2026, 2027 e 2028. Inoltre, riafferma che le misure climatiche, incluse quelle unilaterali, non dovrebbero costituire restrizioni commerciali che siano arbitrarie o discriminatorie. Questa è la prima menzione in assoluto delle misure commerciali in una decisione generale di una COP. Sebbene la questione del commercio abbia ricevuto una significativa attenzione negli ultimi summit, non è nuova per il regime climatico delle Nazioni Unite. A Belém, la questione di tali misure era stata sollevata ancora una volta dalla Bolivia per conto dei Paesi in via di sviluppo con idee affini (LMDCs, un gruppo che include Cina, India e altri). La domenica, a metà della COP, la presidenza ha pubblicato un riassunto delle sue consultazioni, contenente cinque opzioni per una decisione sulle misure commerciali, inclusi dialoghi, tavole rotonde o la creazione di una piattaforma. L'UE sostiene fermamente il modo in cui le misure commerciali supportano l'azione per il clima, ma i paesi in via di sviluppo hanno reali preoccupazioni su come tali misure si manifesterebbero. Accanto alle discussioni sotto la presidenza, queste misure hanno continuato a emergere in diversi flussi negoziali, inclusi quelli sulla transizione giusta (just transition), sulle misure di risposta e sulla tecnologia. La decisione finale sul programma di lavoro per la transizione giusta ha rimosso tutti i riferimenti al commercio, sebbene abbia riconosciuto il ruolo dei piccoli agricoltori e della produzione alimentare. L'agricoltura è il secondo più grande inquinatore dopo i combustibili fossili e il più grande datore di lavoro nel mondo. Dobbiamo passare a un'agricoltura più sostenibile, ma deve accadere in modo equo per proteggere posti di lavoro, mezzi di sussistenza, famiglie, comunità e la sicurezza alimentare globale.
Molti osservatori temevano che i biocarburanti sarebbero stati inclusi nelle negoziazioni o nella decisione generale della COP 30.
Anche la decisione finale del mutirão globale non ha avuto alcuna menzione esplicita di biocarburanti, combustibili di transizione o combustibili sostenibili. Riforma della COP. Si sta manifestando un crescente interesse per la riforma del processo climatico delle Nazioni Unite. Era per la prima volta nell'agenda della COP a Belém, sotto il titolo, "disposizioni per le riunioni intergovernative", lettere dalla presidenza. Le idee sul tavolo includevano il limitare le dimensioni delle delegazioni nazionali, così come il far decadere i punti all'ordine del giorno e limitare il numero di nuove questioni che potevano essere aggiunte. In definitiva, la COP 30 ha adottato conclusioni minime che si limitano a invitare le parti a perseguire l'efficienza nella considerazione dei punti all'ordine del giorno durante le sessioni. I colloqui continueranno l'anno prossimo. Il risultato è stato un un nulla di fatto. Normalmente gli Arrangements for Intergovernmental Meetings non sono un punto all'ordine del giorno delle COP e non sembrava che le parti fossero desiderose di discuterne molto a Belém. La necessità di rendere il regime climatico delle Nazioni Unite più efficiente era stata riconosciuta dalla presidenza brasiliana della COP in una lettera pubblicata a maggio, che affermava: riconoscendo le crescenti richieste di cambiamento alle COP, la presidenza della COP 30 invita tutte le parti a riflettere sul futuro del processo stesso. Qualsiasi speranza che ciò potesse portare a una riforma sostanziale è stata rapidamente stroncata dalla prima bozza di testo sul punto all'ordine del giorno, pubblicata il 13 novembre. Questa contava solo cinque paragrafi, prendendo atto degli sforzi del segretariato per raggruppare gli eventi sul mandato e concordando di continuare le discussioni a Bonn nel giugno 2026. Una bozza più lunga è apparsa il 14 novembre, richiamando e riaffermando il testo concordato nella riunione di Bonn a giugno. Questa è stata poi formalmente adottata alla fine della prima settimana di colloqui. Tuttavia, ha poca attinenza con le idee più sostanziali proposte dagli esperti, che andavano dall'introduzione del voto alle restrizioni su quali paesi possono ospitare la COP. Il processo è diventato sempre più caotico e proceduralmente complesso. Una manciata di punti è stata all'ordine del giorno della COP per anni, ma è essenzialmente dormiente. Altri sono ripetuti per ragioni politiche. Altri ancora, come a Belém, ricevono tutta l'attenzione politica, pur essendo esclusi dall'agenda. L'agenda ha urgente bisogno di essere snellita e razionalizzata. Alcuni osservatori speravano che un punto separato all'ordine del giorno, chiamato "cooperazione con altre organizzazioni internazionali", potesse portare a un nuovo risultato sostanziale che unisse più strettamente il lavoro delle tre convenzioni di Rio su cambiamento climatico, perdita di biodiversità e desertificazione. Scienziati e politici hanno chiesto per anni che il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità vengano affrontati in modo più coeso. Dopo essersi impegnata a fare della COP 30 una COP della natura, la presidenza ha tenuto consultazioni su questo punto, tentando di raccogliere sostegno per un nuovo risultato ambizioso.
2025, SABATO 15 NOVEMBRE. LE PLENARIE DI STOCKTAKING DI MIDTERM CONCLUDONO LA PRIMA SETTIMANA DELLA COP 30
Durante la sessione plenaria di chiusura degli Organi Sussidiari, quelli che hanno gestito il Summit di Bonn del giugno di quest'anno con limitata fortuna, molti gruppi e paesi hanno preso la parola per esprimere la loro delusione riguardo allo stato dei negoziati su tecnologia, ricerca e questioni di genere. La Presidenza ha illustrato il piano per la prosecuzione dei negoziati durante la seconda settimana della conferenza. La sera, il Presidente della COP 30, Corrêa do Lago, ha informato i delegati sul percorso da seguire durante la seconda settimana della conferenza. Ha spiegato che i negoziati continueranno su tre livelli che si influenzeranno reciprocamente: consultazioni ministeriali su questioni che beneficeranno di orientamento politico; ulteriori lavori tecnici sulle questioni ancora irrisolte, da concludersi martedì 18 novembre; continuazione delle consultazioni della Presidenza, anche sulla cooperazione con altre organizzazioni internazionali. Le consultazioni ministeriali da lunedì si svolgeranno sui seguenti temi co-facilitate da coppie di ministri: questioni relative al Global Stocktake; obiettivo Globale sull’Adattamento; finanza; mitigazione; transizione giusta; tecnologia; questioni di genere. Le consultazioni della Presidenza continueranno riguardo a: gli NDC, i rapporti biennali di trasparenza (BTRs), l’Articolo 9.1 dell’Accordo di Parigi (obbligo di finanziamento da parte dei paesi sviluppati) e le misure commerciali restrittive unilaterali (UTMs). Le opinioni espresse finora saranno raccolte in una nota di sintesi per guidare le discussioni successive. Il Presidente Corrêa do Lago ha annunciato che un “Mutirão” a livello ministeriale e di capi delegazione si riunirà all’inizio della seconda settimana, dopo aver ascoltato i report dei co-facilitatori ministeriali. Le Parti hanno approvato questo approccio. La Coalizione per le Foreste Pluviali ha sottolineato la necessità di lasciare Belém con una tabella di marcia per arrivare alla deforestazione zero entro il 2030.
La COP 30 è arrivata al giro di boa con la maggior parte delle questioni chiave ancora da definire, dopo una plenaria di verifica di sabato sera che ha offerto ai delegati molti spunti di riflessione durante la pausa domenicale. La prima settimana si è svolta in relativa calma poiché la presidenza brasiliana ha indirizzato le questioni più spinose, non formalmente presenti in agenda, verso ampie consultazioni. Le discussioni sull’aumento dell’ambizione nella riduzione delle emissioni, sulla fornitura di finanziamenti da parte dei paesi sviluppati, sulle misure commerciali unilaterali e sulla rendicontazione nazionale delle azioni per il clima sono state aperte, costruttive e trasparenti, secondo il Presidente. Egli preparerà una nota riassuntiva sulle discussioni relative a tali temi, che sarà pubblicata domenica, come base affinché i paesi possano proseguire il lavoro. Ma mentre i ministri atterrano nella città amazzonica senza testi di decisione da discutere in molte aree, i lavori tecnici rallenteranno e i confronti politici si intensificheranno. Invocando lo spirito brasiliano del “Mutirão”, simbolo di unione e collaborazione, Corrêa do Lago ha delineato il suo piano per la settimana successiva, modellato su tre percorsi paralleli: la roadmap per l’abbandono dei combustibili fossili, l’Obiettivo Globale di Adattamento, con l’obiettivo di lasciare Belém con un accordo sugli indicatori, e il Programma di lavoro per la transizione giusta. Coppie di ministri provenienti da paesi sviluppati e in via di sviluppo inizieranno a raccogliere posizioni sugli aspetti che richiedono accordi politici ad alto livello, tra cui riduzione delle emissioni di gas serra, finanziamento e adattamento. Dovranno riferire alla presidenza entro martedì, permettendo ai paesi di capire quanto sono vicini – ad un esito positivo. Nel frattempo, le consultazioni della presidenza sui quattro temi privi di un canale negoziale proseguiranno, mentre il presidente della COP convocherà all’inizio della prossima settimana un incontro “Mutirão” con ministri e capi delegazione per integrare i vari risultati. I negoziati sull’adattamento, tema di elezione della COP 30, restano ostaggio del finanziamento. Finalizzare una lista di 100 indicatori per misurare i progressi nell’adattamento agli eventi meteorologici estremi e all’innalzamento dei mari, dopo due anni di lavoro, poteva sembrare facile tanto che la presidenza sperava di chiudere il dossier nella prima settimana dei negoziati. Così non è stato: i gruppi negoziali di Africa, America Latina e paesi arabi hanno deciso di utilizzare la discussione sugli indicatori per l’Obiettivo Globale di Adattamento come piattaforma per esercitare pressione sui governi ricchi per avere maggiori finanziamenti. All’inizio della settimana, come si è detto, hanno chiesto due anni in più per discutere anche come pagare l’adattamento. A metà dei negoziati, con i ministri in arrivo lunedì, la versione più recente del testo era piena di parentesi, segno di totale dissenso. Il testo contiene due opzioni principali: una che non prevede alcun riferimento al tema e l’altra che riflette la proposta dei paesi in via di sviluppo per un nuovo obiettivo quantificato pari a 120 - 150 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 (proposta LDC e Arabi). L’attuale obiettivo, fissato alla COP 26 nel 2021, prevedeva che i governi donatori fornissero almeno 40 miliardi di dollari l’anno entro il 2025. Ma, con i tagli ai bilanci della cooperazione in molti paesi, le stime attuali indicano un probabile esborso di appena 25 miliardi, un enorme divario rispetto alle necessità. Alcune parti del testo pubblicato oggi mirano anche a evitare che ai paesi in via di sviluppo venga richiesto di finanziare le proprie misure di adattamento e affermano che gli indicatori sarebbero volontari e lasciati alla scelta dei paesi, per evitare che venga imposto a tutti cosa fare per rendere più resilienti agricoltura, acqua, salute e infrastrutture. il testo, infine, riconosce l’urgenza di fornire finanziamenti pubblici aggiuntivi e certi. Fonti credibili indicano che potrebbe essere più probabile destinare all’adattamento una quota dei 300 miliardi di dollari all’anno che i paesi sviluppati si sono impegnati a mobilitare per le nazioni più povere entro il 2035 nell’ambito dell’NCQG. Oggi il presidente della COP 30 ha ospitato un attesissimo evento informale sulla Baku-Belém Roadmap, il documento che dà continuità alla COP finanziaria dell’anno scorso e che dovrebbe tracciare la strada per arrivare a 1.300 miliardi di dollari l’anno per i paesi in via di sviluppo entro il 2035. Ma la sessione non ha fornito orientamenti chiari e ha sollevato timori che la roadmap possa essere accantonata a Belém. Sette relatori, tra cui il capo dell’ONU per il clima Simon Stiell, hanno letto dichiarazioni nella prima metà della sessione, ribadendo i punti principali della roadmap: un elenco di misure che potrebbe contribuire a raggiungere i 1.300 miliardi. Alcuni governi, Kenya, Cina, Colombia, hanno espresso feedback per lo più positivi chiedendo che il tema venga discusso formalmente nel regime Onu sul clima.Alla domanda se la roadmap potrebbe essere accolta formalmente alla COP, Corrêa do Lago ha risposto che un movimento sta iniziando, ma vedremo come reagiranno i paesi ma pensa che sia improbabile che ciò accada a Belém.
Sabato la
presidenza della COP 30 ha lanciato un forum per i paesi per discutere clima
e commercio, visto dal Brasile come una delle sue iniziative di punta al di
fuori dei negoziati formali. Il commercio è stato uno dei temi più
controversi al vertice di Belém, dopo che uno dei gruppi dei paesi emergenti
aveva chiesto di inserire un punto in agenda sul tema all’inizio dei
negoziati. Dopo una settimana di consultazioni, i paesi non hanno ancora trovato un accordo sul fatto di aprire una discussione su questo tema alla COP 30 e le prime reazioni all’iniziativa brasiliana sono state tiepide. Un negoziatore dell’UE ha dichiarato mercoledì che il blocco non vuole affrontare controversie commerciali alla COP, poiché queste competono al WTO. Non possiamo infine fare a meno di testimoniare la marcia per il clima che torna nelle strade della COP. Popoli indigeni, attivisti climatici, organizzazioni femministe, clown, frati, ciclisti e molti altri si sono riuniti oggi per la Grande Marcia dei Popoli, una manifestazione per chiedere giustizia climatica e protezione dei territori. Migliaia di persone hanno partecipato alla prima marcia fuori dalla sede della COP in quattro anni; le ultime tre conferenze si erano infatti svolte in Egitto, Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian, contesti in cui le proteste di piazza nei pressi del summit non erano autorizzate. Durante la prima settimana della COP, sono stati soprattutto i popoli indigeni a guidare le due maggiori azioni della società civile: una flottiglia sul delta del Rio delle Amazzoni mercoledì e un blocco dell’ingresso del centro congressi venerdì. Uno dei leader indigeni ha dichiarato che erano lì per combattere e per portare la rivendicazione di resistenza e lotta del popolo, ribadendo la loro richiesta di un faccia a faccia con il presidente Lula. 2025, VENERDì 14 NOVEMBRE. SI CONCLUDE LA PRIMA SETTIMANA DELLA COP 30. POCA LUCE IN FONDO AL TUNNEL Al di là della cronaca del negoziato climatico a COP 30, assicurata da numerose iniziative mediatiche spesso di ottima qualità, giunti alla metà del percorso ci sembra opportuno tirare le fila delle tematiche che stanno occupando spazio a Belém. Ad oggi i punti fermi sono davvero pochi rispetto alla lista della spesa ed alla stessa Agenda enunciata dal Presidente brasiliano iunedì ed appare pertanto piuttosto inutile lanciarsi in congetture sugli esiti di questa COP che si presentano non solo incerti, ma che sembrano relegati in uno spazio marginale, ai confini del mondo, lontano dall'attenzione dei big della politica impegnati in altre faccende, come a farsi la guerra l'un l'altro. è il mondo ad essere a rischio, non solo il clima. Comunque andiamo per punti:
Adattamento. Uno dei risultati chiave attesi della COP 30 su mandato di Bonn è un accordo su una lista di 100 indicatori da utilizzare per misurare i progressi verso l’obiettivo globale sull’adattamento (GGA). Dopo due anni di lavoro degli esperti, i negoziati sono iniziati con una lista proposta ridotta da quasi 10.000 indicatori possibili. Nonostante l’attenzione al GGA da parte della presidenza della COP 30 e di altri Paesi, sono rapidamente emerse divisioni sulla tempistica per l’adozione degli indicatori. In particolare, il Gruppo Africano ha richiesto un programma di lavoro di due anni per perfezionare ulteriormente la lista, mentre altre parti stanno spingendo affinché gli indicatori vengano adottati a Belém come previsto. Mercoledì è stata pubblicata una nota informale che raccoglieva elementi per una bozza di decisione. In modo significativo, per la prima volta sotto il GGA, è incluso un invito ai paesi sviluppati ad almeno triplicare il loro contributo collettivo ai finanziamenti per l’adattamento entro il 2030, con un obiettivo di 120 miliardi di dollari. Ciò riecheggia un obiettivo originariamente proposto dal gruppo negoziale dei Paesi meno sviluppati (LDC), sostenuto dal Gruppo Africano, dal Gruppo Arabo e dai Paesi di AILAC (Associazione dell’America Latina e dei Caraibi). Mitigazione e transizione giusta. Nel corso dell’ultimo anno, gruppi della società civile hanno richiesto l’istituzione di un meccanismo per attuare i principi della transizione giusta. Questa richiesta ha guadagnato slancio mercoledì nelle negoziazioni del programma di lavoro sulla transizione giusta (JTWP), quando il G77 e la Cina hanno chiesto lo sviluppo di un Belém Action Mechanism (BAM). Cile, l’Alleanza degli Stati Insulari (AOSIS), l’India e altri paesi in via di sviluppo hanno sostenuto il meccanismo. Tuttavia, Norvegia, Regno Unito, Australia e Giappone si sono opposti. Sono riemersi anche altri punti di lunga data, tra cui le misure commerciali unilaterali, come il CBAM europeo, i riferimenti ai combustibili fossili e l’allineamento agli obiettivi globali sulle temperature. Nel programma di lavoro sulla mitigazione (MWP), i negoziatori stanno cercando di costruire sui due dialoghi tenuti quest’anno. I temi principali alla COP 30 sono i collegamenti tra l’MWP e il global stocktake e il futuro del programma stesso. Sono riemerse vecchie divisioni, incentrate soprattutto sul mandato dell’MWP e sul potenziale sviluppo di una piattaforma digitale come parte della sua continuazione. Il risultato storico del primo global stocktake, concordato alla COP 28 di Dubai, invitava tutti i paesi a contribuire a una transizione dai combustibili fossili e ad implementare un dialogo sulle ambizioni. Due anni dopo, i paesi sono ancora in stallo su cosa tale dialogo debba discutere. Molti vogliono che copra tutte le parti dello stocktake, inclusa la transizione energetica, mentre altri vogliono che si concentri esclusivamente sulla finanza climatica. Vi sono anche disaccordi sul fatto che il dialogo dovrebbe avere risultati concreti, incluso un processo formale per continuare a discutere le questioni sollevate. Dopo il fallimento nel raggiungere un accordo alla COP 29, l’ultima bozza di testo mostra che le parti sono altrettanto distanti a Belém, a quasi metà del vertice. Finanza. La finanza climatica per i paesi in via di sviluppo non occupa una posizione di rilievo nei negoziati formali della COP 30. Tuttavia, come dimostrato dal suo ruolo nelle discussioni sull’adattamento e nella disputa sull’agenda, la finanza ha ancora il potenziale di far deragliare i lavori. Prima della conferenza, le presidenze della COP 30 e della COP 29 hanno pubblicato la loro roadmap da Baku a Belém, che esplora come la finanza potrebbe essere aumentata a 1,3 trilioni di dollari entro il 2035. Il LSE londinese di Stern ha pubblicato una nuova analisi che dimostra la fattibilità di questo obiettivo, facendo leva sulla finanza privata. Tuttavia, senza una collocazione nei negoziati di Belém, non è chiaro come o se la roadmap sarà stata portata avanti dai governi oltre la COP 30. L'Europa perde la leadership climatica (Natalie Tocci su The Guardian). L’azione per il clima è da tempo una politica di punta dell’Europa. Tuttavia, alla COP 30, la leadership europea è in discussione. Dalla deforestazione al mercato delle emissioni, politiche vitali vengono annacquate in nome della competitività. Ma l’Europa sta rinunciando ad un ruolo di guida, per quanto problematico, per confondersi nella palude reazionaria del trumpismo dilagante. Gli inglesi lo chiamano gentilmente backlash, noi più prosaicamente ritirata. Dieci anni fa, a Parigi, la situazione era molto diversa, quando alla COP 21 fu raggiunto lo storico accordo basato su un’intesa tra Stati Uniti e Cina, una condizione difficile da replicare oggi, e la sua ambizione fu rafforzata dall’azione congiunta dell’Europa con un ampio gruppo di paesi del sud globale. L’accordo di Parigi ha spianato la strada al Green Deal europeo nel 2019, che ha sancito per legge l’obiettivo della neutralità climatica nell’UE entro il 2050 e ha introdotto il primo piano completo al mondo per raggiungerla, con un solido insieme di misure di prezzo, regolamentazione e finanziamento. Nell’immaginare la transizione, i politici europei non ne hanno considerato sufficientemente l’impatto sociale. Il correttivo che va sotto il nome di just transition, per coinvolgere e compensare chi rischiava di perdere ci sono stati, ma non sono bastati. Regioni e lavoratori dipendenti da industrie ad alta intensità di carbonio, gruppi sociali svantaggiati e paesi più poveri colpiti in modo sproporzionato dalla crisi climatica e dalle conseguenze economiche della transizione sono stati tutti penalizzati. Le critiche a queste mancanze sono legittime, ma l’UE ha indubbiamente supportato i propri impegni con azioni concrete, investendo seriamente nel progetto. Oggi in Brasile, però, la leadership climatica europea potrebbe sgretolarsi. Non solo perché gli Stati Uniti si sono nuovamente ritirati dall’accordo di Parigi e l’amministrazione Trump sta attivamente cercando di minare gli impegni degli altri paesi, compresi quelli europei. Né solo perché paesi del sud globale, dall’India e l’Indonesia agli Stati del Golfo e alla Turchia, si rifiutano di sacrificare la crescita per il clima, attribuendo la crisi al nord globale, soprattutto all’Europa. È anche perché la stessa Europa, travolta da un’ondata revisionista di greenlash, rischia di scomparire dall’azione. Dopo la pandemia di Covid-19 e l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, la narrativa dominante sul potenziale del Green Deal di stimolare investimenti e innovazione è cambiata. Gruppi nazionalisti e dell’estrema destra hanno guadagnato terreno trasformando il Green Deal in un mostro ideologico: un progetto guidato da liberali e sinistra, consapevolmente o inconsapevolmente in combutta con la Cina, per indebolire l’Europa. Queste forze, insieme alle potenti lobby dei combustibili fossili e dell’agricoltura, hanno ripetutamente sostenuto che il Green Deal avrebbe causato la deindustrializzazione dell’Europa e permesso a Pechino di sfruttare nuove interdipendenze verdi. Come osservava Hannah Arendt decenni fa, più le falsità si ripetono, più si radicano come convinzioni. Le critiche al Green Deal sono passate dalle frange politiche al centrodestra, amplificate anche da pressioni esterne dell’amministrazione Trump e dei principali esportatori di gas come il Qatar. Washington e Doha, ad esempio, hanno minacciato di trattenere le forniture di gas a meno che l’UE non attenuasse o abbandonasse i propri requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità. L’Europa si è allineata ritirando di fatto ogni obbligazione EGR per le imprese ed il Green Deal è praticamente scomparso dal vocabolario europeo, sostituito da parole come competitività, neutralità tecnologica e semplificazione burocratica, insieme al riarmo. Gli ottimisti speravano che fosse solo uno spostamento retorico per rendere la politica climatica più accettabile sul piano politico. Purtroppo la realtà è più preoccupante. L’UE ha significativamente indebolito i suoi piani di riduzione delle emissioni per il 2040, inserendo clausole di revisione che permettono passi indietro in caso di rallentamento economico e affidandosi a crediti di carbonio scientificamente discutibili. Non sorprende che governi di estrema destra in Italia e nell’Europa centrale e orientale abbiano guidato questa ritirata. L’UE ha inoltre rinviato l’estensione del mercato delle emissioni a case e trasporti, così come l’attuazione del regolamento sulla deforestazione. E potrebbe ancora rimandare o indebolire il divieto previsto per il 2035 sulle nuove auto con motori a combustione. Altri arretramenti sono attesi sotto la copertura della semplificazione burocratica, con il suo pacchetto omnibus che rischia di minare la sostenibilità, la due diligence e, tra le altre misure, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM). Gran parte di ciò equivale a un autogol dell’Europa che rimarrà senza una visione di futuro, prona ad un tipo di archeocapitalismo, indebitata all’acquisto di armi americane ed avendo perduto categorie chiave della modernità come l’innovazione e la ricerca scientifica e, pericolosamente, incrinando la sua tradizione di welfare, diritti e democrazia. Quando l’UE si è fatta promotrice della leadership climatica, non lo ha fatto solo per idealismo, ma anche perché, come continente povero di combustibili fossili, la sua sicurezza energetica e la sua prosperità dipendevano da essa. Ed è proprio per questo che la Cina, anch’essa importatrice di idrocarburi, ha seguito l’esempio europeo nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie verdi. Eppure, mentre la Cina accelera, l’Europa rallenta, dimenticando che i principi climatici e la prosperità economica sono interdipendenti. Il paradosso si approfondisce mentre l’Europa mina la propria reputazione globale come leader climatico. Per esempio, questo dietrofront fa apparire la Cina più virtuosa di quanto non sia. I paesi europei si erano impegnati a ridurre le emissioni tra il 66,3% e il 72,5% entro il 2035 in vista della COP 30. Ma l’annacquamento dell’ultimo minuto di questi obiettivi getta un’ombra sull’ambizione, soprattutto a confronto con la Cina, che punta solo a una riduzione del 10% nel prossimo decennio. L’introduzione prevista per il 1° gennaio 2026 del CBAM sui prodotti importati ha già spinto paesi come Brasile, Turchia e Giappone a introdurre o rafforzare sistemi nazionali di prezzi del carbonio per evitare il dazio europeo. Ma invece di celebrare questo successo come prova dell’efficacia del meccanismo, l’UE ora potrebbe tornare sui suoi passi, cedendo alla pressione per un suo radicale ridimensionamento prima della piena attuazione. L’Europa è nettamente davanti alla Cina e agli Stati Uniti sul fronte dei finanziamenti per il clima. Tuttavia, il deterioramento delle relazioni con il sud globale significa che l’Europa ha meno forza combinata per fare pressione sulla Cina affinché rispetti le proprie responsabilità. Ci consola che, nel quadro geopolitico internazionale desolante, nel pieno trionfo del capitalismo oil&gas, che proprio in questi giorni celebra i suoi fasti lontano da Belém, non siamo i peggiori. L’Europa resta in prima linea nel percorso verso le emissioni nette zero in termini di obiettivi, politiche e finanziamenti. Ma agire nel proprio interesse significa continuare a guidare l’avanzamento del clima e ritrovare una comunanza politica con il sud globale.
Ma i critici avvertono che il ritiro degli Stati Uniti lascia campo libero nei negoziati sul clima, in particolare mentre la Cina, oggi principale emettitore di gas serra al mondo, espande rapidamente le sue industrie delle rinnovabili e dei veicoli elettrici. Il governatore della California Gavin Newsom all’inizio della settimana ha pubblicamente dichiarato che l’America è finita, competitivamente parlando, se non si sveglia e non capisce cosa sta facendo nelle catene di approvvigionamento, nel modo in cui sta dominando la manifattura, nel modo in cui sta occupando ogni spazio. A differenza degli anni precedenti, quando la Cina aveva un padiglione modesto con appena qualche posto a sedere per panel tecnici e accademici, il suo padiglione alla COP 30 occupa uno spazio di primo piano vicino all’ingresso, accanto al paese ospitante, il Brasile. Onoriamo l’eredità e realizziamo la visione di Parigi guidati da un futuro condiviso, ha dichiarato giovedì il vicepresidente di CATL, il più grande produttore di batterie al mondo. Avanziamo insieme nella cooperazione climatica e costruiamo un mondo pulito e bello. Il colosso delle batterie fornisce già un terzo delle batterie ai produttori di veicoli elettrici, tra cui Tesla, Ford e Volkswagen. È la prima volta che CATL ospita un evento a una COP, con l’obiettivo di raggiungere governi e ONG. Poco prima, il viceministro cinese dell’ecologia aveva dichiarato a una platea gremita che lo status della Cina come principale produttore mondiale di energia rinnovabile porta benefici ai paesi, in particolare nel sud globale. Il colosso cinese dei veicoli elettrici BYD ha introdotto una flotta di veicoli ibridi plug-in compatibili con biocarburanti prodotti nel suo stabilimento di Bahia, in Brasile, per l’utilizzo alla COP 30. Sia il presidente della COP André Corrêa do Lago sia l’amministratrice delegata Ana de Toni hanno elogiato il ruolo della Cina come leader nella tecnologia per l’energia pulita. La Cina ha dimostrato leadership non solo portando avanti la propria rivoluzione energetica, ma grazie alla sua capacità produttiva su larga scala possiamo ora acquistare tecnologie low-carbon a prezzi competitivi. La Cina è determinata non solo a continuare a essere un leader stabile nell’Accordo di Parigi, rafforzando la governance climatica, ma anche a intraprendere azioni molto concrete per sostenere altri paesi. La Cina sta svolgendo un ruolo più sottile dietro le quinte dei negoziati, colmando il vuoto lasciato dagli Stati Uniti. Poco alla volta, la Cina sta agendo come garante del regime climatico. La Cina ha avuto un ruolo decisivo nel raggiungere un accordo sull’agenda della COP 30 prima ancora che iniziassero i negoziati, mentre negli anni precedenti i suoi diplomatici non intervenivano se non in presenza di questioni chiave per loro. La Cina è in grado di unire gli ampi interessi del mondo in via di sviluppo, dalle grandi economie emergenti come i BRICS alle piccole nazioni in via di sviluppo. Ha collaborato strettamente con le controparti cinesi in quattro accordi bilaterali sul clima, tra cui quello che sbloccò l’intesa di Parigi. Tendono a essere molto duri e assumere posizioni difficili come facevano gli Stati Uniti, ma poi diventano pragmatici verso la fine, dice Reuters. Devono trovare un risultato che nessuno ritenga tanto negativo da bloccarlo. Ci sono opinioni scettiche che dicono che se la Cina avesse voluto, avrebbe fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni più ambizioso di quanto annunciato a settembre che prevede un taglio delle emissioni di almeno il 7% rispetto al picco entro il 2035. La Cina aveva fissato un obiettivo di riduzione del 18% delle emissioni per il periodo 2021-2025, ma entro la fine di quest’anno avrà raggiunto solo circa il 12%. Ciò significa che dovrebbe realizzare una riduzione di circa il 22-24% nei cinque anni successivi per rispettare il suo principale impegno climatico per il 2030: una diminuzione dell’intensità di carbonio del 65% rispetto ai livelli del 2005. Che le emissioni diminuiscano o meno quest’anno ha un’importanza altamente simbolica. Avendo promesso di raggiungere il picco delle emissioni prima del 2030, i responsabili politici cinesi hanno lasciato aperta la specifica del momento esatto del picco. Il nuovo obiettivo cinese sulle emissioni di gas a effetto serra per il 2035, annunciato da Xi a settembre, è stato fissato come una riduzione del 7-10% rispetto a un livello di picco non definito, rendendo evidente che i decisori politici stanno ancora pianificando un picco tardivo, appena prima del 2030. 2025, 10 NOVEMBRE, LUNEDì. SI APRE LA 30th CONFERENZA DELLE PARTI SUL CLIMA
È tempo di infliggere una nuova sconfitta ai negazionisti. Oggi, dopo accese discussioni, le nazioni hanno finalmente concordato un ordine del giorno per la conferenza. Il presidente brasiliano spera che i paesi prendano in considerazione l’elaborazione di un piano per abbandonare i combustibili fossili, ma è la Presidenza, André Corrêa do Lago, a chiedersi come si potrà mai fare. Tra i possibili temi in agenda c’è anche la definizione di come i paesi ridurranno ulteriormente le emissioni, dato che i piani attuali sono ancora insufficienti per limitare il riscaldamento estremo. Entro la mattina di lunedì, 106 governi avevano presentato nuovi piani climatici. I delegati vogliono inoltre affrontare il tema delle emissioni agricole, un argomento spesso trascurato, vista la difficoltà di modificare le pratiche agricole e zootecniche fondamentali per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza di molti paesi. Tra i paesi in via di sviluppo c’è un movimento per promuovere soluzioni e tecnologie che possano rendere l’agricoltura più efficiente e meno inquinante. La presidenza brasiliana è riuscita a evitare uno scontro imminente su una serie di nuove proposte di agenda avanzate da alcuni paesi prima della conferenza. La maggior parte delle questioni controverse è stata rinviata a consultazioni, con un aggiornamento previsto per mercoledì. Ci si promette perfino di affrontare la questione se i paesi possano ancora lavorare per mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. I gruppi in prima linea contro il cambiamento climatico, tra cui i paesi dei Caraibi e del Pacifico, hanno insistito affinché i negoziati affrontino l’obiettivo a lungo termine di limitare l’aumento della temperatura. Non era chiaro se i paesi avrebbero cercato di negoziare un accordo finale entro la fine dell’evento, un obiettivo difficile in un anno di politica globale tesa e di sforzi statunitensi per ostacolare la transizione dai combustibili fossili. Alcuni, tra cui il Brasile, hanno suggerito di concentrarsi su obiettivi minori che non richiedano il consenso generale, come la lotta alla deforestazione, dopo anni di COP conclusesi con promesse ambiziose ma in gran parte non mantenute. Nelle ultime settimane persino l’ONU ha ammesso che superare la soglia di 1,5 °C è inevitabile. Oggi, le Nazioni Unite hanno pubblicato nuovi calcoli aggiornati che mostrano come gli impegni nazionali ridurrebbero le emissioni globali di gas serra previste per il 2035 del 12% rispetto ai livelli del 2019, due punti percentuali in più rispetto al mese scorso, prima dell’arrivo dei nuovi NDC. Un’analisi aggiornata dell’ONU di tutti i piani climatici nazionali finora presentati mostra alcuni progressi nella direzione giusta, con una riduzione prevista del 12% entro il 2035 rispetto al 2019. Ma gli scienziati avvertono che la diminuzione dovrebbe essere di circa il 60% per avere buone probabilità di limitare il riscaldamento a 1,5 °C. Andremo quindi in overshoot. Il nuovo rapporto ONU tiene conto anche degli impegni più recenti, compresi quelli di Cina ed Unione Europea, ma resta ancora molto al di sotto della riduzione del 60% necessaria per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C soglia oltre la quale il cambiamento climatico produrrebbe impatti molto più gravi. I negoziatori sono stati raggiunti dai leader indigeni, arrivati domenica in barca dopo aver percorso circa 3.000 chilometri dalle Ande. Chiedono di avere un ruolo maggiore nella gestione dei loro territori, mentre il cambiamento climatico si aggrava e industrie come miniere, disboscamento e trivellazioni petrolifere penetrano sempre più in profondità nelle foreste. “Vogliamo assicurarci che smettano di fare promesse e comincino a proteggere, perché noi, come popoli indigeni, siamo quelli che soffrono di più gli impatti del cambiamento climatico”, ha dichiarato Pablo Inuma Flores, leader indigeno del Perù. Il tema dell’adattamento sta diventando sempre più importante, poiché i paesi non riescono a ridurre abbastanza le emissioni che riscaldano il pianeta da evitare gli episodi meteorologici estremi sempre più frequenti. Un rapporto delle Nazioni Unite del mese scorso ha stimato che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno fino a 310 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 per prepararsi. Non è chiaro da dove arriveranno tali fondi. Dieci tra le principali banche di sviluppo mondiali, sotto pressione per liberare più risorse a favore dell’azione climatica, hanno dichiarato oggi che continueranno a sostenere questa necessità. Germania e Spagna hanno promesso 100 milioni di dollari a un altro programma, i Fondi d’Investimento Climatico (CIF), che finanziano progetti per rafforzare la resilienza climatica nei paesi in via di sviluppo. La direttrice dell’organizzazione ha elogiato il Brasile per aver posto il tema come una priorità della COP 30, dopo anni in cui l’adattamento era scivolato in basso nell’agenda dei vertici ONU sul clima. Attirare finanziamenti privati per questa causa resta difficile: i progetti di resilienza offrono rendimenti economici più bassi rispetto a quelli per le energie rinnovabili, che contribuiscono direttamente alla riduzione delle emissioni. Un rapporto di settembre ha affermato che il finanziamento pubblico resta cruciale. Attualmente, i fondi privati costituiscono solo il 3% dei finanziamenti per l’adattamento, ma questa quota potrebbe salire al 15% con politiche adeguate. Abbiamo bisogno di risorse che fluiscano direttamente verso i partner locali e le comunità che già guidano la risposta ricostruendo case,ripristinando i mezzi di sussistenza e proteggendo i sistemi sanitari dagli shock climatici. 2025, 6 - 7 NOVEMBRE. a belem si incontrano i leader mondiali che vogliono ancora dare impulso alla lotta contro i cambiamenti climatici
L’incontro, tenutosi prima dell’avvio ufficiale dei negoziati di lunedì 9, è iniziato con un richiamo al problema che i leader sono lì per affrontare: l’aumento delle temperature globali. Con gli ultimi tre anni i più caldi mai registrati, il segretario generale dell’ONU António Guterres ha dichiarato che il superamento del limite di 1,5 °C è ormai inevitabile, ma può essere reso il più piccolo, breve e sicuro possibile. Il rapporto annuale dell’UNEP sul gap delle emissioni ha avvertito che l’aumento della temperatura globale potrebbe arrivare a 2,8 °C in questo secolo, se verranno attuate solo le politiche attuali. L’aumento potrebbe essere limitato a 2,5°C se gli impegni nazionali incondizionati venissero pienamente rispettati, o a 2,3°C se anche gli impegni condizionati a sostegno finanziario venissero attuati. La traiettoria del riscaldamento globale del pianeta è ora inferiore di 0,3° C rispetto a un anno fa… il che significa che i nuovi piani annunciati quest’anno hanno fatto poco per cambiare la situazione e parte di questo progresso sarà annullata quando il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi entrerà in vigore. Guterres ha poi attaccato i governi che sovvenzionano i combustibili fossili e le aziende che producono e vendono carbone, petrolio e gas, accusandoli di ingannare il pubblico e ostacolare i progressi. Troppe aziende stanno ottenendo profitti record dalla devastazione climatica, spendendo miliardi per fare lobbying, ingannare il pubblico e ostacolare i progressi. Ogni anno, i paesi spendono circa 1.000 miliardi di dollari in sussidi ai combustibili fossili. I leader, ha detto Guterres, hanno due opzioni chiare: Possiamo scegliere di guidare, oppure essere guidati verso la rovina. Alcuni dei colpevoli, in particolare gli Stati Uniti, non erano presenti per ascoltarlo ed hanno lasciato spazio ai presidenti latinoamericani, in particolare quelli di Cile e Colombia, per criticare la negazione del cambiamento climatico da parte di Trump, nemico giurato delle politiche green. Ciononostante, si è percepita una determinazione tenace ad affrontare il lavoro da fare, con numerosi appelli a raddoppiare gli sforzi per potenziare le energie rinnovabili, proteggere le foreste e aiutare le comunità vulnerabili ad adattarsi. Come tutto ciò verrà finanziato è per ora una domanda senza risposta. Alcuni osservatori hanno sottolineato che l’assenza degli Stati Uniti dalla COP 30 potrebbe consentire ai paesi di discutere azioni concrete senza che un solo attore ne domini l’esito: senza gli Stati Uniti presenti, si potrà forse finalmente assistere a un vero dialogo multilaterale. Eppure, i sondaggi mostrano che una schiacciante maggioranza della popolazione, l’89% a livello globale, è preoccupata per la crisi climatica e chiede azioni concrete. E non sono mancate vittorie inaspettate per i politici favorevoli al clima: Mark Carney in Canada, Anthony Albanese in Australia e Claudia Sheinbaum, una scienziata del clima, in Messico. In alcuni contesti, in certe regioni e in determinati settori, fortunatamente, l’azione climatica sta progredendo in modi impensabili solo un decennio fa. Le energie rinnovabili, guidate dal solare e dall’eolico, hanno rappresentato oltre il 90% della nuova capacità energetica installata a livello mondiale lo scorso anno, e il solare è ormai l’elettricità più economica della storia. Gli investimenti globali nell’energia pulita dovrebbero raggiungere quest’anno i 2.200 miliardi di dollari, circa il doppio rispetto alla spesa per i combustibili fossili. Lo scorso anno, un’auto nuova su cinque venduta nel mondo era elettrica, e oggi i posti di lavoro nel settore dell’energia rinnovabile superano quelli nei combustibili fossili. Al centro della COP 30 ci saranno due domande cruciali: cosa può fare il mondo per fermare l’accelerazione del riscaldamento globale? E si può agire abbastanza in fretta da evitare una catastrofe irreversibile? Il presidente brasiliano Lula si è compiaciuto di essere riuscito a portare i leader in Amazzonia (in verità pochi) nonostante le difficoltà logistiche e ha colto l’occasione per promuovere la transizione dai combustibili fossili e l’inversione della deforestazione, tutti temi inevasi per i quali è necessaria una nuova visione. In questa chiave il Brasile lancia una nuova iniziativa per la protezione delle foreste: il Tropical Forest Forever Facility (TFFF), definita un’iniziativa senza precedenti, che vuole sfruttare i mercati finanziari per generare rendimenti da destinare ai paesi affinché mantengano in piedi le loro foreste pluviali, destinando almeno il 20% delle risorse alle comunità indigene e locali. La Norvegia ha dato seguito alle parole con i fatti, impegnandosi a fornire 3 miliardi di dollari in prestiti nei prossimi dieci anni al TFFF, a determinate condizioni. la Francia ha indicato un possibile contributo di 500 milioni di euro, e altri impegni sono attesi nelle prossime settimane. Dopo gli impegni di 1 miliardo ciascuno da parte di Brasile e Indonesia, ma con il rifiuto del Regno Unito rimane ancora molto da fare per raggiungere l’obiettivo del fondo di 25 miliardi di dollari di capitale pubblico iniziale. Con questi fondi, l’obiettivo è raccogliere ulteriori 100 miliardi dagli investitori. La presidenza brasiliana della COP ha pubblicato una roadmap da Baku a Belém, che illustra come il finanziamento climatico per i paesi in via di sviluppo potrebbe essere aumentato fino a 1,3 trilioni di dollari all’anno entro il 2035. La roadmap è stata pubblicata in vista dei negoziati climatici delle Nazioni Unite, ma non sarà discussa formalmente come parte delle trattative. Tuttavia, l’impegno di Lula si scontra con le pressioni economiche. Ha recentemente concesso alla compagnia petrolifera statale Petrobras una licenza per esplorare giacimenti di petrolio vicino alla foce del Rio delle Amazzoni, una decisione che gli ambientalisti ritengono rischi di provocare disastri. Lula ha respinto le accuse di ipocrisia dicendo che non vuole essere un leader ambientalista ne l’ha mai preteso. L'Europa. L’Europa arriva alla COP 30 con un obiettivo interno di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.come recita il nuovo NDC europeo, presentato alla ministeriale di Belèm, che punta a ridurre le emissioni al 2035 tra il 66,25% e il 72,5%. Le scappatoie nel nuovo obiettivo climatico provvisorio dell’UE aumentano il rischio di non raggiungere il traguardo della neutralità climatica entro il 2050. Mercoledì, prima di partire, i 27 governi hanno concordato di ridurre le loro emissioni di gas serra fino al 90% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, ma hanno riempito la legislazione di opzioni di compensazione e clausole di revisione che potrebbero indebolire significativamente l’obiettivo. Anche se il compromesso mantiene l’obiettivo del 90%, fissa i tagli alle emissioni interne dell’UE all’85%, e consente al blocco di coprire la parte restante pagando altri paesi per ridurre l’inquinamento attraverso l’acquisto dei cosiddetti crediti di carbonio. I governi hanno inoltre introdotto una clausola che richiede all’UE di rivedere l’obiettivo ogni cinque anni alla luce delle condizioni economiche o dei prezzi elevati dell’energia, con la possibilità per gli Stati membri di acquistare ulteriori crediti di carbonio. Il consiglio, tuttavia, ha criticato l’uso dei crediti, avvertendo che esternalizzare i tagli alle emissioni distoglierebbe investimenti necessari verso l’estero e rallenterebbe il ritmo interno della decarbonizzazione. Le politiche climatiche non possono diventare il capro espiatorio dei problemi economici dell’UE. L’economia europea ha certamente un problema di competitività, in particolare nei settori ad alte emissioni e nell’industria automobilistica. Ma la politica climatica viene molto spesso accusata della mancanza di una visione industriale. Le preoccupazioni riguardo alla traiettoria attuale del mercato del carbonio, che richiede alle aziende di raggiungere la neutralità climatica prima del 2040, sono valide, ma le richieste di abolire il prezzo della CO₂ dell’UE, avanzate da taluni, sono inutili e pericolose. Fondamentalmente, i messaggi secondo cui la politica climatica è un lusso e che ora è il momento di tornare alle cose importanti sono assurdi. Gli impatti climatici sono reali. E si tratta di una questione che riguarda la sicurezza e la prosperità a lungo termine. In questo quadro la tassa sul carbonio alle frontiere dell’UE (CBAM) sta diventando un punto di tensione alla COP 30. Diversi paesi, tra cui Cina, India e Bolivia, stanno prendendo di mira la tassa sul carbonio alle frontiere nella loro richiesta di includere le misure commerciali unilaterali nell’agenda. Tra i presenti per l'EU, nonostante l’assenza annunciata degli Stati Uniti, si sono fatti notare il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il premier britannico Keir Starmer accompagnato dal principe William, e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per la prima volta dal suo insediamento a Palazzo Chigi, non era presente. A sostituirla c’era il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli esteri Antonio Tajani, che perlomeno parla l'inglese. Tra i non EU, il segretario britannico all’Energia Ed Miliband scrive chegli sforzi multilaterali per affrontare il cambiamento climatico possono ancora dare risultati per il Regno Unito e per il mondo. Nonostante tutte le sue frustrazioni, il vertice COP sul clima è uno dei migliori esempi di multilateralismo di successo che il mondo abbia mai conosciuto. Il processo COP è profondamente caotico e ha molti difetti, ma la COP ha agito come un meccanismo globale di stimolo ed è dubbio” che avremmo raggiunto tali progressi senza questo processo multilaterale. Oggi, alcune forze in Europa vogliono abbandonare la causa dell’azione climatica e minare la cooperazione globale per affrontarla. Sarebbe profondamente irresponsabile. L’Italia arriva a mani vuote, senza riuscire a confermare come ed entro quando erogherà le promesse fatte a Dubai nel 2023 di fornire 100 milioni di euro per il Fondo perdite e danni e 300 milioni di dollari per il Fondo verde per il clima. L’Italia arriva a Belém in una posizione strategica ma complessa. Da un lato, Roma ha rilanciato la cooperazione climatica nel Mediterraneo, con impegni sul contrasto alla desertificazione e sul sostegno ai Paesi africani colpiti dagli impatti del clima. Dall’altro, il Paese resta tra i principali importatori europei di gas e fatica a imprimere un’accelerazione decisiva sulle rinnovabili, rallentate da burocrazia e ritardi infrastrutturali. L’Italia, come membro del G7, dovrebbe svolgere un ruolo importante nel vertice. Sul tavolo, c'è la partecipazione al fondo globale per le perdite e i danni (Loss and Damage Fund), destinato ai Paesi più vulnerabili. La strategia italiana a Belém si concentrerebbe su un forte impulso alle politiche di adattamento, attraverso strumenti improbabili come il Fondo Italiano per il Clima e il Piano Mattei; un’attenzione particolare ai biocarburanti (due approcci per glissare sulla transizione); e un contributo alla finanza climatica globale per ora annunciato dal MASE, si dice, usando i fondi destinati allo sviluppo. Utile qui ricordare, ancora una volta, che tutti gli studi mostrano che non c’è abbastanza terra per raggiungere l’obiettivo globale di emissioni nette zero utilizzando solo soluzioni basate sulla natura di cui fanno parte i biocarburanti. 2025, COP30_11. IL RUOLO DELL'ENERGIA E LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'UAE CONSENSUS Triplicare le fonti di energia rinnovabile e raddoppiare l'efficienza energetica
I nuovi dati 2025 dell'IRENA mostrano che l'obiettivo 2030 di triplicare le fonti rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica, rimane a portata di mano. Triplicare la capacità installata di generazione di energia rinnovabile entro il 2030 è un pilastro fondamentale del Consensus UAE e un passaggio cruciale per mantenere l'obiettivo degli 1,5 °C a portata di mano. Triplicare la capacità di energia rinnovabile fino a raggiungere gli 11,2 terawatt (TW) nel 2030 richiede un'aggiunta media di $1.122 gigawatt (GW) ogni anno tra il 2025 e il 2030, il che rappresenta un tasso di crescita annuo composto del 16.6%. Nel 2024 sono stati aggiunti 581,9 GW di nuova capacità di energia rinnovabile, pari a un tasso di crescita annuale del 15,1%, un aumento dello 0,7% rispetto al 14,4% di crescita registrato nel 2023. Nonostante questo progresso, la crescita della capacità è ancora al di sotto della traiettoria necessaria per conseguire l'obiettivo al 2030. Sebbene la tendenza sia positiva di anno in anno, se il tasso di crescita visto nel 2024 dovesse continuare per i restanti anni del decennio, entro il 2030 verrebbero installati solo 10.3 TW di di energia rinnovabile, mancando l'obiettivo di 0.9 TW (il 7,7%). Per contestualizzare questa carenza, è più della capacità totale installata di energia rinnovabile alla fine del 2024 in Nord, Centro e Sud America, e nei Caraibi, messi insieme. Dato che le aggiunte di capacità sia nel 2023 che nel 2024 sono state inferiori al tasso di crescita richiesto del 16,1%, la capacità rinnovabile deve ora espandersi ancora più rapidamente (del 16.6% all'anno) nei rimanenti sei anni del decennio per fornire 6,7 TW di energia rinnovabile installata. Raggiungere questa capacità farebbe sì che le tecnologie rinnovabili variabili superino la capacità totale dei combustibili fossili entro il 2030, rappresentando il 61% (solare fotovoltaico [PV] 41% ed eolico 20%) della capacità totale installata, in aumento rispetto al 31% del 2024. Mentre le aggiunte di solare fotovoltaico (PV) sono sulla buona strada per soddisfare, o persino superare, la loro quota, non sono sufficientemente rapide da compensare completamente la mancanza di crescita raggiunta dalle altre tecnologie rinnovabili. Le attuali aggiunte di capacità eolica sono inadeguate per raggiungere l'obiettivo di 3 TW di capacità eolica complessiva. La capacità media annua aggiunta per l’eolica onshore deve più che raddoppiare, e l'eolico offshore deve aumentare di sei volte nel periodo 2025–2030. La diffusione geografica delle rinnovabili rimane altamente irregolare, con Asia, Europa e Nord America che rappresentano l'85,4% della capacità di energia rinnovabile installata alla fine del 2024. Il restante 14,6% è condiviso da Africa, America Centrale e Caraibi, Eurasia, Medio Oriente, Oceania e Sud America.
Il Gruppo dei Paesi del G20 rappresenta circa l'87% della capacità rinnovabile installata a livello globale, il che richiede che la capacità rinnovabile del G20 aumenti di 2,4 volte per raggiungere 9,7 TW entro il 2030, rispetto ai 4 TW del 2024. Ciò equivale ad aggiunte medie di capacità di circa 957 GW ogni anno fino alla fine del decennio, rispetto ai 563,2 GW aggiunti nel 2024. Mentre l'Unione Europea sta compiendo forti progressi nell'espansione dell'energia rinnovabile, rimane anch'essa fuori rotta. L'UE-27 ha aggiunto 72,3 GW di nuova capacità di energia rinnovabile nel 2024, portando il totale installato a 702,6 GW, un aumento di poco più dell'11% rispetto al 2023. La capacità rinnovabile deve raggiungere 1.247 GW entro il 2030, un aumento di quasi l'80% rispetto ai livelli attuali. Il ruolo dello stoccaggio. Le tecnologie di stoccaggio energetico diventeranno essenziali per bilanciare la domanda e l'offerta di elettricità e fornire servizi ancillari. Nello Scenario 1,5 °C di IRENA, la crescita di tre volte dell’energia elettrica rinnovabile deve essere sostenuto da un aumento da due a cinque volte della capacità di stoccaggio a batteria entro il 2030, passando da un totale di 164 GW nel 2024 a una cifra compresa tra 360 GW e 900 GW entro il 2030. Nel frattempo, la capacità globale installata di stoccaggio idroelettrico a pompaggio dovrebbe aumentare di quasi 170 GW, raggiungendo una capacità cumulativa di 320 GW entro il 2030, fornendo le necessarie riserve a breve termine e la flessibilità di sistema a lungo termine. Ciò richiederebbe un tasso medio di costruzione di 28 GW ogni anno fino al 2030 3,4 volte la capacità aggiunta nel 2024. Altre forme di stoccaggio, come le batterie a flusso e lo stoccaggio termico, vengono ora implementate su scala e saranno anch'esse necessarie per integrare le batterie e l'idroelettrico a pompaggio.
I tassi globali di ristrutturazione degli edifici rimangono a livelli molto bassi, circa l'1% dello stock edilizio all'anno, ben al di sotto di quelli necessari per raggiungere gli obiettivi climatici. La ristrutturazione dello stock edilizio esistente è fondamentale per realizzare risparmi energetici significativi, poiché gli edifici rappresentano una grande quota del consumo energetico globale. Il tasso di elettrificazione dei settori di utilizzo finale deve aumentare dal 23% nel 2023 al 30% entro il 2030 per rimanere in linea con il percorso di Parigi. L'aumento richiesto è 1-7% nei trasporti, 36-52% negli edifici e 27-31% nell'industria. L'elettrificazione accelerata è la misura chiave del miglioramento dell'efficienza. Si consideri che le pompe di calore elettriche sono in genere il 300-400% più efficienti delle caldaie tradizionali, e i veicoli elettrici [EV] sono il 60-80% più efficienti dei motori a combustione interna, e che al contempo le emissioni si abbattono con l'uso di energia generata da fonti rinnovabili. I veicoli elettrici hanno rappresentato un record del 21% delle vendite globali di auto nuove nel 2024, segnando la loro quota più alta fino ad oggi, spinta da una maggiore concorrenza, dal sostegno politico e dai progressi tecnologici. Anche le vendite di veicoli elettrici pesanti (HDV) sono aumentate, sebbene più lentamente, ma è necessaria una adozione accelerata e infrastrutture di ricarica più estese. Le quote di mercato dei veicoli elettrici stanno crescendo rapidamente, soprattutto nel segmento delle autovetture (26% delle nuove vendite) e nel segmento dei veicoli a due e tre ruote (45%). Anche gli autobus elettrici mostrano una forte adozione al 42%, mentre i furgoni e i camion elettrici sono ancora in ritardo, rappresentando ciascuno meno dell'8% delle vendite globali di veicoli nuovi. Lo UAE Consensus negli NDC in vista della COP 30. Dai dati UNFCCC, al 1° ottobre 2025, solo 60 Paesi hanno presentato il loro terzo ciclo di Contributi NDC 3.0 all'Accordo di Parigi e rappresentano solo il 20% delle emissioni globali. Di questi, 21 NDC menzionano esplicitamente l'obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Nel primo ciclo di NDC presentati dopo l'adozione dell'Accordo di Parigi, il 45% delle Parti dell'UNFCCC ha incluso l'energia rinnovabile nei propri obiettivi, ma si è concentrato principalmente su obiettivi ampi per la riduzione delle emissioni di gas serra e l'aumento della sicurezza energetica. Nel secondo ciclo di NDC, presentati tra il 2020 e il 2022, la percentuale di Parti che hanno incluso l'energia rinnovabile è aumentata a quasi il 60%, migliorando anche la qualità dei loro obiettivi di energia rinnovabile, rendendoli specifici e misurabili. Ad oggi, 183 delle 195 Parti menzionano l'energia rinnovabile nei loro NDC attivi, 2.0 o 3.0. 151 Paesi hanno obiettivi quantificabili: 119 erano specificamente per il settore energetico elettrico, 44 di questi espressi sotto forma di capacità assoluta (MW) o produzione (MWh). 44 obiettivi erano espressi in termini di quota di energia rinnovabile; 31 obiettivi utilizzavano una combinazione di target assoluti e basati sulla quota. Tra i 75 che si rapportano alla quota 13 si impegnano a raggiungere una quota di energia rinnovabile inferiore al 24%; 28 si impegnano a una quota compresa tra il 25% e il 59%; 22 si impegnano a quote comprese tra il 60% e l'89%; 12 si impegnano a quote comprese tra il 90% e il 100% e sono in maggior parte piccoli Stati insulari SIDS, che hanno una minima impronta di emissioni. La quantificazione da parte dell'IRENA degli obiettivi di energia rinnovabile negli NDC presentati al 1° ottobre 2025 rileva che i target esistenti mirano ad aumentare collettivamente la capacità totale di energia rinnovabile a circa 5,8 TW entro il 2030, rispetto ai 4,4 TW attuali. Le 60 Parti che hanno presentato gli NDC 3.0 si sono impegnate a installare 244 GW di capacità entro il 2035, rispetto ai 132 GW nei loro NDC 2.0. Ciò rappresenta un aumento aggiuntivo di 112 GW, sebbene distribuito su un orizzonte temporale più lungo. Attualmente, queste 60 Parti costituiscono 833 GW di capacità, il 19% della capacità globale. Nel complesso, gli obiettivi degli NDC necessitano collettivamente di quasi raddoppiare per raggiungere l'obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030.
2025, COP30_10. CHI PAGA I DANNI ARRECATI DAL CLIMA CHE CAMBIA AI PAESI CHE NON HANNO EMISSIONI STORICHE A LORO CARICO? L'uragano Melissa, con venti misurati dalle sonde fino a 450 km/h, ha causato danni che il governo giamaicano stima in 22 miliardi di dollari a petto di un PIL nazionale di 20. è solo l'episodio più recente che alimenta il dibattito su perdite e danni (Loss and Damage) rin merito ai danni causati dai cambiamenti climatici e come dovrebbero essere risarciti. Quando il livello del mare si alza o si verificano eventi meteorologici estremi, alcune persone e Paesi vengono colpiti più duramente di altri. Sperimentano situazioni che devasterebbero chiunque, come: perdita di case, carenza di cibo e acqua, ambienti distrutti, perdita di cultura o decessi. Spesso, le persone o i Paesi che hanno fatto meno per causare i cambiamenti climatici subiscono gli impatti peggiori.
Le perdite e i danni "evitabili" si riferiscono agli impatti che sono stati o avrebbero potuto essere evitati o minimizzati attraverso la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento e/o misure di riduzione del rischio di catastrofi (DRR) (ad esempio, la costruzione di un argine marittimo). Le perdite e i danni sono considerati "non evitati" quando ci sono vincoli di risorse e capacità (ad esempio, la mancanza di fondi che limita la capacità delle piccple isole (SIDS) di costruire argini marittimi). Le perdite e i danni "inevitabili" si riferiscono a quegli impatti che vanno oltre le misure di adattamento e mitigazione esistenti (ad esempio, gli impatti irreversibili dello scioglimento dei ghiacciai e dell'innalzamento del livello del mare). Nei SIDS è stato registrato un totale di 10.113 decessi associati a eventi legati al clima. I cambiamenti climatici sono responsabili del 39% (41,3 miliardi di dollari) delle perdite economiche totali registrate. Le tempeste contribuiscono per il 77% e le inondazioni per il 23% al totale delle perdite e dei danni attribuibili. Ogni anno, una media di 1,7 miliardi di dollari di perdite economiche possono essere attribuite ai cambiamenti climatici nei SIDS (2000-2022). Ciò costituisce lo 0,8% del PIL collettivo dei SIDS (il picco è stato del 9,5% del PIL nel 2004). I SIDS subiscono un numero di decessi attribuibili ai cambiamenti climatici cinque volte superiore rispetto ai Paesi non-SIDS a basso e medio-basso reddito. Anche le perdite economiche medie annuali attribuite in percentuale del PIL sono significativamente più alte nei SIDS che nei Paesi non-SIDS. Si stima che un uragano medio nei Caraibi riduca la crescita del reddito a livello locale dell'1,5% e il PIL a livello nazionale di circa lo 0,7%-0,8% nell'anno dell'impatto. Sulla base dell'analisi delle misurazioni satellitari dell'intensità della luce notturna, l'attività economica nel Pacifico meridionale si è ridotta fino all'11% nei primi mesi nelle isole colpite dal Ciclone Pam nel 2015. Gli eventi meteorologici estremi possono causare effetti negativi a breve termine sulla bilancia commerciale, come le riduzioni delle esportazioni. Nei Caraibi orientali, si stima che gli uragani riducano le esportazioni di merci del 20% nei primi quattro mesi. Tuttavia, gli eventi gravi possono portare a effetti più ampi e prolungati. "Perdite e danni" è un termine spesso usato nei dibattiti su come e chi dovrebbe pagare per gli impatti climatici in tutto il mondo. L'idea che gli inquinatori debbano essere ritenuti responsabili per il danno causato dai cambiamenti climatici è una parte importante della giustizia ambientale. Non possiamo considerare gli impatti climatici solo in termini finanziari, ma molti Paesi e comunità stanno affrontando devastazioni che non hanno causato e per loro il sostegno finanziario è vitale. I finanziamenti per le perdite e i danni dovrebbero essere separati dagli sforzi di adattamento e mitigazione, che pure devono essere intensificati. Per gli eventi a insorgenza rapida, affrontare le perdite e i danni potrebbe significare rispondere rapidamente per evitare ulteriori perdite, recuperare e ripristinare i servizi critici e ricostruire meglio. "Perdite e danni" può sembrare un gergo strano per gli impatti climatici. Fu usato per la prima volta in un negoziato sul clima delle Nazioni Unite nel 1991 per parlare specificamente del supporto finanziario per gli impatti climatici. Da allora, è stato adottato nelle conversazioni pubbliche sui cambiamenti climatici. La COP 27 di Sharm el Sheik ha aggiunto per la prima volta all'ordine del giorno la questione delle perdite e danni climatici (vedi il resoconto in questa pagina), istituendo un fondo per rimediare all'impatto dei disastri climatici, finanziato dai Paesi industrializzati più responsabili di tali fenomeni. Dopo decenni di pressioni da parte delle nazioni insulari vulnerabili al clima, la creazione del fondo è servita come riconoscimento ufficiale della fondamentale ingiustizia per cui i Paesi che contribuiscono meno al cambiamento climatico spesso sopportano il peso maggiore della sua distruzione. Tuttavia, questo primo passo provvisorio non ha fornito chiare linee guida su come il fondo sarebbe stato finanziato. Nonostante sia il primo emettitore netto di gas serra, la Cina ha dichiarato che non contribuirà al fondo, spiegando di essere una nazione in via di sviluppo. Gli Stati Uniti di Biden, il più grande emettitore storico, hanno resistito all'idea di un risarcimento per perdite e danni sia alla COP 26 che alla COP 27 prima che l'Unione Europea accettasse finalmente un fondo con delle limitazioni. Il Fondo per le Perdite e i Danni è ancora in fase di costituzione presso la Banca Mondiale e, finora, nessun fondo bilaterale o multilaterale ha istituito uno sportello di finanziamento specializzato per rispondere alle perdite e ai danni legati al clima. Ciononostante, esistono fondi e strumenti finanziari per la gestione dei rischi climatici che vengono utilizzati dai SIDS. Il Governo delle Fiji dispone di un fondo di contingenza in corso per il rischio di catastrofi, al quale sono stati assegnati 1 milione di dollari figiani (F$) nei bilanci 2022/23 e 2023/24 (circa 451.000 dollari USA 2023). Inoltre, il bilancio nazionale 2023/24 include un contingente per il recupero immediato e il ripristino dei servizi nei settori chiave. L'indebitamento a condizioni agevolate, in particolare tramite l'ADB e la Banca Mondiale, è stato uno strumento importante per consentire i lavori di riabilitazione e la ricostruzione post-disastro a più lungo termine. Tuttavia, il livello del debito delle Fiji è aumentato negli ultimi anni, raggiungendo il 90% del PIL nel 2022, a causa degli impatti del COVID-19 in concomitanza con gravi cicloni tropicali. Entro il 2050, il IPCC prevede un aumento del 10% degli eventi alluvionali ventennali in uno scenario di riscaldamento di 1,5 °C, e un aumento del 22% in uno scenario di riscaldamento di 2,0 °C. Si prevede che le tempeste tropicali aumenteranno del 13% con un aumento di 2,0 °C della temperatura globale. Si prevede che le perdite e i danni cumulativi totali attribuibili al clima derivanti da inondazioni e tempeste ammonteranno a non meno di 56 miliardi di dollari nei SIDS in uno scenario di riscaldamento di 2 °C entro il 2050. Sebbene i cittadini dei Paesi sviluppati possano essere riluttanti a pagare per i loro errori storici, soprattutto se credono che i loro Paesi abbiano già cambiato rotta verso un futuro più sostenibile, la crescente consapevolezza sociale del cambiamento climatico ha spostato l'attenzione sulle aziende. È stato riferito che 100 aziende sono responsabili del 71% delle emissioni globali e tassarle in base al loro impatto climatico fornirebbe i fondi necessari per compensare le perdite e i danni subiti dai Paesi in via di sviluppo. A livello nazionale, una tassa sul carbonio per le aziende si è già dimostrata efficace nel frenare le emissioni. Per garantire che le multinazionali siano ritenute responsabili dell'impatto climatico delle loro attività globali, i Paesi devono coordinarsi attraverso trattati fiscali bilaterali o multilaterali e implementare un regime fiscale relativamente uniforme per le emissioni di carbonio che eviti una corsa al ribasso. Cosa significa la creazione di un Fondo per le perdite e i danni? È una facility in cui raccogliere denaro per risarcire quei costi. La maggior parte degli attuali finanziamenti per il clima aiutano a mitigare o adattarsi ai cambiamenti climatici ma non le perdite né i danni. Senza nuovi finanziamenti specifici, le persone che stanno già soffrendo soffriranno di più. La disuguaglianza peggiorerà in tutto il mondo, poiché le perdite e i danni rischiano di alimentare il debito, la migrazione di massa e l'instabilità politica o la guerra. L'istituzione di un fondo per le perdite e i danni sotto l'egida delle Nazioni Unite è il modo più equo, trasparente e responsabile per fornire supporto finanziario a Paesi e comunità che ne hanno urgente bisogno. I Paesi hanno concordato la creazione di un fondo alla COP 27. Ciò che conta ora è assicurarsi effettivamente che i Paesi sviluppati si impegnino a versare nuovi fondi mantenendo le promesse per la finanza climatica. Su chi sia responsabile del pagamento si dibatte molto. Ma l'approccio più equo è che siano gli inquinatori a pagare. I Paesi e le aziende fossili ricche e sviluppate sono i maggiori responsabili della crisi climatica. Molti si sono arricchiti e sono diventati potenti bruciando combustibili fossili. Ciò significa che hanno un debito nei confronti dei Paesi e delle comunità più colpite. E ora hanno la responsabilità morale e legale di fornire supporto finanziario. I Paesi potrebbero dire di non avere abbastanza denaro per coprire i pagamenti per le perdite e i danni. Ma questo non è vero. Ci sono molti modi in cui potrebbero raccogliere i fondi. Ad esempio, potrebbero aumentare le tasse sui profitti delle aziende di combustibili fossili, che hanno guadagnato vendendo prodotti che guidano il cambiamento climatico. Negli ultimi 20 anni, queste aziende hanno realizzato profitti sufficienti per pagare molte volte le perdite climatiche nei Paesi più poveri. Per di più il negoziato non è stato finora in grado di risolvere il problema dell'addizionalità del Fondo loss and damage e quindi del double counting di cui molti paesi fanno esplicitamente uso.
2025, COP30_9. L'EUROPA ELABORA A FATICA LA SUA STRATEGIA CLIMATICA E INDUSTRIALE E PREPARA UN NUOVO NDC PER LA COP 30 Le attese (Reuters). I leader europei, assente Orban, si riuniscono il 23 e il 24 ottobre in un quadro di profonde divisioni, cui l'Italia apporta un significativo contributo, con una Agenda assai complessa. · I leader dell'UE dibatteranno il nuovo obiettivo climatico del blocco per il 2040. · I colloqui si concentreranno sul mantenimento della competitività dell'economia dando corso alla transizione ecologica. · I Paesi sono divisi sul ritmo e sui costi della riduzione delle emissioni. · La transizione ecologica è un'opportunità di business, afferma von der Leyen. I leader dell'Unione Europea cercheranno di sbloccare giovedì un accordo sul nuovo obiettivo di emissioni per il 2040, in tempo per i colloqui sul clima del prossimo mese, nonostante la crescente opposizione alle misure ecologiche da parte di alcuni Stati membri, Italia compresa. L'UE sta cercando di approvare un nuovo obiettivo per ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 per allineare il blocco alla neutralità carbonica entro il 2050 - vista dagli scienziati come un passo essenziale per evitare gli impatti peggiori del riscaldamento globale. L'obiettivo 2040 mira a mantenere l'UE in linea tra l'attuale impegno legalmente vincolante di tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 e l'obiettivo 2050. Tuttavia, il nuovo obiettivo ha incontrato resistenza da parte di alcune capitali riguardo a come finanziare la transizione a basse emissioni di carbonio insieme a priorità come la difesa contro l'aggressione russa e la rivitalizzazione delle imprese. "Nessuno di noi sta mettendo in discussione l'obiettivo della protezione del clima. Tutti siamo dell'opinione che dobbiamo combinarlo con la competitività dell'industria europea", ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nonostante il peggioramento degli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, gli sforzi ambiziosi per combattere il cambiamento climatico stanno vacillando - con il Presidente Donald Trump che smantella le misure di riduzione delle emissioni negli Stati Uniti e promuove i combustibili fossili. I leader concentreranno i loro colloqui sulle cosiddette "condizioni abilitanti" - finanziamenti e politiche di supporto - necessarie per evitare bollette energetiche più alte per i cittadini e sostenere le imprese che già lottano con le importazioni cinesi a basso costo e i dazi statunitensi. Il Primo Ministro olandese Dick Schoof ha affermato di aspettarsi che l'UE mantenga i suoi obiettivi climatici - che, almeno per il 2030, i dati ufficiali suggeriscono che il blocco è in gran parte in grado di raggiungere. "Ma dovremo esaminare attentamente come mantenerli sostenibili per i cittadini e le imprese", ha aggiunto.
Bruxelles ha già ridimensionato numerose politiche di sostenibilità quest'anno, nel tentativo di contenere le reazioni politiche, sia da parte dei governi dell'UE che dei partner commerciali, inclusi gli Stati Uniti e il Qatar. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto ai leader che il passaggio a un'economia pulita è l'occasione per l'Europa di rivitalizzare le industrie e ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Cina, che sta investendo massicciamente nell'energia rinnovabile. "Questa è una grande opportunità di business per l'Europa. Coglierla richiede fermezza e un'implacabile spinta per affrontare i nostri concorrenti, a partire dalla Cina", ha detto von der Leyen in una lettera visionata da Reuters e datata 20 ottobre. Ha anche promesso alcuni emendamenti, incluso il controllo dei prezzi in un imminente mercato del carbonio per i carburanti per i trasporti e il rafforzamento del dazio di frontiera sul carbonio dell'UE, una richiesta chiave della Francia. Bruxelles sta anche valutando se ammorbidire il suo divieto di produrre altri i motori a combustione del 2035 dopo le pressioni della Germania cui l’Italia si è mestamente accodata con argomentazioni come sostituire i fossili con carburanti biologici e sintetici che non si capisce dove verrebbero presi. L’Italia evidentemente confida di vendere i suoi vecchi motori e le relative componenti ad un mercato mondiale che sarebbe a quel punto in gran parte elettrificato. Forse come pregevoli oggetti di antiquariato. Risultati. I leader europei hanno concordato una svolta sulle questioni climatiche che aumenta la probabilità che l'UE possa approvare un obiettivo climatico per il 2040 e un impegno sul clima prima della COP 30 di novembre Hanno concordato una serie di condizioni abilitanti volte ad aiutare le case automobilistiche e le altre industrie ad alta intensità energetica a realizzare la transizione verde e di procedere con l'obiettivo 2040, ma lasciando i dettagli ai ministri per l'approvazione in una riunione programmata per il 4 novembre. I colloqui hanno visto i leader discutere su come gestire gli obiettivi contrastanti del blocco: sostenere le aziende in difficoltà, inclusa l’amata industria automobilistica fossile, senza perdere il ruolo guida nella lotta al clima. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha inserito una clausola di revisione nei piani per estendere il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per le emissioni di riscaldamento e trasporti (il cd. ETS 2), che darà ai paesi membri la possibilità di ritardare o adeguare la sua attuazione. Il ministero delle finanze francese ha affermato che l'UE deve mantenere un certo grado di flessibilità in termini di neutralità tecnologica mentre considera nuove norme sulle emissioni per le vendite di auto nuove. Rimane fermo l’obiettivo della neutralità carbonica nel 2050 e il taglio delle emissioni del 90 per cento entro il 2040. Inoltre, c’è la possibilità di inserire almeno delle verifiche prima del 2040, nelle quali eventualmente ridiscutere i target. Il Consiglio attende con interesse la proposta della Commissione sull’accelerazione della decarbonizzazione» e su come sostenere il raggiungimento dell’obiettivo climatico intermedio dell’Ue per il 2040, che va perseguito con realismo e con sostenibilità (?). Il 2035 rimane per il blocco della vendita dei motori endotermici, con buona pace dell’Italia. Una novità rimette in gioco il carbon offsetting come sembra dall’intervento della von der Leyen che avrebbe proposto di esternalizzare fino al 3% il target del 2040 acquistando crediti di carbonio da altre nazioni. Il commento di Politico, piuttosto sarcastico, dice che una delle patate più bollenti in vista del vertice è passata sorprendentemente senza intoppi. I leader alla fine si sono astenuti dal demolire gli obiettivi climatici dell'UE, concordando un impegno espresso in termini vaghi per una transizione verde, sebbene senza impegnarsi per un obiettivo 2040, che propone un taglio delle emissioni del 90% rispetto ai livelli del 1990. I ministri si riuniranno di nuovo per votare l'obiettivo 2040 il 4 novembre. Un classico compromesso che fa tutti ugualmente scontenti. Almeno un leader è però sembrato soddisfatto. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha definito il vertice un punto di svolta nell'approccio europeo alla politica green, perché è riuscito a inserire la clausola di revisione nel piano dell'UE ETS 2. Abbiamo disinnescato una minaccia per le famiglie e gli automobilisti polacchi, ha dichiarato, definendo il cambiamento un segnale che 'l'Europa sta finalmente parlando la nostra lingua. Uno dei pilastri della transizione verde dell'UE, il suo divieto de facto dei motori a combustione interna entro il 2035, era destinato a svolgere un ruolo di primo piano nelle discussioni su competitività e clima, con Merz, Fico e Meloni in cerca di uno scontro sulla proposta, è a malapena registrato come una nota a piè di pagina. La Slovacchia ha usato i colloqui sul clima per opporsi al divieto e la Repubblica Ceca si è unita per concordare, ma alla fine le conclusioni ufficiali del vertice hanno accolto con favore il divieto proposto dalla Commissione senza per ora almanaccare su come dovrebbe essere annacquato. Last but not least nulla si è discusso sul nuovo NDC per EU. Resta fermo che, in attesa delle molte decisioni da prendere, sarà presentato solo alla COP 3o e che, quindi, quantomeno il suo schema rimane quello definito nel già citato documento del Consiglio del 21 ottobre. Conclusione della storia: backlash dell'Europa. Come e peggio di come si temeva, l'ondata di scetticismo climatico ha travolto EU che, dopo i citati rimbalzi, ha ceduto e ha fatto macchina indietro sugli obiettivi della transizione. Un comunicato del Consiglio di intonazione alquanto ipocrita ne dà notizia in data 5 novembre. I ministri del clima dell'UE hanno concordato un obiettivo per il 2040 nelle prime ore di mercoledì 4 novembre dopo aver ammorbidito l'obiettivo in negoziati dell'ultima ora, correndo per raggiungere l'accordo prima della COP 30. Dopo aver negoziato fino a tarda notte martedì, i ministri hanno approvato con un voto pubblico un compromesso per tagliare le emissioni del 90% entro il 2040, rispetto al 1990, ma con flessibilità che ne indeboliscono l'obiettivo. L'obiettivo ammorbidito consentirebbe ai paesi di acquistare crediti di carbonio esteri per coprire fino al 5% dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90%. Ciò indebolirebbe di fatto all'85% i tagli alle emissioni richiesti alle industrie europee, e pagherebbe paesi stranieri per tagliare le emissioni per conto dell'Europa per coprire il resto. L'UE ha anche concordato di prendere in considerazione, in futuro, l'opzione di utilizzare crediti di carbonio internazionali per soddisfare un ulteriore 5% delle riduzioni delle emissioni per il 2040, potenzialmente riducendo l'obiettivo domestico di un altro 5%. Inoltre, i paesi hanno concordato un obiettivo per il 2035 di ridurre le emissioni in un intervallo compreso tra il 66,25% e il 72,5%. Questo sarà il NDC EU a COP 30. In un ulteriore sforzo per convincere i paesi scettici, l'UE ha anche accettato di ammorbidire altre politiche climatiche politicamente sensibili, in particolare ritardando l'avvio del mercato del carbonio dell'UE di un anno, al 2028. Nonostante ciò, una manciata di paesi tra cui Polonia, Slovacchia e Ungheria si è opposta all'obiettivo climatico per il 2040, sostenendo che avrebbe danneggiato la competitività delle industrie. La loro opposizione non è stata sufficiente a bloccare l'accordo, che necessitava del sostegno di almeno 15 dei 27 Stati membri. La Commissione aveva originariamente proposto un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90%, con una quota massima del 3% di crediti di carbonio. L'obiettivo era stato concepito per mantenere l'UE in linea tra i suoi obiettivi giuridicamente vincolanti di tagliare le emissioni nette del 55% entro il 2030 e raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tuttavia, sconsigliava l'acquisto di crediti di carbonio esteri, che avrebbero distolto investimenti necessari dalle industrie europee. Paesi come Francia e Portogallo avevano chiesto una flessibilità del 5% per i crediti di carbonio, mentre altri, tra cui Polonia e Italia, avevano cercato il 10%. Spagna e Paesi Bassi erano tra quelli contrari ad ammorbidire ulteriormente l'obiettivo (Reuters). Polonia, Italia, la Repubblica Ceca e altri si sono opposti all'obiettivo originale del 90% in quanto troppo restrittivo per le industrie nazionali che lottano con gli alti costi energetici, le importazioni cinesi più economiche e i dazi statunitensi. Viceversa i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia, hanno citato il peggioramento delle condizioni climatiche estreme e la necessità di recuperare terreno con la Cina nella produzione di tecnologie verdi come ragioni per mantenere obiettivi ambiziosi. 2025, COP30_8. DI OVERSHOOT SI PARLERà POCO ALLA COP 30, MA è ORMAI UNA REALTà CON CUI FARE I CONTI Il tema del superamento temporaneo dei limiti termici dell’Accordo di Parigi, noto come overshoot, non è stato finora oggetto di adeguata attenzione da parte della scienza del clima e non è mai comparso nel negoziato e nelle COP. Di che si tratta? Gli specialisti hanno fatto quanto nelle loro abitudini ed hanno convocato una prima conferenza internazionale sul controverso tema all’inizio di ottobre 2025 nell’istituto IIASA a Laxenburg, vicino a Vienna, dove per ora non si pongono limiti alla presenza di tutti gli scienziati dell’est e dell’ovest. La conferenza, durata tre giorni, ha riunito quasi 200 ricercatori ed esperti legali per discutere i possibili percorsi futuri della temperatura globale in cui l’obiettivo aspirazionale dell’Accordo di Parigi, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C a fine secolo viene raggiunto dall’alto, piuttosto che dal basso. I percorsi di overshoot sono quelli che superano temporaneamente il limite di 1,5 °C, per poi essere riportati al di sotto di tale soglia tramite tecniche di rimozione del carbonio dall’atmosfera. Lo studio dell’overshoot è cresciuto negli ultimi anni, man mano che la possibilità di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C si è fatta più remota. La conferenza è stata suddivisa in otto aree tematiche: ambizione di mitigazione; rimozione della CO₂ (CDR); risposte del sistema terrestre; impatti climatici; punti di non ritorno (tipping points); adattamento; perdite e danni (loss and damage) ed implicazioni legali. È stata anche data grande attenzione a come comunicare il concetto di overshoot. Oggi, il termine viene per lo più usato per descrivere percorsi futuri in cui la temperatura supera temporaneamente il limite di 1,5 °C per poi tornare al di sotto. Tuttavia, un singolo percorso emissivo può sia superare 1,5 °C nel breve periodo, sia stabilizzarsi su 1,5°C nel lungo termine. L’aspetto cruciale è che un overshoot implica un periodo temporaneo di superamento, destinato a essere invertito.
La conferenza si è concentrata sulla reversibilità o irreversibilità degli impatti climatici. Nessuna somma di denaro potrà far ritirare il mare nelle nostre vite o in quelle dei nostri figli. Non c’è un pulsante rewind per un ghiacciaio sciolto, né una macchina del tempo per una specie estinta. Una volta superati certi punti critici, nessun successivo raffreddamento potrà ripristinare barriere coralline, ghiacci o specie perdute. Sono stati presentati studi sulle probabilità di perdita irreversibile dei ghiacciai, sull’impatto duraturo sulle risorse idriche, e su come la durata e l’intensità dell’overshoot influenzino diversi tipi di impatti. Ad esempio, nei vari studi si legge che 10 anni a 1,6 °C sono simili a 5 anni a 1,7 °C in termini di effetti o che un overshoot di 0,2 °C per 10 anni comporta il 15% di morti da caldo in più nel XXI secolo rispetto a un overshoot di 0,1°C. Overshoot, adattamento e danni permanenti. Gran parte delle strategie di adattamento presuppongono un aumento continuo della temperatura globale media. Ma in alcuni casi, ad esempio infrastrutture permanenti, l’overshoot potrebbe richiedere piani di adattamento diversi. Dal punto di vista sociale, il bisogno di adattamento è massimo prima del picco di riscaldamento, poiché è in quel periodo che la società deve rafforzare la propria resilienza per superare la fase critica. Tuttavia, anche negli scenari più ottimistici, non riusciremo a riassorbire neppure la metà dei danni subiti. Si è discusso anche di come i quadri legali internazionali dovrebbero evolversi in un mondo in overshoot, dove gli Stati devono perseguire strategie di emissioni nette negative per riportare le temperature a 1,5 °C. Si pone il problema di andare oltre il semplice net zero e fissare obiettivi di emissioni negative entro la metà del secolo. I ritardi nelle riduzioni attuali ne spostano il peso sulle generazioni future, aumentando la necessità di giustizia correttiva e risarcimenti per perdite e danni. Tuttavia, maggiori sforzi di adattamento rischiano di ridurre l’ambizione di mitigazione, data la limitata capacità decisionale e finanziaria. Un riscaldamento globale superiore a 1,5 °C aumenterà perdite e danni irreversibili e inaccettabili per persone, società e ambiente. È imperativo minimizzare sia il picco massimo che la durata del superamento degli 1,5 °C per ridurre i rischi aggiuntivi di violazioni dei diritti umani e cambiamenti irreversibili nei sistemi sociali, ecologici e terrestri, inclusi i punti di non ritorno. Ciò sarà possibile solo rimuovendo la CO₂ dall’atmosfera e riducendo ulteriormente le emissioni residue. Conclusioni provvisorie. Non possiamo essere certi che il calo della temperatura dopo il superamento temporaneo sia realizzabile entro le tempistiche attualmente previste. I percorsi di picco e successivo declino delle temperature si distinguono in base alla severità degli sforzi di riduzione delle emissioni nel breve periodo fino al raggiungimento delle emissioni nette zero di CO₂, nonché alle ipotesi sulle emissioni nette negative di CO₂ nel lungo periodo. Il primo fattore determina le emissioni cumulative massime di CO₂ di un dato percorso e, di conseguenza, approssimativamente l’entità e il momento del picco di riscaldamento. Il secondo fattore determina la velocità del potenziale ritorno delle temperature a livelli inferiori. Entrambi gli aspetti dipendono inoltre dall’evoluzione temporale delle emissioni non legate alla CO₂. È fuorviante considerare l’overshoot come un modo alternativo per ottenere lo stesso risultato climatico. Diversi impatti climatici infatti in un mondo pre- e post-overshoot sono differenti perché la reversibilità degli impatti non è garantita. Anche nei casi in cui gli impatti siano reversibili, i tempi di reversibilità possono essere più lunghi rispetto agli orizzonti decisionali tipici della pianificazione per l’adattamento. Gli impatti legati al picco del riscaldamento, piuttosto che quelli attesi nel lungo termine, rappresentano lo sfondo per la valutazione dei bisogni globali di adattamento. Da una prospettiva di giustizia climatica, l’overshoot comporta impatti socioeconomici e perdite e danni legati al clima che sono tipicamente irreversibili e gravano in modo sproporzionato sulle popolazioni povere. Il citato studio di Nature trae le seguenti conseguenze: - Le riduzioni delle emissioni devono essere accelerate il più rapidamente possibile per rallentare l’aumento della temperatura e ridurre il picco di riscaldamento. Perseguire un percorso di protezione energica è l’unica strategia solida per, se non evitare, almeno minimizzare i rischi climatici di vasta portata. - è necessario prepararsi a una capacità di rimozione della CO₂, CDR, ambientalmente sostenibile, per proteggerci da esiti ad alto rischio nel lungo periodo derivanti da feedback climatici più forti del previsto. Tale capacità preventiva di CDR potrebbe dover raggiungere diverse centinaia di Gt di emissioni nette negative cumulative, una scala che potrebbe essere appena possibile entro i limiti sostenibili delle attuali tecnologie. Ciò lascia poco margine per l’uso della CDR al fine di compensare le emissioni residue al di fuori dei settori difficili da decarbonizzare, sottolineando ulteriormente l’importanza di riduzioni estremamente rigorose delle emissioni nel breve termine per limitare i rischi a lungo termine. 2025, COP30_7. IL REBUS DEL FINANZIAMENTO PER IL CLIMA E LA CENERENTOLA DELL'ADATTAMENTO La finanza per il clima. La transizione verso un’energia pulita e a basse emissioni di carbonio, la costruzione di una maggiore resilienza agli impatti del cambiamento climatico e la protezione della natura e della biodiversità richiedono un rapido aumento degli investimenti in tutti i Paesi, in particolare nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo, che sono i più vulnerabili agli effetti del clima. LSE stima che il fabbisogno globale sia di circa 6,3–6,7 trilioni di dollari all’anno entro il 2030, di cui 2,7–2,8 trilioni nelle economie avanzate, 1,3–1,4 trilioni in Cina e 2,3–2,5 trilioni negli EMDC. Entro il 2035 sarà necessario un aumento globale del 20%, con il 40% destinato agli EMDC. La rapida diminuzione dei costi tecnologici, in particolare per l’energia solare, rappresenta un’opportunità senza precedenti per i Paesi in via di sviluppo. Qualsiasi riduzione degli investimenti prima del 2030 eserciterà una pressione aggiuntiva sugli anni successivi, creando un percorso più ripido e potenzialmente più costoso nel seguito. Inoltre, il fabbisogno di investimenti per l’adattamento e la resilienza, per le perdite e i danni e la rigenerazione della natura, aumenterà bruscamente con l’intensificarsi dei rischi climatici e ambientali. Lo sforzo richiesto potrebbe ammontare a circa il 15–18% del PIL globale nel 2030 e generare al contempo risparmi finanziari pari all’11–18% del PIL globale. L’espansione ampia e rapida dei finanziamenti per sostenere un massiccio piano di investimenti potrà essere raggiunta solo sfruttando tutte le fonti di capitale disponibili. Le risorse interne, che attualmente rappresentano circa il 70% dei finanziamenti climatici, potrebbero ragionevolmente coprire 1,4 trilioni di dollari all’anno sui 2,4 trilioni richiesti per il 2030 e 1,9 trilioni del fabbisogno totale di 3,2 trilioni entro il 2035. Il ruolo del settore privato sarà molto più importante rispetto al passato. I finanziamenti esterni, provenienti da tutte le fonti pubbliche e private, dovranno coprire circa 1 trilione di dollari all’anno del fabbisogno totale entro il 2030 e circa 1,3 trilioni entro il 2035, pari a un aumento di 15–18 volte rispetto ai livelli attuali. La finanza climatica è stata una priorità centrale dalla COP 26 di Glasgow alla COP 29 dell’anno scorso e la COP 30 sarà cruciale per portare avanti l’agenda finanziaria. È necessario un forte impulso su tre priorità: preparare e attuare investimenti di alta qualità; mettere in atto le riforme macroeconomiche, settoriali e istituzionali necessarie e mobilitare finanziamenti su larga scala e migliorare l’accesso a capitali a basso costo con condizioni più favorevoli per il debito esistente. Sebbene una quota molto rilevante della finanza climatica proverrà dal settore privato, la mobilitazione delle risorse pubbliche interne sarà fondamentale, anche attraverso l’aumento delle entrate fiscali. Il carbon pricing ha un potenziale straordinario per aumentare le entrate durante la transizione e fornisce incentivi efficienti per ridurre le emissioni di carbonio, così come per l’eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili e di altri incentivi dannosi. Ci sono tre ambiti in cui i progressi non sono ancora sufficienti: l’impegno nelle riforme strutturali e l’aumento degli investimenti a livello nazionale; l’espansione della capacità di prestito e la catalizzazione dei finanziamenti privati. È urgentemente necessario garantire un finanziamento adeguato al Fondo Loss and Damage. Il mercato volontario del carbonio ha il potenziale per generare entrate, ma ha subito gravi battute d’arresto e una perdita di fiducia. Sono in corso importanti sforzi per garantire una maggiore integrità dei crediti di carbonio. Alla COP29, le parti hanno raggiunto un consenso sugli standard per l’Articolo 6.4 dell’Accordo di Parigi, creando linee guida operative più chiare per promuovere l’uso dei crediti di carbonio di alta qualità e la domanda volontaria.
In breve, i 1,3 trilioni di dollari devono sostenere due obiettivi: rafforzare la resilienza dei paesi in via di sviluppo e, al contempo, garantire una crescita a basse emissioni di carbonio. Le nazioni vulnerabili, quelle con meno risorse per reagire, dovrebbero affrontare oltre mezzo trilione di dollari di danni legati al clima ogni anno entro il 2030. Nel frattempo, i finanziamenti per rafforzare la resilienza restano scarsi, con un divario di 360 miliardi di dollari tra ciò che è necessario e ciò che viene effettivamente fornito ogni anno. Inoltre, meno di un quinto dei fondi destinati all’adattamento raggiunge realmente le comunità che ne hanno bisogno. Allo stesso tempo, sia i paesi a basso reddito che quelli in crescita, hanno bisogno di sostegno per superare la dipendenza dai combustibili fossili, creando al contempo posti di lavoro e migliorando la qualità della vita. Serviranno finanziamenti per garantire che queste trasformazioni avvengano con la rapidità e l’ampiezza necessarie. Basti pensare che secondo l’IEA gli investimenti nel settore dell’energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo dovranno aumentare di circa sette volte entro il 2035.
1,3 trilioni di dollari possono sembrare una cifra enorme, ma non lo sono se
la si mette in prospettiva: utilizzando il tasso medio annuo di crescita del
PIL globale del 2,8% stimato dal FMI, rappresentano meno dell’1% del PIL
mondiale previsto per il 2035. L’obiettivo dei 300 miliardi di dollari di
finanziamenti climatici può essere raggiunto fornendo fondi direttamente ai
paesi destinatari; attraverso banche di sviluppo (MDB) come la Banca
Mondiale e fondi climatici multilaterali come il Green Climate Fund;
mobilitando finanziamenti privati. Almeno una parte significativa di questi
fondi deve essere erogata sotto forma di sovvenzioni, finanziamenti
agevolati e prestiti a basso costo, per evitare di aggravare l’indebitamento
dei paesi vulnerabili, molti dei quali già in crisi del debito. Pertanto la
ristrutturazione o la cancellazione del debito sarà cruciale per garantire
il massimo impatto dei nuovi fondi. Per passare da 300 miliardi a 1,3
trilioni occorrono aumenti di capitale nelle MDB, che con 1 $ dollaro di
denaro pubblico mobilitano 4–10 $ di investimenti, nuovi regimi fiscali a
carico dei settori inquinanti come l’aviazione, il trasporto marittimo o il
petrolio, che potrebbero generare oltre 200 miliardi di dollari, i mercati
del carbonio, ma, alla fine, almeno la metà dei 1,3 trilioni di dollari
dovrà provenire dal settore privato: un passaggio quanto mai poiché gli
investimenti a basse emissioni di carbonio nei paesi in via di sviluppo sono
ancora considerati rischiosi e costosi. Ci sono esempi di successo di questo
procasso,
l’IRA della precedente amministrazione
Su questa linea la Conferenza di Siviglia di luglio sul finanziamento dello sviluppo sostenibile ha ribadito che affrontare gli impatti sempre più intensi del cambiamento climatico richiede migliaia di miliardi di dollari, un costo ben al di là delle possibilità dei Paesi più poveri. Le divisioni su chi debba assumersi questa responsabilità finanziaria sono profonde e le cifre legate al nuovo obiettivo di finanziamento climatico sono enormi. Il nuovo obiettivo di Baku sostituisce il target annuale di 100 miliardi di dollari fissato nel 2009 a Copenhagen che è stato appena raggiunto nel 2022, con due anni di ritardo. Secondo un rapporto del Climate Policy Initiative, il finanziamento climatico globale pubblico-privato avrebbe già raggiunto in media 1,3 trilioni di dollari all’anno nel 2021/2022, rispetto ai 653 miliardi di dollari del 2019/2020. Altre organizzazioni stimano che la cifra necessaria sia di circa 1 trilione di dollari all’anno. Altri affermano che l’ammontare del finanziamento climatico richiesto potrebbe salire fino a 9 trilioni di dollari entro il 2030. Per soddisfare queste enormi esigenze finanziarie, i governi di tutto il mondo stanno esplorando varie opzioni, tra cui tasse sulla ricchezza, prelievi sul trasporto marittimo e la gestione del debito. Il Presidente della COP 29 di Baku ha dichiarato che la COP 29 ha gettato le basi per l'aumento dei finanziamenti per il clima. I 300 miliardi di dollari non sono mai stati pensati per risolvere da soli l'intera crisi climatica. Se le parti, le banche multilaterali di sviluppo e il settore privato riusciranno a implementare l'intero obiettivo e ad aumentare i finanziamenti per il clima destinati al mondo in via di sviluppo fino a 1.300 miliardi di dollari all'anno, allora sarà un passo storico verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ciò significa che i Paesi donatori devono raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento entro la fine di quest'anno, come promesso alla COP 26 di Glasgow, triplicare gli esborsi dei fondi delle Nazioni Unite entro il 2030 e che i donatori devono definire ora come contribuiranno con la loro quota dei 300 miliardi di dollari entro il 2035. Il precedente impegno di 100 miliardi di dollari ha richiesto più di un decennio per concretizzarsi. Perché i Paesi vulnerabili dovrebbero fidarsi che i nuovi impegni finanziari saranno effettivamente mantenuti? Il risultato di Baku, l’effetto l’ha avuto ma le critiche non hanno tardato ad arrivare e molti Paesi del Sud del mondo hanno espresso delusione, sostenendo che le somme promesse sono ancora molto inferiori a quanto necessario. Le stime sui bisogni di investimento climatico nel Sud globale fino al 2030, secondo Climate Home News, si aggirano tra i 5,1 e i 6,8 trilioni di dollari. Sorprende relativamente che alcuni autorevoli analisti hanno mostrato che l’obiettivo di Baku è raggiungibile in realtà senza ulteriori sforzi di bilancio da parte dei Paesi sviluppati, oltre agli aumenti già previsti. Una combinazione di impegni nazionali già esistenti e dei piani delle banche multilaterali di sviluppo (MDB) porterà il finanziamento climatico a circa 200 miliardi di dollari all’anno entro la fine di questo decennio. Inoltre, includendo i fondi già distribuiti da economie emergenti come la Cina, incoraggiata dal nuovo obiettivo, il totale potrebbe arrivare a 265 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò significherebbe che l’obiettivo è sulla buona strada per essere raggiunto entro quella data, con uno sforzo aggiuntivo minimo. Tuttavia l’obiettivo dei 300 miliardi di dollari non tiene conto dell’inflazione. Una volta considerata, il suo valore reale potrebbe ridursi di circa un quarto. In un contesto di tensioni finanziarie e incertezza politica nei Paesi sviluppati, i Paesi in via di sviluppo hanno sottolineato di aver bisogno che il finanziamento climatico raggiunga migliaia di miliardi di dollari, necessari per ridurre le emissioni e proteggersi dagli impatti del cambiamento climatico.
L’articolo 2.1 dell’Accordo di Parigi. Gli obiettivi di lungo periodo dell’Accordo di Parigi prevedono di allineare i flussi finanziari globali all’azione per il clima. L’articolo 2.1(c) del patto stabilisce l’obiettivo di “rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici”. Questo obiettivo è posto sullo stesso piano di quelli che mirano a limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C (articolo 2.1(a)) e ad adattarsi ai cambiamenti climatici (articolo 2.1(b)). Sono già stati fatti alcuni passi concreti in questa direzione nell’economia reale. Molte grandi banche e investitori si sono impegnati ad allineare i propri portafogli all’obiettivo delle emissioni nette zero e, nonostante alcune reazioni negative in certi contesti, la maggior parte resta fedele a questo impegno. Più di 50 giurisdizioni diverse stanno sviluppando o applicando tassonomie di finanza sostenibile, e il mercato delle obbligazioni verdi e sociali è cresciuto rapidamente, raggiungendo i 6 trilioni di dollari nel 2025. Tuttavia, senza un adeguato sostegno politico dall’alto, continueranno a mancare della velocità e della scala necessarie. Per l’articolo 2.1(c), questo sostegno potrebbe concretizzarsi attraverso la creazione di un quadro di riferimento per monitorare i progressi verso l’allineamento della finanza agli obiettivi climatici, orientare le politiche per reindirizzare gli investimenti e garantire che i Paesi in via di sviluppo abbiano accesso ai capitali necessari. Il quadro dovrebbe inoltre assicurare un equilibrio tra attenzione alla mitigazione tanto quanto all’adattamento. Un sostegno politico all’attuazione dell’articolo 2.1(c) contribuirebbe alla risposta della COP 30 al divario di ambizione, dato che i piani climatici nazionali presentati finora sono ancora lontani dal metterci sulla traiettoria per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Se ben strutturata, una decisione sull’articolo 2.1(c) potrebbe inviare un segnale forte: i governi comprendono che l’azione climatica non riguarda solo la definizione di obiettivi ambiziosi, ma anche l’allineamento del sistema finanziario a tali ambizioni. Per i Paesi in via di sviluppo, questo potrebbe significare che i flussi finanziari inizieranno finalmente a trasformare i piani in progetti concreti che migliorano la vita delle persone. Per i mercati, fornirebbe la certezza necessaria a sbloccare maggiori investimenti privati. Per i cittadini, potrebbe ristabilire la fiducia nella cooperazione climatica internazionale, affrontando il problema alla radice. Tra tutte le decisioni che la COP 30 di Belém potrebbe produrre, un risultato forte sull’articolo 2.1(c) potrebbe essere il più significativo. Se la finanza continuerà a sostenere i combustibili fossili ai livelli attuali, l’Accordo di Parigi fallirà. Se invece sarà equamente reindirizzata verso l’energia pulita e la resilienza, ci sarà ancora una possibilità di successo. Sebbene l’autorità per l’intera gamma di azioni necessarie a raggiungere questo obiettivo vada oltre il mandato della Convenzione climatica delle Nazioni Unite, il processo della COP ha comunque un ruolo importante da svolgere. La sua credibilità, in una fase in cui quello che conta è l'attuazione delle politiche, dipende da questo.
Nel 2021/22, la finanza per l'adattamento ha raggiunto i 69 miliardi di dollari USA, con un aumento del 40% rispetto al 2019/20. Ciononostante, il divario di finanziamento globale per l'adattamento si sta ampliando La citata analisi del Climate Policy Initiative indica che solo in quei paesi, i finanziamenti annuali per l'adattamento dovranno raggiungere 212 miliardi di dollari entro il 2030 e 239 miliardi di dollari tra il 2031 e il 2050. Le stime esistenti del fabbisogno globale di finanziamenti per l'adattamento sottovalutano in modo significativo la reale portata degli investimenti necessari per affrontare gli impatti del cambiamento climatico e costruire economie resilienti. Ciò è dovuto al fatto che i futuri costi di adattamento sono intrinsecamente difficili da quantificare, in quanto dipendono da impatti climatici incerti, localizzati e in evoluzione. Alla Conferenza di Bonn di giugno l’adattamento era chiaramente al centro dell’attenzione. La terza lettera della Presidenza della COP 30 aveva ribadito che le Parti dovevano perfezionare gli indicatori dell’Obiettivo Globale (GGA), tuttavia, non era chiaro in che modo il finanziamento per l’adattamento sarebbe stato trattato. La questione è stata però rapidamente chiarita, con l’adattamento che è emerso come tema chiave nell’agenda formale sul finanziamento, diventando un punto critico in tutte le negoziazioni sull’adattamento. La nuova attenzione sull’adattamento non ha però sciolto i nodi sui riferimenti alle fonti, ai contributori e agli strumenti del finanziamento. Nei negoziati sui Piani Nazionali (NAP), le Parti sono rimaste in stallo su come fare riferimento al sostegno finanziario e tecnico, nonché sulle responsabilità dei paesi sviluppati rispetto alle altre Parti. G77 e Cina hanno insistito per concentrarsi sulla fornitura di finanziamenti da parte dei paesi sviluppati e hanno respinto i riferimenti ai finanziamenti pubblici nazionali, sostenendo che ciò potrebbe indebolire la responsabilità dei paesi sviluppati. La fornitura di finanziamenti è fondamentale per l'adattamento, ambito nel quale è relativamente più difficile mobilitare fondi privati. Le preoccupazioni riguardo agli impegni dei paesi sviluppati hanno alimentato i dibattiti di Bonn, su questioni meramente formali. L’unica nota positiva è arrivata durante la discussione sull’Articolo 2.1(c) dell’Accordo di Parigi che ha posto una forte enfasi sull’adattamento, condivisa dalle Parti. Nel complesso, tuttavia, le Parti hanno lasciato Bonn con un risultato minimo proprio a causa di tali disaccordi scaricando sul Brasile tutta la controversia sul finanziamento dell’adattamento. Bisogna risalire alla COP 26 di Glasgow per trovare una forte attività di promozione del finanziamento con il raddoppio dei fondi per l’adattamento sostenuto attivamente dalla Presidenza. Poi un lungo silenzio fino a che ora si può chiedere al Brasile di trattare il finanziamento per l’adattamento come questione a sé stante, al di fuori dell’intrico della finanza globale per il clima. Il Brasile dovrebbe promuovere una narrazione che articoli un insieme ambizioso ma equilibrato di risultati, ferma nel richiamare le responsabilità legali dei Paesi sviluppati nel fornire finanziamenti per l’adattamento, ma al tempo stesso ambiziosa nell’incoraggiare contributi volontari da parte di altri Paesi ricchi e ad alte emissioni. Dovrebbe sottolineare il ruolo centrale delle sovvenzioni e dei finanziamenti pubblici altamente agevolati, evidenziando al contempo le opportunità per il settore privato di ampliare gli investimenti per l’adattamento in linea con i NAP e gli NDC. L’importanza degli investimenti pubblici nazionali nella resilienza dovrebbe essere messa in evidenza, insieme alla necessità di alleggerire il debito e creare spazio fiscale. La narrazione può sostenere la creazione di contesti politici favorevoli agli investimenti, rifiutando fermamente l’imposizione di nuove condizionalità. La Presidenza della COP 30 dovrebbe guardare ai numerosi Paesi sviluppati i cui impegni pluriennali di finanziamento climatico scadranno nel 2025 o all’inizio del 2026. Nonostante i recenti tagli agli Aiuti Pubblico allo Sviluppo, ODA, esiste ancora una reale opportunità per promuovere la priorità assegnata al clima, e in particolare all’adattamento. Dovrebbero inoltre essere sollecitate nuove promesse di finanziamento al Adaptation Fund, per garantire la continuità dei programmi fino a quando le entrate derivanti dalla quota di proventi dell’Articolo 6.4 di Parigi non diventeranno disponibili. 2025, COP 30_6. A CHE PUNTO SIAMO CON LE DICHIARAZIONI DI IMPEGNO PER LA MITIGAZIONE (NDC) DEI VARI PAESI? Lo stato del clima in vista della COP 30. Lo stato del clima in costante peggioramento nva rapportato alle attività globali di mitigaazione. Si intende per mitigazione l’attività volta a stabilizzare la concentrazione di gas serra in atmosfera e con essa la temperatura globale superficiale media della terra che è ad essa strettamente proporzionale. A Parigi nel 2015 si stabilì che l’anomalia di tale temperatura a fine secolo, rispetto al periodo preindustriale, non avrebbe dovuto superare i 2 °C, poi preferibilmente ridotti a 1,5 °C. Il gas serra antropogenico principale è la CO₂ la cui concentrazione in atmosfera arriva a 422,5 ppmv nel 2024, 2,8 parti per milione in più rispetto al 2023, e il 52% in più rispetto ai livelli pre-industriali. L’insieme degli assorbitori (sink) naturali di CO₂, terrestri e oceanici, ha continuato ad prendersi circa la metà della CO₂ antropogenica emessa in atmosfera. Le emissioni per il 2024 diminuiscono nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, ma aumentano in India, leggermente in Cina e nel resto del mondo. Le emissioni totali di CO₂ sono responsabili dell’aumento della concentrazione atmosferica della CO₂ (in media +2,5 ppmv nell’ultimo decennio). Le emissioni totali di CO₂, somma delle emissioni da combustibili fossili e da cambiamento d’uso del suolo, si sono stabilizzate nell’ultimo decennio e sono stimate a 41,6 GtCO₂ nel 2024. Le emissioni globali di CO₂ da combustibili fossili sono viceversa previste in aumento dello 0,8% nel 2024 (-0,3 ÷ 1,9%), raggiungendo 37,4 GtCO₂. La crescita nell’uso di gas naturale e petrolio spinge le emissioni fossili globali verso l’alto. Anche le emissioni da carbone sono previste in aumento. Le emissioni globali di CO₂ da cambiamento d’uso del suolo rimangono elevate, con una stima di 4,2 GtCO₂ nel 2024, ma sono diminuite ogni decennio a partire dagli anni ’90, in particolare nell’ultimo decennio (-20%). Oltre agli assorbimenti dovuti al cambiamento d’uso del suolo, la rimozione deliberata di anidride carbonica (CDR) non basata sulla vegetazione ha compensato nel 2023 solo una frazione trascurabile delle emissioni di CO₂.
Decarbonizzare l'economia significa lasciare sottoterra quantità importanti di fossili, carbone, petrolio e gas. Lo studio sottoposto a revisione paritaria, pubblicato su Nature nel 2021, ha scoperto che il 90% del carbone deve rimanere non estratto e quasi il 60% del petrolio e del gas metano fossile deve rimanere sottoterra per avere anche solo il 50% di possibilità di impedire che le temperature globali aumentino di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. L'entità di queste stime fa capire come e perché la decarbonizzazione sia osteggiata in tutti i modi dall'industria dei fossili, che da un pò di tempo chiamiamo oil and gas, pur sapendo che lo stesso carbone è oggetto di rilancio da parte di una quantità di iniziative ben sostenute e finanziate. Gli strumenti della mitigazione. La COP 28 di Dubai, tenuta e presieduta da personaggi del mondo oil and gas, non lascia più dubbi su tali strumenti laddove prescrive la transition away from fossil fuels e tripliicare le fonti rinnovabili entro il 2030 in uno con il raddoppio dell'efficienza. Il Rapporto IEA Renewables 2025 prospetta che la capacità globale di energia rinnovabile dovrebbe raddoppiare da oggi al 2030, con un aumento di 4.600 gigawatt (GW). Si tratta, più o meno, dell’equivalente della capacità di generazione elettrica combinata di Cina, Unione Europea e Giappone aggiunta al mix energetico mondiale. Il solare fotovoltaico rappresenta quasi l’80% dell’aumento globale, seguito da eolico, idroelettrico, bioenergia e geotermico. In oltre l’80% dei Paesi del mondo, la capacità di energia rinnovabile crescerà più rapidamente tra il 2025 e il 2030 rispetto al quinquennio precedente. L’aumento della capacità solare fotovoltaica è destinato a più che raddoppiare nei prossimi cinque anni, dominando la crescita globale delle rinnovabili. Costi contenuti, autorizzazioni più rapide e un’ampia accettazione sociale continuano a favorire l’adozione sempre più rapida del solare fotovoltaico. Le energie rinnovabili (ER) forniranno oltre il 70% della produzione globale di elettricità entro il 2050, con le altre tecnologie decarbonizzate tutte molto indietro. In secondo luogo, l'elettrificazione dell'economia globale è il passaggio obbligato per la decarbonizzazione, compresi i settori industriale e dei trasporti. Reuters osserva che nel 2024 è stato aggiunto a livello globale un record di 582 GW di capacità rinnovabile, con un tasso di crescita annuo del 15,1%. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo entro il 2030 sarà necessario un tasso di crescita annuo del 16,6% tra il 2025 e il 2030. Sono oltre 100 ipaesi si sono impegnati a triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030 durante la COP 28 del 2023. La realtà è però assai meno rosea, come mette in luce il recente Rapporto del SEI. I governi prevedono di produrre nel 2030 un volume di combustibili fossili superiore del 120% rispetto a quanto sarebbe coerente con il limite di riscaldamento globale di 1,5 °C, e del 77% superiore rispetto a quanto compatibile con il limite di 2 °C. Ciò rappresenta un ampliamento del divario rispetto all’analisi del 2023, che evidenziava una differenza del 110% e del 69% per i due target. Il continuo fallimento collettivo dei governi nel ridurre la produzione di combustibili fossili e le emissioni globali implica che, in futuro, la produzione dovrà diminuire in modo più drastico per raggiungere la neutralità climatica nella seconda metà del secolo. In contrasto con la promozione strisciante dei fossili, esplode a livello mondiale l'energia rinnovabile, sopratutto per la produzione di energia elettrica. L'energia rinnovabile è lo strumento più efficace al servizio della mitigazione. Alla fine del 2024, la capacità globale di energia rinnovabile ha raggiunto 4448 GW. Il solare, in linea con l’anno precedente, ha rappresentato la quota maggiore del totale mondiale, con una capacità di 1865 GW. La produzione idroelettrica rinnovabile e l’energia eolica hanno costituito la maggior parte della restante capacità, con rispettivamente 1283 e 1133 GW. Altre fonti rinnovabili comprendono 151 GW di bioenergia, 15 GW di geotermico e 0,5 GW di energia marina. Nel 2024 la capacità di energia rinnovabile è aumentata di 585 GW (+15,1%). Oltre tre quarti di questa espansione sono dovuti all’energia solare, che ha registrato un incremento di 452 GW (+32,2%); seguono l’energia eolica con 113 GW (+11,1%). La capacità idroelettrica rinnovabile è cresciuta di 15 GW (+1,2%), la bioenergia di 4,6 GW (+3,2%) e la geotermica di 0,4 GW (+2,5%). L’energia solare ed eolica hanno continuato a dominare l’espansione della capacità rinnovabile, rappresentando insieme il 96,6% di tutte le nuove installazioni nette del 2024. Nonostante i progressi, la crescita non è ancora sufficiente a raggiungere l’obiettivo di triplicare la capacità rinnovabile globale installata a oltre 11 TW entro il 2030. Mantenendo il tasso di crescita del 2024, si arriverebbe a 10,4 TW entro il 2030, ossia 0,8 TW (−7,2%) in meno rispetto al traguardo. Nel periodo di cinque anni 2018–2023, la capacità rinnovabile globale è cresciuta a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,4%. Se questa tendenza storica continuasse, la capacità installata nel 2030 raggiungerebbe 8,0 TW, cioè 3,1 TW (−27,9%) al di sotto dell’obiettivo. Per centrare il traguardo entro il 2030 sarebbe stato necessario mantenere un tasso di crescita minimo del 16,1% all’anno a partire dal 2022. Tuttavia, poiché sia nel 2023 sia nel 2024 tale tasso non è stato raggiunto, la capacità rinnovabile dovrà ora aumentare ancora più rapidamente, con una crescita del 16,6% annuo nei prossimi sei anni. Il mercato del carbonio. Il pricing del carbonio (CP) è un approccio basato sul mercato per ridurre le emissioni, che assegna un costo alla CO₂ attraverso meccanismi come le tasse sul carbonio o i sistemi di cap-and-trade, creando così incentivi economici per le imprese a ridurre le proprie emissioni. Il pricing del carbonio rappresenta la strategia fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto consente di ridurre efficacemente le emissioni pur permettendo la crescita economica. L’esperienza dimostra che meccanismi di CP ben progettati possono produrre benefici ambientali significativi senza compromettere la stabilità economica, anche se occorre prestare attenzione alle implicazioni sociali ed all'equità di tali politiche. Promuovendo gli investimenti in tecnologie più pulite e incoraggiando la sostituzione delle risorse, il CP può svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi climatici. In teoria, le regolamentazioni basate sul mercato promettono di mitigare i cambiamenti climatici al minor costo possibile per la società. Il prezzo incoraggia sia la riduzione diretta delle emissioni, in particolare da parte degli emettitori con costi di abbattimento più bassi, sia gli investimenti in tecnologie che riducono tali costi. Le regolamentazioni market-based consentono alle imprese inquinanti maggiore flessibilità nel scegliere come conformarsi rispetto alle regolamentazioni di tipo command-and-control a patto che si trovi il modo di evitare il carbon leakage che si determina quando le imprese regolamentate riducono le proprie emissioni esternalizzando le fasi della catena del valore più ad alta intensità di carbonio, allora le emissioni di CO₂ si sposteranno semplicemente verso giurisdizioni o imprese non regolamentate. Il leakage mina alla base l’efficacia di qualsiasi politica di mitigazione e rischia addirittura di invertire l’impatto del CP sulle emissioni globali. Di mercato si parla sia in regime di regolamentazione che quando il mercato è libero per l'offsetting delle emissioni. A Bonn 2025 si è conclusa la fase di regolamentazione di tutti i mercati in attuazione dell'Art. 6 di Parigi. L'esempio guida del mercato di conformità è il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), che impone un tetto alle emissioni complessive di oltre 12.000 impianti energetici e manifatturieri in trentuno paesi. Il cap copre il 45% delle emissioni dell’UE e il 5% di quelle globali. Vengono quindi emessi permessi negoziabili per ogni tonnellata di CO₂ inclusa nel tetto. Il prezzo dei permessi si forma in un mercato europeo, in cui le imprese con un surplus di permessi vendono a quelle che ne hanno bisogno per rispettare la normativa. Questo approccio si sta estendendo ad altri territori, oltre 70 schemi attivati: Cina, California, etc. con prospettive di successo. Uno studio UK stima che, in media, le imprese regolamentate dall'EU ETS abbiano ridotto le emissioni del 16,3% durante la fase II del sistema di scambio. Non trova alcuna conferma il timore che il sistema non abbia effetti sulle prestazioni economiche delle imprese, misurate in termini di valore aggiunto o numero di dipendenti. Le imprese regolamentate hanno infatti aumentato gli investimenti in capitale del 10,5% ed hanno ridotto l’intensità di emissioni per unità di valore aggiunto del 17,4% durante la fase II dell'EU-ETS. Lo studio stima inoltre una riduzione del 10% nell’intensità di emissioni dell’output. Sulla base di innumerevoli e comunque complesse stime il mercato del carbonio potrebbe da solo conseguire i target di mitigazione di Parigi ove il prezzo per tonnellata si avvicinasse ai 200 US$. Nel mercato regolato EU-ETS siamo a meno di 70 € mentre, nelle medie globali, il mercato libero sta offrendo permessi a costi anche dieci volte inferiori. L'Accordo di Parigi contempla che ciascun Paese debba dichiarare le proprie intenzioni in merito alla lotta contro i cambiamenti climatici, in particolare il proprio impegno di abbattimento delle emissioni serra, ogni cinque anni. Questo avviene attraverso comunicazioni al segretariato della Convenzione climatica, UNFCCC, le Nationally Determined Contributions. L'Accordo sancisce un meccanismo attraverso il quale ogni successiva dichiarazione deve obbligatoriamente essere più avanzata della precedente. La COP 30 conclude l'anno della scadenza quinquennale a partire da un quadro precedente degli NDC del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi di Parigi. Gli NDC 2025 avrebbero dovuto essere presentati entro il 10 febbraio. Ciò non è avvenuto perché il 95% circa dei paesi ha mancato questa scadenza e quindi la Convenzione la ha spostata a settembre, quando, in occasione dell'ottantesima Asssemblea generale ONU, si è tenuto un vertice dedicato al clima, il Climate Action Summit. La speranza era di avere un quadro generale completo degli NDC 2025 così da poterli includere in un rapporto che sintetizzi i progressi climatici globali, previsto per ottobre.
Secondo Carbonbrief la Cina si è presa la scena al vertice sul clima delle Nazioni Unite, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra del 7-10% al di sotto dei livelli di picco entro il 2035, senza però indicare con adeguata precisione l'anno di riferimento. L'UE, inadempiente, ha trovato il modo di criticare apertamente lo NDC cinese, guadagnandosi una risposta piccata. Nella figura a destra sono rappresentate tre linee. In alto quella del nuovo NDC cinese, che nei fatti rinvia l'impegno dovuto all'Accordo di Parigi alla seconda metà del secolo, così configurando uno stato di overshoot termico per la prima metà. Al di sotto, in tratteggio blu, c'è l'andamento minimo richiesto dai modelli per l'obiettivo degli 1,5 °C e sotto ancora l'andamento mediano globale stimato da IPCC per tale obiettivo. Tuttavia, anche altri grandi emettitori hanno presentato nuovi annunci di impegni climatici durante l’evento, tra cui il quarto maggiore emettitore mondiale, la Russia, e la Turchia. Dopo il vertice, circa un terzo (63) dei paesi ha ora annunciato o presentato i propri impegni climatici al 2035. Al vertice, molti paesi hanno dichiarato di essere ancora al lavoro sui loro NDC e di puntare a inviarli all’ONU prima o durante la COP 30 di novembre. L’UE non ha ancora concordato un impegno climatico al 2035. Al vertice ONU, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato una “dichiarazione d’intenti” per ridurre le emissioni in un intervallo compreso tra il 66,3% e il 72,5% al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2035. Ha aggiunto che l’UE punta a presentare formalmente il proprio NDC all’ONU prima della COP 30 di novembre. Il secondo maggiore emettitore mondiale, gli Stati Uniti, aveva presentato il proprio impegno climatico al 2035 nel 2024, sotto la presidenza di Joe Biden. Tuttavia, l’attuale presidente Donald Trump ha successivamente firmato un ordine per ritirare il paese dall’Accordo di Parigi. Pertanto, si presume che l’impegno degli Stati Uniti sia ora nullo. Oltre 100 paesi hanno preso la parola al vertice sul clima. Non tutti questi paesi hanno annunciato nuovi impegni durante il vertice. In realtà, molti dei paesi intervenuti avevano già presentato i loro impegni al 2035, oppure hanno usato il loro intervento per promettere di farlo in un secondo momento. Nuovi impegni sono stati presentati solo da Cina, Russia, Turchia, Palau, Tuvalu, Kirghizistan, Perù, São Tomé e Príncipe, Fiji, Bangladesh ed Eritrea. Questi paesi rappresentano complessivamente il 36% delle emissioni globali di gas serra. Vale la pena notare che la sola Cina rappresenta il 29% delle emissioni. Nel complesso sono 53 i paesi che hanno già notificato i propri impegni climatici al 2035 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Queste nazioni coprono il 14% delle emissioni globali. Nonostante i nuovi annunci, due terzi dei paesi non hanno ancora presentato i propri impegni climatici al 2035. Tra questi figurano grandi emettitori come India, Indonesia e Messico. L’India prevederebbe di presentare il proprio impegno climatico al 2035 all’inizio della COP 30, il 10 novembre. Sia il Messico sia l’Indonesia hanno preso la parola al vertice ONU sul clima. Il Messico ha dichiarato di essere ancora in consultazione con le industrie riguardo al proprio obiettivo proposto, mentre l’Indonesia non ha fatto sapere quando intenda presentare il proprio NDC. L’Australia ha fissato un obiettivo in linea con il suo traguardo climatico al 2035: il governo ha annunciato un obiettivo di riduzione delle emissioni compreso tra il 62 e il 70% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2035. Molti altri paesi presenti al vertice hanno promesso di presentare i propri impegni al 2035 entro la COP 30 e quindi numerosi Stati hanno ignorato la scadenza di fine settembre, invocata dall'ONU, per essere inclusi nel prossimo rapporto di sintesi sugli NDC. Ciò significa che la COP 30, come temevamo, inizierà senza un quadro chiaro degli impegni globali di mitigazione. 2025, COP 30_5. LA QUESTIONE FORESTALE E IL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO AI SENSI DELL'Art. 6 DI PARIGI Le foreste coprono un terzo della superficie terrestre e sono fondamentali per la salute ambientale e il benessere umano. Ospitano oltre la metà delle specie terrestri del pianeta e svolgono un ruolo cruciale nella lotta al cambiamento climatico attraverso i processi naturali di sequestro del carbonio (sink). Il potenziale di mitigazione delle foreste, stimato al 2030 tra 4,1 e 6,5 GtCO₂eq, ne evidenzia il ruolo per il raggiungimento degli obiettivi di Parigi. La conservazione, la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste sono mezzi a basso costo per la mitigazione climatica, potendo arrivare a coprire fino al 30% delle misure attuabili nel prossimo decennio. Le foreste agiscono inoltre come barriere naturali contro eventi climatici estremi, come tempeste e inondazioni e sono fondamentali per l’approvvigionamento idrico, fornendo acqua potabile a quasi metà delle più grandi città del mondo. Le foreste offrono anche risorse e protezione indispensabili per le comunità che dipendono da esse per i propri mezzi di sussistenza.
Investire nelle foreste offre anche consistenti ritorni economici e opportunità occupazionali. Secondo l’UNEP un investimento di 30 miliardi di dollari nella lotta alla deforestazione, può ottenere un ritorno di 2.500 miliardi di dollari in prodotti e servizi salvaguardati. Investimenti mirati nel settore forestale possono generare milioni di posti di lavoro. L’inclusione delle foreste negli accordi internazionali sul clima è stata complessa, spesso considerata una misura di mitigazione secondaria. Assumendo una piena attuazione degli NDC nel contesto dell’Accordo di Parigi, emerge che l’uso del suolo, e in particolare le foreste, rappresentano un elemento chiave passando a livello globale da una fonte antropogenica netta nel periodo 1990–2010 (1,3 ± 1,1 GtCO₂eq all’anno) a un sink netto di carbonio entro il 2030 (fino a −1,1 ± 0,5 GtCO₂eq all’anno) e fornendo un quarto delle riduzioni di emissioni pianificate dai Paesi. Per realizzare e monitorare questo potenziale di mitigazione sono necessarie maggiore trasparenza e una più stretta cooperazione tra scienza e governi, così da aumentare la fiducia nei dati, compreso il riconoscimento della differenza di circa 3 GtCO₂e in più all’anno tra le stime dei rapporti nazionali NDC e quelle degli studi scientifici. Va riferito che proprio il Presidente brasiliano e il suo governo dovranno spiegare alla COP 30 le ragioni dell’allentamento delle regole contro la deforestazione nel loro paese e in particolare proprio a danno della foresta amazzonica. La deforestazione annuale nella foresta pluviale amazzonica brasiliana è diminuita dell’11%, secondo i dati del governo. In base ai dati satellitari, tra agosto 2024 e luglio 2025 è stata distrutta un’area di foresta pluviale quasi quattro volte più grande della Grande Londra. Tuttavia, questo rappresenta il tasso di deforestazione più basso dal 2014 — un segnale positivo per il paese in vista della COP 30. La gestione delle foreste impatta le regole dei mercati del carbonio, sistemi di scambio in cui i crediti di carbonio (un’unità equivale a 1 t di CO₂eq rimossa dall’atmosfera) vengono messi all’asta, venduti e acquistati. Le aziende possono utilizzare i crediti di carbonio per obbligo nel caso di un mercato di conformità, oppure per compensare le proprie emissioni (offsetting) nell’ambito di uno schema volontario. I mercati di conformità sono istituiti e regolamentati a livello nazionale o internazionale su base obbligatoria. L’autorità stabilisce limiti quantitativi obbligatori alle emissioni per ciascun emettitore e consente lo scambio di permessi/quote di emissione tra gli emettitori per raggiungere i rispettivi limiti. È così per il Sistema europeo EU ETS e per il sistema cap-and-trade della California. I mercati volontari, quelli dell’offsetting, sono mercati decentralizzati in cui attori privati acquistano e vendono crediti di carbonio per mettere a bilancio la compensazione delle loro emissioni. Qui l’istituzione di regole nette è quanto mai necessaria. Un lungo negoziato ha finora consentito di concordare linee guida e processi relativi al Meccanismo dei Crediti di carbonio dell’Accordo di Parigi (PACM, Articolo 6.4), per guidare le modalità di misurazione della riduzione delle emissioni e garantire che i crediti di carbonio emessi nell’ambito del PACM siano ambiziosi, reali, addizionali e verificabili. Questi elementi tecnici mirano a garantire certezza nell’espansione di una fonte importante di finanziamento per le economie emergenti. In America Latina, ad esempio, 12 Paesi su 17 hanno esplicitamente incluso gli approcci cooperativi previsti dall’Articolo 6 come strumento per raggiungere gli obiettivi dei propri NDC. Ogni Paese definirà modalità e tempistiche della propria partecipazione, ma vi è una generale aspettativa che le nuove regole offrano un potenziale significativo per l’espansione dei finanziamenti climatici. Lo stato generale del negoziato internazionale sul mercato del carbonio Alla COP 29 di Baku il negoziato aveva effettivamente portato alla finalizzazione delle regole per i mercati internazionali del carbonio ai sensi dell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Il testo che riaffermava l’importanza di conservare, proteggere e ripristinare la natura. Sfortunatamente nella caotica sessione plenaria finale non si è riusciti ad adottare questo documento. Le regole che disciplinano il commercio di crediti di carbonio da paese a paese ai sensi dell’Articolo 6.2, così come il nuovo mercato internazionale del carbonio previsto dall’Articolo 6.4 (PACM), sono ormai più o meno complete. Mobilitando investimenti privati laddove la riduzione e la rimozione delle emissioni risultano più convenienti, l’Articolo 6 ha il potenziale di aumentare l’ambizione climatica, trasferire tecnologie e convogliare flussi finanziari dove sono più necessari. A Baku, i mercati del carbonio hanno ricevuto la massima priorità: la presidenza ha spinto fin dal primo giorno per un accordo che approvasse i documenti relativi all’Articolo 6.4 su metodologie e rimozioni. Questi documenti sono stati “adottati” dall’organo di supervisione (SBM) invece che negoziati riga per riga dai paesi. Lo stesso SBM aveva anche predisposto uno strumento obbligatorio per lo sviluppo sostenibile, corredato da salvaguardie ambientali e in materia di diritti umani. Le linee guida sulle metodologie definiscono requisiti per l’adeguamento delle basi di riferimento rispetto alle quali possono essere emessi i crediti di carbonio – un processo volto ad allineare tali basi con gli obiettivi di lungo termine dell’Accordo di Parigi. Vengono inoltre stabiliti controlli sull’addizionalità per evitare che progetti consolidino livelli elevati di emissioni. Un’altra decisione della COP 29, adottata in plenaria conclusiva, incoraggia l’organo di supervisione ad accelerare i lavori sulle basi di riferimento, l’addizionalità e il rischio di inversione delle rimozioni. Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante per le soluzioni basate sulla natura, come la riforestazione, dato che gli incendi boschivi sempre più frequenti potrebbero annullare i guadagni in emissioni. Viene inglobato anche il vecchio il vecchio Clean Development Mechanism (CDM), purché rispetti le regole sulle rimozioni. In pratica, piantagioni di alberi realizzate prima dell’Accordo di Parigi saranno tra i primi progetti ammessi nel nuovo mercato, senza ulteriori controlli sull’addizionalità o sulla reale riduzione delle emissioni tra il 2021 e il 2025. Sebbene questi progetti rappresentino solo una piccola percentuale di quelli del CDM, il loro ingresso nell’Articolo 6.4 potrebbe aprire la strada al riconoscimento delle piantagioni monocolturali come rimozioni valide. La COP 29 ha preso una decisione anche sul commercio di crediti di carbonio da paese a paese, ai sensi dell’Articolo 6.2. L’assenza di regole ufficiali fino a quel momento non aveva impedito ai paesi di concludere accordi bilaterali, molti dei quali segnalati dagli osservatori per la loro evidente mancanza di trasparenza. La decisione della COP 29 richiede una maggiore trasparenza preventiva ai paesi nel reporting sulle loro attività, un punto chiave per paesi e osservatori preoccupati che questo meccanismo possa trasformarsi in un far west selvaggio, dove gli scambi avvengono senza trasparenza. L’ONU afferma che è imperativo tenere presente che il pubblico ha diritto ad accedere alle informazioni sui mercati del carbonio riguardo a prove credibili e verificabili di riduzioni delle emissioni; agli impatti previsti su terre, acque, natura e diritti umani; nonché a chi trae benefici economici dai mercati del carbonio e se i crediti vengano usati per compensare emissioni evitabili. Ciò è ancora più importante in un contesto globale di disinformazione e mistificazione diffuse sui cambiamenti climatici e i loro impatti sui diritti umani. I paesi, tuttavia, hanno accolto con molto favore l’esito. Blocchi come AOSIS, il Gruppo per l’Integrità Ambientale, il Gruppo Africano e l’Australia hanno dato il benvenuto alla decisione sui mercati del carbonio durante la plenaria conclusiva della COP. L’a stessa UE ha dichiarato: “Abbiamo realizzato l’Articolo 6 e questo rappresenta un balzo in avanti. Abbiamo assistito alla conclusione storica del regolamento sui mercati del carbonio. Ora abbiamo standard con il sigillo di approvazione delle Nazioni Unite, e questo stimolerà gli investimenti, aumenterà l’ambizione e porterà trasparenza e standard più elevati. Questa COP ha portato risultati sul finanziamento climatico, ma anche sulla fiducia… regole affidabili sui mercati del carbonio.” Infine, i negoziati di Baku hanno raggiunto un accordo anche sull’Articolo 6.8, relativo alla cooperazione. Clima, biodiversità e desertificazione. La COP 29 è iniziata poco più di una settimana dopo la conclusione della COP 16 sulla biodiversità a Cali, in Colombia. Nonostante ciò, la COP 29 ha visto poche nuove iniziative per affrontare il degrado della natura o i riferimenti alla necessità di affrontare insieme perdita di biodiversità e cambiamento climatico. Durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, a settembre, in vista del vertice di Baku, le presidenze della COP 29 sul clima, della COP 16 sulla biodiversità e della COP 16 sulla desertificazione hanno lanciato un’iniziativa con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra le tre Convenzioni di Rio: la UNFCCC, la CBD e la UNCCD. La presidenza di Baku ha dedicato parzialmente l’ultima giornata tematica, il 21 novembre, alla natura con un evento di alto livello sull’iniziativa. La giornata è coincisa con l’inizio della fase finale dei negoziati, il che ha fatto sì che molti relatori non si presentassero, inclusi i tre presidenti delle Convenzioni. In un evento parallelo, diversi relatori hanno sottolineato la mancanza di nuove iniziative sulla biodiversità alla COP 29 e hanno invitato i delegati a guardare alla COP 30 in Brasile. Un rappresentante del ministero dell’ambiente brasiliano, che lavora sulle sinergie tra clima e natura, ha dichiarato che il suo governo stava collaborando strettamente con la presidenza della COP 16 sulla biodiversità per assicurarsi che la natura sarà al centro della COP 30. Ha aggiunto che il Brasile stava lavorando intensamente alla COP 29 per garantire che la lotta alla perdita di biodiversità fosse inclusa nel dialogo di Dubai, un testo che definisce come portare avanti i risultati del global stocktake di Parigi. La bozza riafferma l’importanza di conservare, proteggere e ripristinare la natura e gli ecosistemi… in linea con il Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal, l’accordo storico sulla natura raggiunto nel 2022.Ancora una volta, la presidenza della COP 29 non è riuscita a trovare un consenso per approvare questo testo, il che significa che la decisione è stata rinviata alla COP 30. Troppo lobbying nelle COP. Le preoccupazioni riguardo al greenwashing e all’attività di lobbying vengono sollevate spesso durante i vertici ONU sul clima. La COP 29, tenutasi nel opetrostato dell’Azerbaigian, non ha fatto eccezione. Prima del vertice, l’amministratore delegato della COP 29 è stato segretamente registrato mentre discuteva di opportunità di investimento nella compagnia statale di petrolio e gas con un uomo che si fingeva potenziale investitore (BBC). Un’altra indagine di Global Witness ha rivelato che oltre 1.700 lobbisti dei combustibili fossili si sono registrati per partecipare alla COP 29. Si tratta di un numero inferiore al record stabilito alla COP 28, ma comunque più alto rispetto alla maggior parte delle delegazioni nazionali. Dal lato agricolo, secondo un’analisi di DeSmog e del Guardian, hanno partecipato alla COP 29 centinaia di lobbisti dell’agricoltura industriale. Più di 200 delegati provenienti da aziende agricole e associazioni di categoria si sono registrati per i colloqui. Quasi il 40% di questi ha viaggiato con le delegazioni ufficiali dei vari paesi, ottenendo così un accesso privilegiato ai negoziati. DeSmog ha inoltre rilevato che 52 delegati del settore carne e latticini hanno preso parte al vertice, di cui 20 all’interno della delegazione ufficiale del Brasile. Tra questi figuravano rappresentanti di grandi multinazionali come JBS (il più grande trasformatore di carne al mondo) e Nestlé (la più grande azienda alimentare del mondo).
Passi avanti a Bonn sul mercato del carbonio? Il primo “dialogo sull’ambizione dell’Articolo 6.2” si è svolto a Bonn. Questo dialogo, organizzato due volte l’anno (una volta a Bonn e una volta durante la COP), mira a offrire uno spazio ai paesi per scambiarsi esperienze su come gli accordi commerciali e gli approcci cooperativi possano sostenere l’ambizione climatica. Alla luce delle gravi preoccupazioni sollevate fino ad ora; mancanza di trasparenza, scarsa qualità dei crediti e benefici discutibili per lo sviluppo sostenibile, ci si aspettava un momento di riflessione onesta. Invece la sessione si è concentrata sulle storie di successo e sulla necessità di rafforzare le capacità per aumentare l’attività di mercato. Molto pericoloso, posto che i crediti di carbonio dell’Articolo 6.2 verranno utilizzati dai paesi acquirenti e dalle aziende per compensare emissioni realmente dannose, indebolendo l’ambizione climatica dei paesi sviluppati e delle industrie inquinanti. I paesi hanno discusso della necessità che chi partecipa all’Articolo 6 abbia obiettivi climatici ambiziosi (NDC), ma in modo sorprendente l’enfasi è stata posta sui paesi venditori di crediti di carbonio, in gran parte paesi in via di sviluppo con un’impronta di carbonio più bassa, piuttosto che sui paesi acquirenti, finora esclusivamente paesi sviluppati con emissioni eccessive. Non c’è stata alcuna richiesta ai paesi acquirenti di avere obiettivi di mitigazione domestica in linea con traiettorie scientificamente fondate e con i progressi necessari a rispettare gli obiettivi di Parigi. Questa omissione è tanto più grave vista la mancanza di un’adeguata ambizione climatica nei paesi sviluppati, che portano la maggiore responsabilità storica e attuale per la crisi climatica. Alcuni di questi, e la stessa UE, stanno considerando di annacquare i propri obiettivi climatici attraverso compensazioni nell’ambito dell’Articolo 6. Non è bastato che l’organismo climatico dell’ONU (SB), presentando i risultati della prima revisione ufficiale degli scambi bilaterali ai sensi dell’Articolo 6.2, abbia rilevato una mancanza di trasparenza e potenziali gravi carenze nei crediti di carbonio pianificati. Poiché il processo di revisione non può valutare pienamente la qualità degli scambi, ci sarebbe stato molto di cui discutere, tanto più che i risultati del primo ciclo di revisioni hanno chiaramente messo in luce i limiti del mandato dei revisori, dato che alcuni approcci cooperativi comportano scambi di crediti normalmente vietati dall’Articolo 6. In linea con la COP 29 i negoziatori a Bonn hanno discusso anche del CDM e di cosa dovrebbe accadere ai suoi oltre 45 milioni di dollari di fondi rimanenti, provenienti da un mix di contributi dei paesi e dalle commissioni di emissione dei crediti. Le opzioni in discussione includevano il trasferimento del denaro al Fondo di Adattamento delle Nazioni Unite o il suo utilizzo per sostenere l’operatività e il rafforzamento delle capacità del meccanismo previsto dall’Articolo 6.4. Si vedrà alla COP 30 per chiudere anni di negoziati su questo tema. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha chiesto che i fondi siano destinati al Fondo di Adattamento. I paesi sviluppati hanno invece spinto affinché il denaro fosse utilizzato per espandere i mercati del carbonio ai sensi dell’Articolo 6.4, o per una combinazione tra Articolo 6.4 e adattamento. Il Brasile e il blocco dei like minded, guidato dall’Arabia Saudita, si sono opposti alla chiusura del CDM e alla riallocazione dei suoi fondi, anche se a Bonn hanno mostrato una posizione leggermente più flessibile. È incoraggiante che a Bonn il Segretariato UNFCCC abbia ribadito chiaramente che i contributi alla mitigazione (MCU) previste dall’Articolo 6.4 non dovrebbero essere utilizzate per compensazioni o rivendicazioni di offset. Piuttosto, dovrebbero servire a sostegno ad azioni per il clima che portino avanti la riduzione delle proprie emissioni dirette. Inoltre quelle azioni vengono conteggiate nell’obiettivo climatico del paese venditore, in cui la mitigazione è avvenuta. Se un’azienda utilizzasse questi crediti per scopi di compensazione, ciò equivarrebbe a un doppio conteggio. Fin dalla COP 27 di Sharm, quando i paesi hanno creato le unità di contributo alla mitigazione, si stabilì che non potessero essere usate per rivendicazioni di compensazione nè per usi volontari da parte delle imprese. Tuttavia l’aria che tira non sembra essere esattamente questa. Allo stato attuale, il regolamento dell’Articolo 6 non è abbastanza solido da garantire il commercio trasparente di crediti di carbonio di alta qualità. L’Articolo 6.2 manca completamente di regole vincolanti sulla qualità dei crediti o di meccanismi di supervisione robusti. È interamente lasciato ai paesi che partecipano all’Articolo 6 definire autonomamente propri criteri credibili di qualità e creare i propri sistemi di responsabilità. Ma finché i paesi non saranno disposti ad affrontare i problemi riscontrati negli scambi condotti finora, è dubbio che la qualità di tali scambi possa migliorare. Si spera nella COP 30. Nel prossimo dialogo sull’ambizione, a Belém, il coinvolgimento degli stakeholder dovrà essere rafforzato invitando più ONG al tavolo, le discussioni dovranno essere più aperte e coinvolgenti rispetto a alle inutili discussioni che finora hanno maliziosamente lasciato travisare scambi inesistenti per acquisire dubbie riduzioni spendendo molto meno. 2025, COP 30_4. L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI è IL FOCUS CENTRALE DEL NEGOZIATO ALLA COP 30 L’adattamento è la seconda scelta tra gli strumenti della lotta al cambiamento climatico, restando prima la mitigazione. Quest’ultima è stata la protagonista principale dell’intera vicenda climatica a partire da Rio, poi Kyoto e Parigi. A Rio 1992 si stabilì di “raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico”. Con il Protocollo di Kyoto del 1997 molte nazioni industrializzate (listate nell’Annesso I) e alcune economie centroeuropee in transizione (Annesso B) concordarono su riduzioni legalmente vincolanti delle emissioni di gas serra fra gli anni 2008 e 2012, in media del 7% rispetto ai livelli del 1990. Infine a Parigi l’obiettivo è stato spostato sull’innalzamento della temperatura media superficiale globale terrestre che deve rimanere, dati scientifici alla mano, entro gli 1,5 – 2 °C a fine secolo.
Per tutto questo il negoziato, che ha concluso la fase di definizione formale degli obblighi per la mitigazione ai sensi dell’Accordo di Parigi, sta portando l’adattamento in primo piano, anzitutto con la ricerca di indicatori condivisi (GGA) capaci di quantificare per ogni paese i risultati degli sforzi per l’adattamento. Il lavoro per definire indicatori che ne possano misurare i progressi, aveva ad un certo punto contato fino a 9.000 potenziali indicatori. A Bonn, nel giugno del 2025, ne restavano 490 e alla COP 30 se ne vorrebbero concordare non più di 100. Inutile dire che le dispute più feroci sono sulla inclusione tra di essi di indicatori dei pagamenti dovuti dai paesi sviluppati. Il CGA è un passaggio obbligato per la stesura dei piani nazionali di adattamento (NAP) che si vuole debbano entrare a far parte degli NDC, le dichiarazioni nazionali volontarie sui singoli sforzi nella lotta di ogni paese al cambiamento climatico. Con esso si dovranno negoziare alla COP 30 il fondo per l’adattamento, la struttura della governance con il Consiglio per l’adattamento e i format sulle comunicazioni sull’adattamento alla Convenzione climatica che i paesi dovranno adottare. Lo stato generale del negoziato sul clima come si è configurato alla Conferenza intersessionale di Bonn del giugno 2025 (fonte: Carbonbrief et al. Elaborazione con Google Gemini AI) Obiettivo globale sull’adattamento. L’adattamento è emerso come tema centrale nelle COP dopo Parigi fino al negoziato di Bonn di giugno, dove è continuata la ricerca di uno o più indicatori di rilievo dell’obiettivo globale sull’adattamento (GGA). A differenza della mitigazione, per la quale esistono metriche chiare di progresso relative alle emissioni nazionali e globali, non ci sono mai stati indicatori concreti e misurabili per monitorare gli sforzi collettivi dei Paesi nell’adattarsi a un clima in riscaldamento. Nel 2023, le parti a Dubai hanno concordato un quadro generale per il GGA, che definiva obiettivi per guidare l’azione in aree chiave come alimentazione, acqua e salute. Il lavoro per definire indicatori che possano essere usati per misurare i progressi in materia di adattamento, aveva ad un certo punto, contato fino a 9.000 potenziali indicatori. A Bonn, ne restavano 490, lontano dall’obiettivo di concordarne 100 alla COP 30, ma sono rapidamente emersi problemi per la mancanza dei testi completi degli esperti. Il dibattito ha riguardato l’inclusione nel CGA dei finanziamenti per il clima (i mezzi di implementazione) e la tempistica degli eventi. È sempre stato un punto all’ordine del giorno molto difficile. L’idea dell’obiettivo è fissare una sorta di riferimento, in modo da poter fissare il livello di adattamento di cui abbiamo bisogno rispetto alle risorse e il relativo divario. In particolare, a partire dalla COP 29 di Baku, il nuovo obiettivo collettivo quantificato (NCQG) per il finanziamento climatico internazionale ha creato contrasti e le questioni relative ai fondi per l’adattamento hanno attraversato tutti i negoziati per concludersi alla fine in uno stallo ed una impasse sulle decisioni finanziarie con i paesi sviluppati contrari, mentre i paesi in via di sviluppo ne hanno sottolineato l’importanza, compresa la collocazione negli NDC nazionali. I paesi sviluppati chiedono ai paesi in via di sviluppo di dichiarare quanto del proprio bilancio destinano all’azione per il clima, compreso l’adattamento. Queste informazioni potrebbero però essere usate contro di loro quando chiedono assistenza. Il G77 e la Cina hanno denunciato la crescita del divario di finanziamenti per l’adattamento. Alla COP 26 di Glasgow i paesi avevano concordato l’obiettivo di raddoppiare i finanziamenti climatici per l’adattamento tra il 2019 e il 2025. Il rapporto UNEP del 2024 ha rilevato che i flussi di finanziamento pubblico per l’adattamento verso i paesi in via di sviluppo sono aumentati da 22 nel 2021 a 28 miliardi di dollari nel 2022, il maggiore incremento assoluto anno su anno dall’Accordo di Parigi. Tuttavia anche se questa tendenza continuasse e l’obiettivo di raddoppio venisse raggiunto entro il 2025, ciò coprirebbe solo circa il 5% del fabbisogno. La scadenza di tale obiettivo è prevista per novembre e con i paesi sviluppati non riusciranno a raggiungerlo. Si parla allora di triplicare i finanziamenti per l’adattamento, anche da parte di gruppi della società civile.
Un secondo testo provvisorio è stato prodotto il 24 giugno. Conteneva ancora molti elementi tra parentesi su cui non si era ancora raggiunto un accordo o elencati come opzioni. Era già successo a Baku, quando si cercò di ammorbidire il linguaggio passando da MoI (denaro) a strumenti abilitanti per l’attuazione et similia o ad altri termini. Alla fine di tutto un accordo sul GGA non è stato raggiunto. Le sezioni relative al BAR e all’adattamento trasformativo sono state rimosse dalle conclusioni provvisorie, con un paragrafo finale che ha precisato che invece verranno incluse in una nota informale, che servirà come base per i negoziati alla COP 30. Fortunatamente c’è stato un accordo generale sul fatto che la priorità va data agli indicatori del GGA. Per quanto riguarda il MoI si stabilisce che gli indicatori per i mezzi di attuazione e altri fattori che consentono l’attuazione delle azioni di adattamento devono essere inclusi, e quelli non pertinenti all’Accordo di Parigi devono essere rimossi. In rosso le ondate di calore dell'inverno 2025 Il testo adottato a Bonn rappresenta un compromesso, ma contiene comunque importanti progressi per i paesi in via di sviluppo, soprattutto nell’allontanarsi dal linguaggio ambiguo di Baku. Il testo invita gli esperti a continuare a lavorare sugli indicatori, a presentare un rapporto tecnico finale e un elenco di potenziali indicatori al segretariato nell’agosto 2025. Ciò consentirà ulteriori negoziati alla COP30 per ridurre progressivamente la lista degli indicatori nell’ambito del GGA, verso l’obiettivo dei 100 indicatori.
Alla COP 29,
nonostante alcuni progressi nei negoziati, le discussioni sui Piani
nazionali di adattamento (NAP) si erano concluse senza un accordo. Altre questioni insolute rimanevano sul fondo per l’adattamento, sul consiglio per l’adattamento e sulle comunicazioni. Sul fondo per l’adattamento le parti si sono concentrate sulla composizione del consiglio del fondo, sulla sua quinta revisione e sugli accordi affinché serva esclusivamente l’Accordo di Parigi ma le parti sono riuscite ad accordarsi solo su conclusioni procedurali. Durante i negoziati sulle comunicazioni sull’adattamento, le parti hanno discusso della necessità di ulteriore supporto ai paesi in via di sviluppo, dei limiti nella stesura di un modello universale per le comunicazioni e della necessità di ulteriori iniziative di formazione. Numerosi testi sono stati prodotti durante le due settimane di Bonn, con il principale risultato di evidenziare la necessità di estendere il termine per le parti per inviare contributi a supporto di un rapporto di sintesi sulle comunicazioni sull’adattamento. I disaccordi persistono su questioni complesse di governance, in particolare se il Consiglio debba servire l'Accordo di Parigi o la UNFCCC. Nonostante le minime divergenze, il 23 giugno sono state pubblicate le bozze di conclusioni. L'attenzione principale è rivolta al rafforzamento della collaborazione con i diversi detentori di conoscenza e al riconoscimento dell'importanza del tema. A fine conferenza gli LDC hanno espresso profonda delusione per gli ostacoli che ancora affrontano nell'ottenere finanziamenti per l'adattamento, in particolare per i NAP), definendo la mancanza di risorse "non solo frustrante, ma soprattutto scoraggiante”.
2025, COP 30_3. DI RIFORMA COP SI PARLA PER LINEE INTERNE, PERFINO NEGLI ORGANI TECNICI DELL'UNFCCC I colloqui di Bonn. Gran parte della narrazione sulla COP 29 a Baku si è concentrata sulle minacce al multilateralismo. Sette mesi dopo, in occasione dei colloqui di Bonn del 2025, la situazione geopolitica è ulteriormente peggiorata. L'escalation dei conflitti, i tagli agli aiuti esteri e gli sforzi delle grandi potenze per indebolire le istituzioni globali hanno un impatto sulla politica climatica. Gli Stati Uniti, che si sono ritirati dal processo climatico internazionale e non hanno inviato negoziatori a Bonn, sono stati al centro di tutte queste questioni. In questo contesto, e con il 2025 che segna un decennio dall'Accordo di Parigi, molti hanno iniziato a riflettere su come le trattative sul clima delle Nazioni Unite possano essere riformate. Ciò è stato riconosciuto dalla presidenza brasiliana della COP 30 in una lettera, in cui si affermava: "Riconoscendo le crescenti richieste di cambiamento alle COP, la presidenza della COP 30 invita tutte le parti a riflettere sul futuro del processo stesso". Una parte dei negoziati di Bonn a giugno ha affrontato direttamente questo tema. Una nota del segretariato della UNFCCC ha riconosciuto la crescente portata e complessità delle trattative climatiche, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di punti all'ordine del giorno e degli eventi. Tenendo conto di ciò, i paesi hanno utilizzato le sessioni sui meccanismi per le riunioni intergovernative (AIM) per discutere come rendere il processo più efficiente. Le proposte includevano:
Nonostante queste discussioni, alla fine dei colloqui a Bonn, sembra che le parti volessero continuare a discutere i modi per aumentare l'efficienza del processo sol perché non sono riuscite a raggiungere un accordo su molte delle proposte concrete. È da notare che, sebbene le discussioni AIM siano solitamente limitate alle sessioni dei Subsidiary Bodies, SB, a Bonn, le parti hanno deciso di continuarle alla COP 30. Le discussioni AIM erano solo una parte delle più ampie richieste di riforma. Ci sono anche questioni più profonde di cui la UNFCCC e tutte le parti qui presenti devono far parte. Domande su cosa ci stia impedendo di compiere il salto verso un percorso realmente trasformativo. Queste idee hanno dato luogo a un appello congiunto per una riforma urgente delle trattative sul clima delle Nazioni Unite, sostenuto da oltre 200 gruppi della società civile e pubblicato durante i colloqui degli SB. Una proposta che ha attirato l'attenzione è la deliberazione a maggioranza se le trattative non riescono a raggiungere il consenso, il che impedirebbe alle singole nazioni di bloccare il progresso. Un'altra idea, scaturita dalle ultime COP nei petrostati che le hanno ospitato negli ultimi anni, si potrebbe sintetizzare in una richiesta di garantire l'integrità delle presidenze della COP. Non è molto rispetto a quanto si discute nel mondo e al livello delle preoccupazioni, ma è pur sempre iun segno di vita dall'interno del processo. La lettera del Club di Roma. Nel pieno della COP 29 di Baku, il 18 novembre 2024, con la firma di Tubiana, Robinson, Ban-ki moon, Rockstrom, e molti altri, il Club di Roma manda una lettera al Segretario Generale Guterres nella quale si propone, né più ne meno, lo smantellamento del formato COP nella sua forma attuale. Un’attuazione efficace degli Accordi di Parigi, ormai formalmente finalizzati per intero, richiede una riforma urgente del processo delle COP. Le Nazioni Unite devono cambiare passo e concentrare tutti gli sforzi sulla realizzazione degli obiettivi e degli impegni globali in vista del 2050, colmando il divario tra scienza e azione ed impedendo che le crisi attuali ritardino i progressi. La struttura della COP, basata sul consenso, favorisce solo lenti progressi incrementali: Nel frattempo, le emissioni e le temperature globali continuano ad aumentare e gli eventi climatici estremi si verificano con maggiore frequenza e intensità del previsto. L’unico modo per rispettare il limite di 1,5 °C è ridurre le emissioni globali di circa il 50% entro il 2030 e continuare a tagliarle del 50% per decennio, fino a raggiungere un’economia mondiale a emissioni nette zero entro il 2050-2060. Siamo invece di fronte a una contraddizione drammatica tra ciò che la COP dovrebbe realizzare e l’inerzia che caratterizza il negoziato.
È assurdo non riuscire nemmeno a raggiungere un consenso sul fatto che il mondo debba iniziare ad eliminare gradualmente i combustibili fossili a causa degli interessi legati all’energia fossile. Le UN e i leader nazionali e locali in tutto il mondo, hanno dichiarato lo stato di emergenza planetaria. Tuttavia, i governi – alle prese con gli effetti combinati della pandemia da COVID-19, del cambiamento climatico e dei conflitti – usano gli impatti economici e le spinte inflazionistiche correlate per frenare l’ambizione climatica e ritardare l’azione per una transizione giusta. Un’attuazione efficace richiede una riforma del processo COP, trasformando gli incontri da negoziati chiusi su dichiarazioni annuali e testi legali in piattaforme multi-stakeholder per l’attuazione, la responsabilità, il finanziamento e lo scambio di esperienze. Occorre:
Per raggiungere questi obiettivi, sei pilastri devono essere riportati urgentemente al centro del processo COP: lo scambio di conoscenze e delle tecnologie; l’allineamento dei piani di mitigazione con la scienza; l’adattamento; la finanza; l’attuazione e responsabilità tramite misurazione, reporting e verifica. Le riunioni COP possono assumere diversi formati per raggiungere l’obiettivo di accelerare l’attuazione. Il passo più trasformativo sarebbe abbandonare completamente l’attuale struttura con zone separate dai negoziati, riducendo drasticamente la dimensione delle COP e ripensandole come sessioni di reporting, contabilità e lavoro operativo, con rappresentanti di tutti i gruppi di stakeholder riuniti in uno o più incontri globali che portino risultati concreti. Concentrare l’attenzione sull’attuazione non significa ridurre l’importanza del coinvolgimento degli stakeholder. Al contrario, facilitare il dialogo multi-stakeholder e garantire rappresentanza equa e accesso trasparente al processo politico dovrebbero essere elementi centrali della riforma. In alternativa, un processo COP ristrutturato potrebbe assumere un formato ibrido: ad esempio, una grande conferenza ogni tre anni, focalizzata su eventi pubblici ed esterni e sulla presentazione di soluzioni da parte di diversi attori; negli altri anni, i negoziatori si riunirebbero a Bonn per approvare formalmente documenti di lavoro già negoziati, garantendo continuità ai progressi. L’obiettivo di questi momenti pubblici sarebbe assicurare un circuito di feedback efficaci tra tutti gli attori rilevanti – governi, settore privato, società civile, giovani e comunità indigene – affinché idee e proposte alimentino i negoziati, in linea con gli obiettivi climatici stabiliti a Parigi. Liste di allineamento degli Stati con l’obiettivo di 1,5°C dovrebbero essere pubblicate dal segretariato UNFCCC ed esposte pubblicamente in tutte le COP, per evidenziare quali paesi stiano davvero facendo progressi evidenziando per tutti: eliminazione graduale dei combustibili fossili; trasformazione del sistema alimentare; tutela degli stock e della capacità di assorbimento del carbonio negli ecosistemi intatti; aumento degli stock e della capacità di assorbimento in aree gestite (riforestazione, ripristino degli ecosistemi); adozione di soluzioni basate sulla natura;diffusione su larga scala delle tecnologie di emissioni negative (CCS, BECCS, CDR, DAC). Oltre a ciò, devono essere garantiti adattamento e resilienza, giustizia ed equità finanziaria, e compensazioni per perdite e danni e, infine, gli avanzamenti degli NDC. Per raggiungere un mondo a +1,5°C, non possiamo più perdere tempo in negoziazioni infinite che rischiano di farci arretrare invece di portare risultati. Per concentrarsi sull’attuazione, le UN devono ora garantire che le COP siano strutturate per avere successo. Questo richiederà un cambiamento radicale rispetto all’attuale formato, per assicurare uguaglianza e diversità nella rappresentanza; sicurezza e tutela dei diritti umani di tutti i delegati, statali e non statali; un ambiente sicuro e affidabile per il dialogo e lo scambio. La proposta è la seguente:
I distinguo di Laurence Tubiana e l'appello all'Europa. Laurence Tubiana, direttrice della European Climate Foundation, ha commentato la lettera aperta sulla riforma delle COP con una prospettiva sfumata. Ha riconosciuto le frustrazioni legate alla lentezza dei negoziati multilaterali sul clima, soprattutto considerando l’urgenza di accelerare l’azione. Tuttavia ha sottolineato la cruciale importanza del multilateralismo come fondamento dei progressi climatici, affermando: L’Accordo di Parigi è stato raggiunto perché tutti i Paesi – grandi e piccoli, ricchi e poveri – sono stati inclusi. La sua legittimità deriva dalla sua natura multilaterale. Ha ammesso che le riforme sono necessarie, in particolare per rafforzare la responsabilità, migliorare l’attuazione e amplificare le voci degli attori in prima linea e subnazionali. Ciononostante, ha messo in guardia dal mettere da parte il processo di costruzione del consenso, che favorisce fiducia e legittimità. Ha inoltre difeso il sistema della presidenza a rotazione delle COP, definendolo un elemento essenziale che consente a tutti i Paesi di assumere la guida, pur ricordando la responsabilità delle nazioni ospitanti di agire con imparzialità e di mantenere l’integrità scientifica. Secondo lei, le COP devono restare luoghi di azione climatica collettiva e non piattaforme dove singoli settori promuovono agende controproducenti per i progressi sul clima. Un uso improprio del ruolo di presidenza, ha avvertito, potrebbe compromettere la credibilità internazionale e indebolire la fiducia necessaria alla cooperazione globale. Durante una visita in Finlandia del giugno scorso la Tubiana ha aggiunto che L’Europa rimane l’unica regione al mondo ad aver avuto successo nel ridurre le proprie emissioni, mantenendo al contempo un forte contratto sociale. La politica climatica deve essere perseguita a tutti i livelli di governance e della società. Per garantire che la transizione proceda nei tempi previsti, è essenziale sia implementare misure efficaci sia comunicare chiaramente che questo non è un progetto guidato da élite, ma un cambiamento che porta benefici a tutti.
L’Europa
deve mantenere il percorso di azione climatica. Sebbene la transizione sia
stata lenta, i progressi sono indiscutibili: le vendite di veicoli elettrici
stanno aumentando rapidamente, la produzione di energia rinnovabile cresce e
un numero significativo di paesi ha ora fissato obiettivi di zero emissioni
nette. I paesi nordici sono stati pionieri nella politica climatica
internazionale dagli anni ’80 e ’90. Tubiana li ha incoraggiati a continuare
a svolgere questo ruolo soprattutto ora, quando l’Europa nel suo insieme
deve dimostrare di poter guidare il processo. La cooperazione internazionale
è fondamentale. Tubiana ha espresso serie preoccupazioni sul fatto che componenti essenziali del quadro ambientale e di sostenibilità dell’UE, incluse le disposizioni relative al clima della Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale (CSRD), possano essere indebolite nel processo legislativo legato all’iniziativa OMNIBUS. Ha esortato gli stakeholder a interagire attivamente con Parlamento e Commissione europea nei prossimi mesi per garantire che il vantaggio competitivo costruito dalle aziende all’avanguardia non venga perso.
2025, COP 30_2. Un parere ottimistico sulla riforma del processo delle COP Elaborazione da dati di Carbonbrief mediante AI ChatGPT
Naturalmente, dice Betts, l’UNFCCC e il processo delle COP presentano delle carenze. Ad esempio, sarei il primo a riconoscere che i progressi in materia di finanza, adattamento e perdite e danni sono stati troppo lenti. Tuttavia, sostengo che non ci sarebbe stato alcun progresso senza il dibattito globale centrale garantito dalle COP, nelle quali i paesi vulnerabili hanno sempre avuto una voce forte. L’alternativa alle COP – spesso proposta da paesi grandi e potenti – è di spostare tutto all’interno del G20, magari con forme di cooperazione plurilaterale tra grandi stati. Nessuno sarebbe più felice di vedere la fine del processo delle COP rispetto agli interessi del petrolio e del gas negli Stati Uniti, che hanno cercato di indebolire le COP durante ogni fase del negoziato. L’esclusione dei paesi vulnerabili portava a risultati con minore ambizione, con i quali Stati Uniti ed economie emergenti si sentivano a proprio agio. Ma per i paesi vulnerabili perdere le COP, significa essere ridotti al silenzio. In generale il valore di mantenere un forum globale, in cui tutti hanno un posto al tavolo e, quindi, i più vulnerabili hanno voce, sia evidente, e questo è l’UNFCCC. È un momento politico indispensabile ogni anno per mobilitare le forze dell’ambizione sul clima. Ci sono, tuttavia, due miglioramenti che si potrebbero apportare al funzionamento delle COP. Introdurre un secondo global stocktake. I bilanci ufficiali avvengono ogni cinque anni, due anni prima dei successivi cicli quinquennali di rilancio delle ambizioni delle COP (come Parigi e Glasgow). Ma i media e le ONG dedicano pochissima attenzione agli annunci degli NDC, in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo. In vista dei bilanci quinquennali, dovrebbe esserci un momento – magari a un terzo dell’anno – per verificare dove ci troviamo, individualmente e collettivamente, sulla base degli NDC annunciati. Se le proposte di alcuni paesi sono deboli, dovrebbero essere messi sotto pressione per fare di più; se altri non hanno presentato alcuna proposta, ciò dovrebbe essere messo in evidenza. È improbabile che le grandi economie accettino un cambiamento formale del processo. Tuttavia, la società civile dovrebbe creare questo momento al di fuori del processo formale, con analisi e eventi mediatici, per offrire l’occasione di valutare e mettere sotto pressione i contributi proposti. L’appartenenza agli Annex. In secondo luogo, dovremmo rivedere l’appartenenza agli allegati della Convenzione, che stabiliscono chi è sviluppato e chi è in via di sviluppo. Serve un cambiamento radicale nel sostegno alle economie emergenti, per aiutarle nella transizione a basse emissioni di carbonio, che oggi è sempre più accessibile e porta anche altri benefici. Ciò significa molto più finanziamento dai paesi dell’Annex II, integrato da contributi di Cina e degli Stati del Golfo, che si sono arricchiti vendendo combustibili fossili. Dubito che sarà possibile negoziare modifiche alla composizione degli allegati, nonostante la Convenzione prevedesse che ciò dovesse avvenire già entro il 1998. I paesi non inclusi nell’Annex I oggi rappresentano quasi due terzi delle emissioni globali e costituiranno probabilmente una quota ancora maggiore della crescita futura delle emissioni. Se vogliamo limitare il cambiamento climatico, è su queste emissioni che dobbiamo concentrarci soprattutto, con azioni più rapide dei paesi dell’Annex I, magari con emissioni negative, e da un aiuto molto più serio ad alcuni paesi non appartenenti all’Annex I. 2025, COP 30_1. NEL DECENNALE DI PARIGI PREVALGONO PREOCCUPAZIONI E Scoraggiamento Elementi di uno studio mediante l'AI Gemini su un database di Carbonbrief Ad un decennio dall'Accordo di Parigi, è cresciuto il malcontento per il processo climatico dell'ONU. I critici affermano che i colloqui non stanno facendo abbastanza per accelerare la riduzione delle emissioni, affrontare i combustibili fossili o raccogliere fondi per il clima per i paesi in via di sviluppo. Figure influenti nella politica climatica e nei gruppi della società civile affermano che le COP hanno bisogno di una revisione urgente. Questo è stato riconosciuto dalla presidenza brasiliana della COP30, che ha preso atto delle crescenti richieste di cambiamento e ha chiesto alle parti di riflettere sul futuro del processo stesso in un contesto di preoccupazioni per la crisi del multilateralismo, conflitti diffusi e l'escalation dei pericoli climatici. Proponiamo di seguito una raccolta delle opinioni più autorevoli sulle tematiche critiche. L'Accordo di Parigi è stato un successo? Parigi ha funzionato bene per alcuni aspetti (Stern), incluso il rafforzamento dei suoi obiettivi di temperatura ed emissioni alla luce dell'evoluzione scientifica. Ha anche portato a un primo bilancio globale che ha richiesto di triplicare l'energia rinnovabile e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030 e di abbandonare i combustibili fossili al fine di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Parigi rimane uno degli sforzi multilaterali di maggior successo nella storia recente. Ha realizzato ciò che pochi pensavano possibile: un accordo tra quasi 200 paesi su una questione globale che va al cuore della sovranità nazionale, dei modelli economici e della politica interna. Le ultime COP hanno trovato un accordo per la transizione dai combustibili fossili – non è un'impresa da poco. Prima di Parigi, il mondo era sulla buona strada per un catastrofico riscaldamento di 4-5 °C. Gli impegni di oggi, sebbene ancora inadeguati, hanno piegato quella curva più vicino a 2,5-3 °C, ancora poco, ma significativo. Piuttosto che soffermarsi sulle imperfezioni del sistema, la questione è se possa evolvere, realisticamente e politicamente. Smantellare il sistema attuale è improbabile che produca un sistema più forte o più equo con l'autorità di annullare le decisioni nazionali. All'indomani di ogni COP, ci sono appelli per riformare la Convenzione, ma dovremmo puntare a un'evoluzione, non a una rivoluzione, per tre ragioni. In primo luogo, una rivoluzione quasi certamente non si tradurrebbe in qualcosa di più forte di quello che abbiamo già. È difficile immaginare che sarebbe possibile adottare l'Accordo di Parigi nell'attuale contesto geopolitico ed economico. In secondo luogo, l'Accordo di Parigi sta funzionando, anche se non abbastanza velocemente. In terzo luogo, e soprattutto, le maggiori barriere al fal rispetto dell'Accordo di Parigi sono le carenze nella politica globale. Nessuna modifica del processo delle COP può superarle.
emissione globali di CO2 Come potrebbero essere migliorati i negoziati stessi? È tempo di riconoscere pienamente che c'è una crisi di fiducia nel processo climatico dell'ONU e di prendere misure appropriate per limitarla. Le parti diffidano tra loro e gli stakeholder sono frustrati dei risultati limitati dopo 30 anni di colloqui sul clima. Il processo di negoziazione può essere frustrante, rimane però essenziale. Converrebbe rendere il carico di lavoro più gestibile, raggruppando gli argomenti all'ordine del giorno e organizzando il lavoro su base pluriennale cercando di dare abbastanza tempo a ogni punto, piuttosto che affrontare tutto insieme ogni volta, e sviluppare la consapevolezza che non ogni punto ha bisogno di un risultato ad ogni riunione. Potremmo... snellire gli ordini del giorno ripetitivi e sovraccarichi, ed elevare la responsabilità dei presidenti della COP attraverso un giuramento pubblico, potenzialmente amministrato dal bureau dell'UNFCCC, che ricordi alla presidenza della COP il suo ruolo (Figueres).Molte delle inefficienze percepite non sono difetti in quanto tali, ma sono inerenti a un processo globale in cui tutte le nazioni sono sovrane e uguali – e tutti vogliono dire la loro. Sono anche inerenti alla questione stessa del cambiamento climatico, che genera un'agenda in continua espansione, attirando sempre più partecipanti del governo e della società civile. Le mosse per ristrutturare i negoziati si scontrano inevitabilmente con forze potenti che sanno come massimizzare la loro influenza nel sistema esistente e preferiscono di gran lunga lo status quo. Le COP dovrebbero evitare negoziati affrettati a porte chiuse senza consultazioni delle parti, che rendono impossibile l'attuazione. Quando il testo della bozza appare all'undicesima ora e viene inoltrato alla plenaria di chiusura senza una discussione adeguata, le possibilità che le parti si ingannino a vicenda sul reale significato del testo si moltiplicano. Un linguaggio come "transizione dai combustibili fossili" o il percorso verso la "Tabella di marcia da Baku a Belém per 1,3 trilioni di dollari", dove la formulazione non è chiara, consente alle parti di scegliere l'interpretazione più favorevole, minando l'attuazione di decisioni che erano già difficili da raggiungere. Snellire gli ordini del giorno e limitare le dimensioni delle delegazioni governative sono cose per cui vale la pena lottare, ma imporre criteri per la selezione dei paesi ospitanti delle COP e escludere le aziende private coinvolte in attività ad alta intensità di carbonio non è possibile (Depledge). Se il vero problema è che la COP non sta prendendo decisioni in linea con la scienza, allora la risposta non è armeggiare con la procedura. Ciò che serve è un ripensamento strategico importante e riforme più fondamentali. Il processo deve cambiare (Singh), snellire i negoziati, rivedere le regole del consenso e vietare ai lobbisti dei combustibili fossili di influenzare i testi. Porre al centro le voci dei popoli indigeni, delle comunità in prima linea e della società civile. E aumentare i finanziamenti pubblici per il clima per consentire una transizione giusta e un vero sostegno per l'adattamento e l'affrontare le perdite e i danni. Il recente parere consultivo della Corte internazionale di giustizia ha rafforzato la richiesta di risarcimenti climatici. La COP30 deve aprire una nuova era di responsabilità e giustizia. I colloqui sul clima dell'ONU possono guidare tagli più rapidi alle emissioni? L'UNFCCC è efficace solo nella misura in cui le parti lo consentono. L'Accordo di Parigi sta funzionando esattamente come alcuni temevano e come alcuni dei principali paesi emettitori speravano. Si basa sulla promessa di trasparenza: che i rapporti nazionali e il bilancio globale, in qualche modo ispireranno l'ambizione climatica. Ma la trasparenza non è la stessa cosa della responsabilità. Il regime di Parigi stesso ha un ruolo importante da svolgere. Per cominciare (Stern), il regime deve sviluppare molto di più una partnership ampia nello spirito della Coalizione ad alta ambizione del 2015. Certo, Parigi è stata costruita sul principio dei "contributi determinati a livello nazionale" e quel principio non può essere buttato a mare. Ma Parigi è stata anche costruita sulla promessa che si sarebbe sforzati di prevenire un pericoloso cambiamento climatico, che i nuovi obiettivi di emissione ogni cinque anni avrebbero riflesso la massima ambizione possibile dei paesi e che i bilanci globali avrebbero, di fatto, fatto il punto della situazione. La natura determinata a livello nazionale degli NDC e il fatto che nessuna valutazione dei progressi venga formalmente fatta al di fuori del periodo di cinque anni del bilancio globale, significa che il divario di ambizione diventerà più difficile da colmare quanto più urgente diventerà colmarlo. L'ironia è che l'architettura di Parigi è stata fatta su misura per accogliere le idiosincrasie degli Stati Uniti, che si sono ripetutamente ritirati dall'accordo. Un approccio basato sull'ambizione comporta estrarre dichiarazioni nazionali di intenzione di riduzione delle emissioni, sfruttando la denuncia pubblica dei paesi e rafforzando gli impegni attraverso una maggiore responsabilità. Ma le condizioni non sono favorevoli a questo approccio. La politica nazionale raramente privilegia la riduzione delle emissioni rispetto ad altri obiettivi e la politica globale è sempre meno reattiva allo shame climatico. Al contrario, le condizioni per un approccio di apprendimento attraverso l'azione sembrano più promettenti. Non c'è nulla negli NDC che dica che i paesi non possono essere interrogati, spronati e criticati (Stern). Proteggere i permalosi non è così importante quanto proteggere un mondo abitabile. Gli NDC potrebbero essere liberati per essere modelli di sperimentazione piuttosto che basi rigide solo per la responsabilità (Dubash). Percorsi dettagliati di sviluppo a basse emissioni di carbonio a livello settoriale metterebbero in evidenza le comunanze dei paesi, rivelerebbero un ambito produttivo per la cooperazione internazionale e incentivarebbero i finanziamenti... Un processo internazionale rinnovato dovrebbe essere focalizzato sul lavoro duro e dettagliato per consentire transizioni di sviluppo a basse emissioni di carbonio e resilienti e meno sulle di dichiarazioni di intenti. Dovremmo passare a un approccio in cui i progressi sono misurati prevalentemente dall'impatto delle politiche attuate a livello nazionale, non dagli NDC sulla carta. Come possono le COP garantire una maggiore responsabilità? L'opportunità più grande per sostenere l'implementazione si trova al di fuori del processo formale, mettendo ordine e struttura nell'”agenda d'azione. Questa agenda è cresciuta enormemente negli ultimi anni e ci sono state molte iniziative preziose. Tuttavia, non c'è stata sufficiente continuità e non sono stati fatti abbastanza follow-up e monitoraggi per garantire che ciò che viene annunciato e promesso venga poi realizzato. Interessante la proposta della presidenza brasiliana entrante della COP30 di strutturare l'agenda d'azione attorno a sei ampi temi, tratti dai risultati del bilancio globale, incluso un tema trasversale sugli elementi abilitanti, come il ruolo vitale della finanza. All'interno dei negoziati, c'è un'evidente necessità di monitorare i numerosi impegni presi al di fuori del processo di negoziazione regolare, sia nelle dichiarazioni guidate dalla presidenza che nelle decisioni di copertura (Allan). Ciò che deve cambiare è il funzionamento del sistema. Ogni dieci anni circa, il regime climatico si è adattato, passando dal legalismo top-down di Kyoto alla flessibilità determinata a livello nazionale di Parigi (Lee). Questi cambiamenti non sono stati solo filosofici, ma hanno anche permesso nuove capacità. Il crollo di Copenaghen ha contribuito a catalizzare i piani di investimento nelle energie rinnovabili, mentre Parigi ha introdotto i NDC. La prossima fase deve integrare più a fondo nel processo la realizzazione e l'equità, includendo, per esempio, meccanismi che allineino i piani di transizione aziendale con la transizione dei paesi, le politiche nazionali e i percorsi settoriali. I risultati di qualsiasi processo di riforma dovrebbero significare meno teatralità, decisioni più rapide e una maggiore responsabilità. Tutto ciò migliorerebbe non solo il coinvolgimento dei paesi ma anche quello del pubblico, così come la credibilità del processo climatico globale. Invece di catalizzare l'ambizione, l'Accordo di Parigi è stato utilizzato dai paesi sviluppati per sottrarsi alle loro responsabilità storiche (Singh). Non sono l'Accordo di Parigi o l'UNFCCC ad aver fallito, sono i paesi ricchi che hanno minato il sistema per proteggere gli inquinatori e preservare un modello di crescita insostenibile. Le nazioni ricche devono essere ritenute responsabili per le loro emissioni storiche e devono pagare per le perdite e i danni che hanno causato. Ambizione e implementazione non sono necessariamente complementari. La prima è guidata da una concentrazione incessante sulle emissioni, sulla comparabilità degli impegni di emissione e sulla costruzione della responsabilità. La seconda è resa possibile collegando il clima ad altri obiettivi, cercando formulazioni specifiche per i paesi che ottengano sostegno politico e una sperimentazione flessibile che consenta di imparare dal fallimento. Scendere di più, non di meno, nei dettagli settoriali potrebbe rivelare opportunità non evidenti dalle altezze stratosferiche dei negoziati sul clima. L’altro punto è che rafforzare l'applicazione degli obiettivi climatici attraverso la supervisione scientifica, la revisione tra pari (peer review) e una rendicontazione solida, garantendo che governi, presidenze delle COP e aziende siano ritenuti responsabili (Club di Roma). Dovrebbe esserci un organo consultivo scientifico permanente all'interno della COP. La scienza deve essere centrale nei negoziati, con tutte le delegazioni regolarmente informate sugli ultimi dati relativi a rischi, equità, soluzioni e scenari. I colloqui sul clima delle Nazioni Unite hanno bisogno del voto a maggioranza? Il voto è l'argomento tabù. I Paesi firmatari dell'UNFCCC non sono mai stati in grado di adottare le regole di procedura perché non riescono a trovare un accordo sulla disposizione relativa al voto in assenza di consenso. Invece, procedono riunione dopo riunione usando le regole come bozze di regole di procedura. Ciò ha creato una corsa al ribasso in cui i paesi che vogliono ostacolare i progressi possono farlo. Per 29 anni, gli altri Paesi hanno dovuto accettare il minimo comune denominatore in nome del consenso. La decisione presa nel 2023 di abbandonare gradualmente i combustibili fossili ha bisogno sia di essere dettagliata che di essere monitorata, ma non è presente da nessuna parte nei negoziati formali in vista di Belém. Tali omissioni riflettono un problema fondamentale dell'UNFCCC e un difetto fondamentale dell'Accordo di Parigi: la regola del consenso. Alcuni paesi stanno ora sfacciatamente facendo marcia indietro sul loro precedente impegno e affermano che qualsiasi menzione di riduzione dei combustibili fossili in qualsiasi contesto è per loro una linea rossa. Una manciata di paesi tiene in ostaggio il futuro dell'umanità perché, a causa della regola del consenso, può bloccare tutto ciò che vuole. Anche le presidenze delle COP che vogliono far progredire l'agenda hanno paura di essere audaci, per timore che il processo si paralizzi. Nel contesto dei negoziati formali, potremmo riconsiderare la nostra tradizione di dover adottare tutte le decisioni all'unanimità. Le procedure dell'UNFCCC richiedono il consenso per l'adozione delle decisioni, non necessariamente l'unanimità. La differenza è importante e, certo, difficile da gestire, ma vale la pena esaminarla (Figueres). Negli ultimi mesi, molti critici hanno dichiarato la crisi il processo climatico multilaterale delle Nazioni Unite rotto, sostenendo che dovrebbe essere smantellato e sostituito, ma non ci sono alternative valide sul tavolo. Riformare le procedure di base, come introdurre il voto a maggioranza o modificare la convenzione, richiederebbe l'accordo di tre quarti dei paesi, seguito dalla ratifica nazionale. Anche senza l'attuale geopolitica fratturata, questo sarebbe un compito arduo. Quale dovrebbe essere il ruolo della presidenza della COP? Le COP dovrebbero evitare di aggiungere ulteriore pressione chiarendo i doveri e i processi per il presidente della COP. Le regole di procedura danno semplicemente al presidente della COP il potere di condurre formalmente i negoziati, cosa che dovrebbe essere fatta in modo neutrale. Sempre più spesso, vediamo i presidenti della COP stabilire piani eccessivamente ambiziosi per le rispettive COP. Le idee di successo permeano quello che dovrebbe essere un ruolo di facilitazione verso il progresso collettivo dei colloqui sul clima delle Nazioni Unite. Le COP si concludono con dichiarazioni e resoconti di risultati che non riflettono i progressi effettivi. La revisione della conduzione dei negoziati e del ruolo e delle aspettative delle presidenze della COP potrebbe aiutare a ripristinare parte della fiducia danneggiata nel processo. L'agenda d'azione deve sfuggire al vizio che le mutevoli presidenze e i campioni di alto livello le hanno imposto, in cui i nuovi annunci prevalgono sulla realizzazione (Hale). Solo i paesi con un'elevata ambizione climatica dovrebbero essere idonei a ospitare le COP (Club di Roma). La presidenza della COP potrebbe mostrare una manciata di progetti di energia rinnovabile su larga scala nei propri paesi, sostenuti da finanziamenti concreti. Tale funzione aiuterebbe a colmare il divario sempre più ampio tra ciò che viene concordato alle COP e ciò che accade sul campo. Le aziende di combustibili fossili hanno troppa influenza? La sopravvivenza dell'industria dei combustibili fossili dipende dal fallimento dell'UNFCCC, poiché il raggiungimento degli obiettivi dell'UNFCCC e dell'Accordo di Parigi significa innegabilmente l'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Non c'è quindi da meravigliarsi se, fin dall'inizio, i lobbisti dell'industria dei combustibili fossili siano stati presenti alle COP e abbiano lavorato per minare l'ambizione. Le presidenze hanno molto di cui rispondere e possono essere fondamentali per aumentare la responsabilità. La COP sta diventando la nuova Davos: un luogo d'incontro per miliardari, senza un controllo scrupoloso delle loro attività o dei loro annunci. Questo deve finire. Le presidenze dovrebbero revocare gli inviti ai CEO della Oil&Gas. I Paesi potrebbero adottare una politica sui conflitti di interesse per, quantomeno, rendere trasparente l'influenza dei lobbisti dei combustibili fossili ed escludere successivamente coloro che mirano a influenzare indebitamente il processo. I Paesi, compreso il team della presidenza, potrebbero rifiutare di dare loro i badge. Inoltre, potrebbero porre fine al greenwashing alle COP nella forma di sponsorizzazioni aziendali e padiglioni aziendali. Le COP sono troppo grandi? Le COP sono al contempo troppo e troppo poco (Hale): anche le COP di maggior successo sono minuscole rispetto al problema. Il cambiamento climatico richiede l'azione di tutta la società. In questo sistema complesso, il processo UNFCCC svolge la funzione critica di fissare agende e obiettivi. Nessun altro organismo ha la legittimità multilaterale necessaria. I vertici sul clima potrebbero passare da un forum di discussione a una dimostrazione di leadership se gli inviti fossero estesi solo ai paesi che hanno presentato e mantenuto gli NDC più progressivi e li stanno attuando. Accanto a un'unica riunione di due settimane in un unico luogo, abbiamo bisogno di molte riunioni più piccole e mirate in molti luoghi. La buona notizia è che gli elementi di questo cambiamento sono già ben avviati, con sempre più città che ospitano settimane del clima. Le riunioni regionali con formati più flessibili raggiungono più persone, in modo più mirato, molto più a buon mercato ed efficiente di una COP. Le COP devono evolvere da forum incentrati sui negoziati a riunioni più frequenti, più piccole, incentrate sulle soluzioni, incentrate sui progressi e sull'attuazione, con un'ampia partecipazione degli stakeholder.Per altro verso gli eventi collaterali, delle attività dei padiglioni e dei panel delle COP hanno subito un deciso cambiamento, da un numero minore di eventi incentrati sulla negoziazione e l'attuazione a una vasta gamma di panel che mostrano nuove iniziative o azioni nazionali. Riguarda ciò che è nuovo, non il follow-up su ciò che è stato concordato. Gli spazi dei padiglioni potrebbero essere riservati a coloro che possono dimostrare che la loro presenza farà progredire l'azione per il clima. Come potrebbe essere migliorata la partecipazione alla COP? La società civile, i giovani, i popoli indigeni, le donne, le comunità locali e le persone con disabilità, tra gli altri, hanno sempre più affrontato uno spazio civico che si restringe nelle COP (Lennon). Devono lottare per far sentire la loro voce, per essere presenti nelle stanze in cui si prendono le decisioni, per l'accesso alle informazioni e al processo decisionale aperto e per riunirsi pacificamente. Le barriere strutturali... minano l'inclusività e la partecipazione equa alle riunioni, dal costo elevato degli alloggi, un problema gravissimo per la prossima COP 30, alle pratiche di visto discriminatorie e alla riduzione delle quote della società civile. Queste barriere devono essere smantellate per garantire che tutte le parti e gli stakeholder possano partecipare pienamente e su un piano di parità. Le parti dovrebbero incorporare e sostenere la partecipazione non solo alle COP, ma anche nell'azione per il clima e nelle decisioni sul campo. Possono farlo creando spazio in tutti i punti all'ordine del giorno per ascoltare i titolari dei diritti e garantendo che i diritti umani e lo spazio civico siano garantiti durante tutti i negoziati. Gli accordi di ospitalità devono garantire la libertà di parola, di riunione e di accessibilità, sostenuti da un organismo indipendente per affrontare le violazioni. In che modo le COP possono guidare il cambiamento al di fuori del processo ONU? La COP deve trasformarsi da un forum di negoziazione a una piattaforma di realizzazione, inclusione e responsabilità, ancorando l'azione per il clima alle realtà vissute dalle persone e alle richieste della scienza (Dixson-Declève).Dovrebbe esserci un'analisi approfondita e onesta del valore aggiunto del processo UNFCCC e di ciò che è meglio lasciare ad altri forum. Sebbene alcuni negoziati rimangano necessari, l'azione più urgente si è spostata sull'attuazione nel contesto delle forze di mercato e dell'economia climatica. Non c'è dubbio che la società civile, le imprese, le città e le comunità si stanno muovendo più velocemente dei governi (Figueres). Questi attori, tradizionalmente considerati ed etichettati come semplici osservatori, sono diventati i veri motori della trasformazione. Si potrebbero considerare i pro e i contro della creazione di un mondo reale semi-staccato accanto alla COP, che amplifichi i loro progressi, metta in mostra l'innovazione e reindirizzi intuizioni attuabili al processo formale. Il processo di Parigi ha un ruolo da svolgere nell'incoraggiare e monitorare un'azione forte al di fuori dei suoi spazi formali (Stern). Ciò include i settori pubblico e privato che lavorano insieme sulla rapida decarbonizzazione e sullo sblocco del tipo di investimenti su larga scala necessari affinché i paesi del sud del mondo costruiscano economie sostenibili e resilienti. C'è un ultimo, più grande problema, che nessuna riforma dell'UNFCCC può risolvere: il regime climatico è figlio dell'ordine mondiale democratico, quello stesso che si sta trasformando in una pericolosa imitazione degli stati canaglia. L'ascesa dell'estrema destra e l'erosione della democrazia stanno rendendo il multilateralismo stesso inutile. Un mondo che non è in grado di fermare i genocidi a Gaza e in Sudan non può risolvere la crisi climatica. 2025. FINALITà DELLA COP 30: DA BELéM UN PIANO DI ATTUAZIONE
Sebbene le agende tradizionali siano dense e i risultati su temi come gli indicatori di adattamento, la transizione giusta, i finanziamenti e il seguito del bilancio globale siano fondamentali, anche tutte insieme non rappresentano l’elemento decisivo di cui Belém ha bisogno per avere successo. Alcuni hanno suggerito che, sulla via di una ben sperimentata tradizione, una dichiarazione politica aggiuntiva in uscita da COP 30. oggi chiamata decisione di copertura (cover), potrebbe essere un modo per cercare di colmare le ampie lacune che il mondo sta affrontando in termini di ambizione e azione climatica. La realtà è che, al contrario, dovremmo concentrarci su come razionalizzare e migliorare i mandati esistenti, assicurandoci di creare processi che facciano davvero la differenza, invece di appesantire ulteriormente il sistema. Un’Agenda d’Azione di Belém, che mobiliti azioni climatiche volontarie in tutte le economie e società, potrebbe essere proprio lo strumento necessario a questo scopo, con il grande vantaggio di non richiedere risultati basati sul consenso. Tuttavia, per essere efficace, servono miglioramenti significativi. Per essere accettabile, un forum di attuazione deve correggere la principale debolezza delle risoluzioni finali fino ad oggi: la tendenza a moltiplicare gli annunci senza garantire un seguito credibile e una reale implementazione. In sintesi, gli ultimi giorni della COP non dovrebbero essere teatro di un’altra tesa negoziazione su una nuova decisione di copertura destinata ad avere poco impatto, ma piuttosto il momento in cui la presidenza presenti un Piano di Attuazione di Belém. Questo piano fornirebbe chiarezza su come tutto il lavoro mobilitato procederà, specificando chi farà cosa e quando, con risultati chiari nel prossimo anno o due. Indicherebbe inoltre dove e quando si riunirà, nel 2026, un forum di attuazione, per esempio le già previste settimane del clima a New York, per monitorare i progressi. Tale processo sarebbe guidato dalla presidenza della COP 30, dai campioni e, auspicabilmente a quel punto, dalla futura presidenza della COP 31. Cambiare l’abitudine dell’UNFCCC di negoziare decisioni sarà difficile.Molti possano continuare a ritenere che il risultato debba includere una qualche forma di testo decisionale. Se tale testo potesse essere breve e mirato, perché no? Tuttavia, resterebbe comunque la necessità di affiancargli un forum di attuazione, per garantirne la credibilità.
2024. LA COP 29 DI BAKU. TRIPLICARE LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ENTRO IL 2030 8 novembre 2024. Si apre la 29 COP climatica a Baku. Nere prospettive. Nel 2025 il limite degli 1,5 °C di Parigi verrà superato
La violenza
dell’impatto climatico è in crescita oltre ogni previsione. Le vittime di
Valencia sono paragonabili a quelle delle guerre in corso. Valencia,
immagine del progresso e delle speranze dell'umanità con la sua architettura
futuribile di Santiago Calatrava, è ora ridotta alla squallida
rappresentazione dell'impotenza del genere umano a salvare se stesso (in
figura un particolare). Preoccupa però il diffondersi di una forma di
rassegnazione che, pur se alimentata dal ricco sistema mondiale dell’oil
and gas e fatta propria in occidente da taluni schieramenti
politici, rischia da sola di vanificare lo sforzo immane profuso in
trent’anni nel negoziato internazionale multilaterale sul clima. L’Emissions
Gap Report 2024 dell’ UNEP conferma la perdurante crescita delle
emissioni GHG, arrivate a 57 GtCO2eq nel 2023, e con essa delle
concentrazioni in atmosfera e, per diretta conseguenza, della temperatura
media superficiale terrestre e marina, con punte oltremisura proprio nelle
zone temperate di cui fanno parte l’Europa e il bacino mediterraneo.
L’obiettivo degli 1,5 °C di Parigi a fine secolo viene quasi universalmente
giudicato fuori portata, anche negli interventi ufficiali. Il mediterraneo
salirà sopra gli 1,5 gradi nel 2025. In questo quadro si prepara a Baku una COP 29 in tono minore. Il check degli impegni assunti dai vari paesi, gli NDC, avverrà infatti solo il prossimo anno alla COP 30 in Brasile. Ai governi è stato richiesto di rivedere al rialzo entro il 2025 i propri livelli di ambizione che ad oggi farebbero fallire l’obiettivo di Parigi, e a presentarne di nuovi per il 2035, anno in cui le emissioni globali, che ancora oggi continuano a crescere, dovrebbero essere ben del 60% più basse rispetto a quelle del 2019. L’Europa ha comunicato un promettente abbattimento delle emissioni dell’8,3% nel 2023 confermando il suo impegno immutato sulla transizione ecologica. Le elezioni americane, però, riportano uno dei peggiori negazionisti alla guida di un grande paese e suscitano gravi preoccupazioni. Al proposito Reuters segnala che i leader mondiali delle principali economie come l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Brasile hanno in programma di disertare la COP 29. La Cina resta paradossalmente con l’Europa alla frontiera del clima, ma ha chiesto ai paesi di discutere off the records a Baku sulle tasse di confine sul carbonio che sarebbero dannose per i paesi in via di sviluppo. Alcuni documenti dalla Cina sollevano il timore che le crescenti tensioni commerciali tra le principali economie potrebbero bloccare i colloqui di Baku. Al di fuori delle negoziazioni formali, le COP sono spazi in cui governi, settore privato e società civile possono impegnarsi in una collaborazione autentica per promuovere l'azione per il clima. Molte sono state le acquisizioni dei vertici recenti, come gli impegni per incrementare le energie rinnovabili, ridurre gradualmente i combustibili fossili, promuovere l'azione per il clima nelle città, rendere green il settore finanziario, fermare la deforestazione e altro ancora. La maggior parte dei paesi non dispone però di strutture di monitoraggio dell’azione dei governi e degli altri soggetti. La COP 29 è un'opportunità per dimostrare un reale progresso sui numerosi impegni presi finora. Per le iniziative esistenti, ciò significa comunicare pubblicamente i progressi attraverso il Global Climate Action Portal dell'UNFCCC o pubblicando relazioni adeguate. Ciò aiuterebbe a far progredire la comprensione del ruolo che gli sforzi cooperativi possono svolgere nel supportare azioni ambiziose. In concreto, quali sono gli obiettivi attribuiti alla COP 29? Dare un nuovo obiettivo al finanziamento per il clima. La COP 29 sarà una sorta di COP finanziaria, incentrata sull'adozione di un nuovo improbabile obiettivo di finanziamento per il clima, il NCQG che sostituirà il precedente obiettivo annuale di 100 miliardi di dollari stabilito nel 2009 a Copenhagen e tuttora inevaso. Dovrebbe essere rivalutato l'importo e il tipo di finanziamento che i paesi in via di sviluppo ricevono per sostenere la loro azione per il clima. Il quadro internazionale e la nuova alleanza dei BRICS complicano le cose. In effetti, molti paesi in via di sviluppo non possono mantenere o rafforzare i loro impegni climatici senza sostegni. Ma i paesi occidentali, da sempre restii a far fronte alle responsabilità che sono essenzialmente le loro, non mancheranno di sfruttare il pretesto della crisi geopolitica per non fare fronte agli impegni vecchi e a quelli nuovi. I dialoghi tecnici degli ultimi tre anni, volti a dare forma al NCQG, lasciano sul tavolo questioni fondamentali sulle dimensioni e la struttura dell'obiettivo. Una decisione chiave è a quale cifra punterà il NCQG, quantificato da volta a volta da miliardi a trilioni su base annua. Per ora sembra probabile che NCQG consisterà in più obiettivi che riflettono diversi tipi di flussi finanziari pubblici e privati. Resta da definire, e non è poco, quali paesi forniranno finanziamenti, se saranno favoriti determinati strumenti finanziari come sovvenzioni o prestiti agevolati e quale rendicontazione sarà richiesta per promuovere la trasparenza. Aumentare l’ambizione degli impegni nazionali per il clima. I paesi dovranno annunciare i loro nuovi impegni nazionali sul clima (NDC) solo nel 2025. Diversi grandi emettitori, Brasile, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti annuncerebbero i loro nuovi NDC alla COP di quest'anno. I nuovi NDC dovrebbero includere nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni GHG per il 2035, aumentare quelli del 2030 e mettere i paesi su percorsi credibili per raggiungere le emissioni zero nette intorno alla metà del secolo. Per stimolare cambiamenti di così vasta portata, gli NDC dovrebbero stabilire obiettivi specifici per settore, energia, trasporti, agricoltura, in coerenza con il Global Stocktake della COP 28. A Baku si potrà al più tentare di coinvolgere il settore privato per aiutare a indirizzare più finanziamenti verso l'azione per il clima. Maggiori finanziamenti per perdite e danni. La crisi climatica è ingigantita al punto che alcuni impatti vanno già oltre ciò a cui le persone possono adattarsi, come la perdita di vite umane e mezzi di sostentamento a causa di inondazioni estreme e incendi boschivi o la scomparsa di siti patrimoniali costieri a causa dell'innalzamento del livello del mare. Nei negoziati sul clima delle Nazioni Unite, il termine usato è loss and damage. Il primo giorno della COP 28 è stato avviato il Fondo per rispondere alle perdite e ai danni (FRLD). Da allora, la Banca Mondiale ha assunto il ruolo di fiduciario, le Filippine sono state scelte come paese ospitante per il consiglio del Fondo e Diong è stato nominato primo direttore esecutivo. Il passo successivo è riempire le casse del fondo. Alla COP 28 sono stati promessi circa 700 M$; è un inizio, ma nulla in confronto ai 580 G$ di danni legati al clima che i paesi in via di sviluppo potrebbero dover affrontare entro il 2030. Un piano di mobilitazione delle risorse dovrebbe essere attivo entro il 2025. Alla COP 29, i paesi sviluppati dovrebbero annunciare nuovi impegni, eventualmente inseriti nel NCQG, in modo che il sostegno possa iniziare a fluire verso i paesi bisognosi, ma le ombre scure delle divisioni geopolitiche si allungano sul negoziato proprio nell’anno delle terribili inondazioni nel Rio Grande do Sul, in Emilia e a Valencia. Adeguare il finanziamento per l'adattamento nell’ottica della definizione di un obiettivo globale. Alla COP 29 i paesi dovrebbero anche lavorare per colmare il divario finanziario per l'adattamento, che attualmente si aggira intorno ai 194 - 366 G$ all'anno in crescita. Nel 2021 i paesi hanno concordato di raddoppiare il finanziamento per l'adattamento entro il 2025 come parte del Glasgow Climate Pact. La Convenzione climatica sta preparando un rapporto per la COP 29 per documentare i progressi verso questo obiettivo, come sollecitato dal Global Stocktake dell'anno scorso. A Baku, con il NCQG, i finanziamenti per l'adattamento dovrebbero essere messi alla pari con quelli per la mitigazione e gli interessi sui prestiti dovrebbero essere ridimensionati. Del pari si dovrebbe tentare di dare forza all'obiettivo globale sull'adattamento (GGA), che si vuole che assuma un rilievo politico pari agli 1,5 °C di Parigi. Alla COP 28, i paesi avevano stabilito gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 e avviato un programma di lavoro biennale per determinare come saranno misurati gli sforzi di adattamento. Alla COP 29, i negoziatori tenteranno di raggiungere un accordo su un set gestibile di indicatori per monitorare i progressi e i flussi finanziari sia a livello nazionale che locale. Sfruttare i mercati del carbonio per guidare l'azione per il clima. L'articolo 6 dell'accordo di Parigi consente ai paesi di scambiare crediti di carbonio per raggiungere i propri obiettivi climatici nazionali. I paesi ricchi di foreste pluviali tropicali potrebbero vendere crediti per generare fondi per la protezione delle foreste che i paesi che acquistano i crediti potrebbero dedurre nei propri NDC. Le regole sul funzionamento di questi mercati dovranno essere definite prima che gli scambi possano iniziare in un assetto capace di garantire che i mercati del carbonio, disciplinati da standard internazionali, siano ecologicamente validi e non rischino di compromettere i tagli alle emissioni globali. Si tratta di cosa assai diversa dai mercati volontari dell’offsetting che hanno dato in questi anni più scandali che risultati Fallito alla COP 28 l’accordo sulle regole dell'articolo 6, le parti hanno fatto alcuni progressi nel trovare un terreno comune. L'organismo di vigilanza per il nuovo meccanismo di accreditamento dell'accordo di Parigi è il PACM, che gestirebbe l'accredito del carbonio tra i paesi e che ha recentemente concordato due standard sui requisiti metodologici e sulle attività che comportano rimozioni ecosistemiche. Ha anche stabilito che tutti i progetti devono rispettare le tutele ambientali e dei diritti umani. A Baku si dovrà stabilire se il PACM andrà avanti; come affrontare l'autorizzazione dei crediti di carbonio; se un paese può revocare l'autorizzazione dei crediti; se i crediti dovranno passare attraverso un processo di revisione tecnica prima di poter essere utilizzati e se i paesi in via di sviluppo con risorse limitate possono o meno utilizzare il registro del commercio internazionale per le transazioni sui crediti. Rafforzare la trasparenza intorno alle azioni nazionali per il clima. La trasparenza è un principio cardine dell'accordo di Parigi, tanto che i paesi sono tenuti a presentare i loro primi rapporti biennali sulla trasparenza (BTR) entro la fine di quest’anno. In questi rapporti i paesi chiariranno le modalità dei loro sforzi per ridurre le emissioni di gas serra; i loro progetti e piani di adattamento e quanto sostegno finanziario hanno fornito, mobilitato, ricevuto o di cui hanno bisogno. Dettaglieranno anche i progressi che i paesi stanno facendo verso i loro obiettivi NDC del 2025 e del 2030. La preparazione di rapporti biennali sulla trasparenza è un processo esteso e complesso e i paesi in via di sviluppo con meno esperienza richiederanno supporto per il capacity building. Riconoscendo queste sfide, la presidenza azera ha lanciato la Baku Global Climate Transparency Platform per supportare le metodologie della rendicontazione e della trasparenza e ha ospitato diversi workshop regionali per supportare gli sforzi di rendicontazione.
2023. LA COP 28 di DUBAI. PHASEOUT DELLE FONTI FOSSILI DI ENERGIA (resoconti in diretta da COP 28 UAE live e dalle Nazioni Unite, disponibili su VOLUME VI)
15 dicembre 2023. I prossimi passi per l’Italia dopo le decisioni della Cop 28, di Ivan Manzo Il vertice di Dubai ha stabilito finalmente l’allontanamento dal settore fossile. Per accelerare il processo di decarbonizzazione dobbiamo dotarci di una Legge sul clima, rivedere il Pniec e trasformare i Sussidi ambientalmente dannosi. Il documento finale della Cop 28 per la prima volta associa la causa, i combustibili fossili, all’effetto, il riscaldamento globale. Può sembrare strano ma, in 30 anni di negoziati, non si era ancora riusciti a mettere nero su bianco che non solo occorre tagliare le emissioni climalteranti, ma che bisogna anche spingere forte sulla transizione da un sistema basato sulle energie fossili, che oggi soddisfano circa l’80% della domanda energetica globale, a uno pulito e rinnovabile. l testo definitivo del primo inventario delle azioni compiute dagli Stati, quel Global stocktake che va effettuato ogni cinque anni (il prossimo si avrà dunque nel 2028) e che ricorda che i Paesi sono ampiamente fuoristrada sull’Accordo di Parigi e devono presentare nuovi contributi determinati a livello nazionale (impegni di riduzione delle emissioni) entro il 2025, indica che bisogna ridurre le emissioni climalteranti del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035, rispetto al 2019, per centrare l’obiettivo degli 1,5 °C. Inoltre, la decisione Onu “richiama i Paesi” a effettuare politiche di “allontanamento dalle fonti fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questa decade - entro il 2030, così da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come indicato dalla scienza”. Sempre sotto al profilo della mitigazione, la Cop 28 suggerisce di: triplicare le fonti rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030; accelerare la riduzione graduale del carbone non abbattuto (“unabated”); ridurre le emissioni di metano – anch’esso menzionato per la prima volta - e quelle sul trasporto su strada; eliminare gradualmente e il prima possibile i sussidi “inefficienti” ai combustibili fossili. i tratta di un pezzo importante dell’accordo, ma che presenta aspetti controversi. Senza dubbio è positivo il fatto che per la prima volta nel testo negoziale si associ la riduzione delle emissioni ai combustibili fossili. Soprattutto alla luce del fatto che questa decisione è stata presa in un Paese direttamente interessato, gli Emirati Arabi, e che il presidente della Cop 28, Sultan Al-Jaber, è anche l’amministrazione delegato della compagnia petrolifera di casa, l’Adnoc. Resta però l’amaro in bocca per la presenza nel testo finale di “transitioning away” (allontanarsi) piuttosto che di un “phase out” (eliminazione) accanto a combustibili fossili – il phase out era la principale speranza riposta in questa Cop prima dell’inizio, e per un semplice “phase down” (riduzione graduale) dal carbone persino “unabated”, e cioè solo quello che non si è in grado di catturare attraverso soluzioni tecnologiche, peraltro ancora poco efficaci e costose, come la Ccs (Carbon capture and storage), che al momento coprono solo lo 0,12% delle emissioni mondiali. Non rassicura nemmeno il termine “inefficienti” associato a sussidi ai combustibili fossili che, senza una definizione chiara significa tutto e nulla, restando così un parametro parecchio interpretabile. In sostanza, questa parte sul Gst permette ancora l’utilizzo di parecchie vie di fuga e resta lontana da quanto chiede la comunità scientifica.
A inizio summit ha sorpreso l’approvazione fulminea del fondo “Loss and damage”, quello destinato ai danni e alle perdite subite dai Paesi vulnerabili, a cui l’Italia ha dichiarato di voler contribuire per una somma pari a 100 milioni di euro, riconoscendo in questo modo la responsabilità storica detenuta dai Paesi industrializzati nell’aver provocato la crisi climatica. Il fondo fino a ora ha raggiunto la cifra di 655,9 milioni di dollari, “mancano però regole, obiettivi e target per passare dalla elargizione occasionale ad un finanziamento strutturale”, ha commentato Toni Federico nelle sue Cronache della Cop” pubblicate dall’ASviS. Un fondo diverso dal Green climate fund che copre le attività di mitigazione e di adattamento e che ha l’obiettivo, fino a ora mancato, di raccogliere 100 miliardi di dollari ogni anno. In generale, però, ci vorrebbero molti più soldi: la Cop 28 ricorda che in termini di finanza climatica servirebbero 4mila 300 miliardi di dollari l’anno per la mitigazione e 215-387 miliardi di dollari all’anno (da qui al 2030) per l’adattamento. Il documento punta inoltre ad arrestare la deforestazione e il degrado delle foreste entro il 2030, riconoscendo l'importanza del ruolo degli ecosistemi per il benessere umano e nello stoccaggio dei gas serra, in linea con quanto stabilito dall'Accordo di Montreal della Convezione sulla diversità biologica lo scorso anno. Male, infine, che dopo due settimane di discussioni non si sia trovato nessun accordo sui meccanismi del mercato deldi carbonio. La Cop 28 ha infatti rinviato tutte le decisioni alla Cop 29 di Baku, in Azerbaigian, sia per quanto riguarda la cooperazione bilaterale sui crediti di carbonio sia per quanto riguarda la costituzione di un meccanismo globale di scambio dei permessi di emissione. Tuttavia, per quanto imperfetto il testo negoziato a Dubai può vantare comunque un certo peso politico. Adesso organizzazioni e società civile hanno un’arma in più per obbligare i 198 Stati che hanno firmato l’accordo ad accelerare nell’immediato le politiche di transizione, ricordando che anche in sede Onu è stata finalmente riconosciuta la stretta connessione che intercorre tra riscaldamento globale, emissioni gas serra e combustibili fossili. Per centrare l’Accordo di Parigi non c’è dunque soluzione alternativa che dismettere carbone, gas e petrolio nei prossimi anni. Come dovrà procedere dunque il nostro Paese e quali sono i prossimi passi fondamentali? Rafforzare e approvare quanto prima il Pniec e il Pnacc. Quest'ultimo è stato presentasto in versione finale nei primi giorni del 2024. Per attuare il processo di transizione ecologica ed energetica, l’ASviS nel suo Rapporto 2023 L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sottolinea che è ancora possibile centrare gli obiettivi climatici europei al 2030 (-55% di emissioni rispetto al 1990) e al 2050 (neutralità carbonica). Per portare il Paese all’avanguardia nella lotta alla crisi climatica occorrerebbe però rivedere i Piani per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Pniec e il Pnacc. L’ASviS ricorda che questi Piani necessitano di ulteriori sviluppi per orientare le politiche economiche, sociali e ambientali in direzione dello sviluppo sostenibile. La bozza di Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima), per esempio, inviata alla Commissione europea a giugno, rivela diverse criticità che richiedono urgenti correzioni. Gli obiettivi sulle energie rinnovabili per il 2030 sono inferiori rispetto ai suggerimenti di esperti e operatori del settore e mostrano una mancanza di enfasi sul ruolo delle comunità energetiche. Mancano poi indicazioni chiare riguardo all'uso dell'elettricità rinnovabile derivante da idrogeno verde, nonché riguardo all'abbattimento delle emissioni gas serra, allo stop dei veicoli inquinanti; il tema della "giusta transizione", poi, è trattato in modo superficiale (come si intende attuarla?). Bene la chiusura confermata al 2025 delle centrali a carbone, anche se non vengono indicate alternative basate sulle fonti rinnovabili. In sostanza, il Pniec necessita di miglioramenti significativi per diventare uno strumento efficace nel guidare l'Italia verso la decarbonizzazione. Il Pnacc (Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici), invece, va soprattutto finanziato dato che, al momento, non sono previste risorse dedicate a questo importante Piano di adattamento alla crisi climatica.
Iniziare finalmente ad eliminare e convertire i sussidi ambientalmente dannosi. L’Italia deve trovare nuove modalità di coinvolgimento attivo di soggetti economici e sociali per la definizione e la realizzazione delle politiche climatiche e di un programma temporale per eliminare i sussidi dannosi all’ambiente (Sad) legati ai combustibili fossili. Secondo il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica al momento sono presenti all’interno del bilancio dello Stato circa 22,4 miliardi di euro di Sad. I soldi provenienti sia dalla riconversione dei Sad sia da una nuova fiscalità ecologica attenta alla tutela del capitale naturale e premiare le imprese virtuose, potrebbero essere utilizzati per finanziare l’innovazione tecnologica low carbon e per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali fortemente presenti nel Paese, come tra l’altro confermato dal Rapporto sui Territori pubblicato il 13 dicembre sempre dall’ASviS. Favorire lo sviluppo di un sistema industriale italiano completo delle rinnovabili. Il progressivo contrasto ai cambiamenti climatici aumenterà la domanda di energia elettrica, poiché l'elettricità offre rendimenti superiori e può essere prodotta senza generare emissioni di CO2. Tuttavia, la decisione di prolungare l'uso predominante del gas naturale nella produzione elettrica rischia di portate l'Italia fuori dalla rotta stabilita dalle direttive dell'Unione europea e dagli accordi internazionali. Una scelta ancor più azzardata considerando i prezzi elevati e instabili del gas. Anche per questo motivo occorre favorire lo sviluppo di un sistema industriale italiano delle rinnovabili, che si dice pronto a superare il raddoppio delle Fer (Fonti energetiche rinnovabili elettriche) entro il 2030 al ritmo annuale di 8-10 GW (Gigawatt) all’anno. Grazie a un uso intelligente dei fondi del Pnrr, il nostro Paese ha l’opportunità di costruire una politica industriale basata sulla fabbricazione di tecnologie centrali al processo di transizione, come pannelli solari e batterie. La rete elettrica futura sarà notevolmente diversa dall'attuale. Sarà infatti basata sulle fonti rinnovabili, sull'autoconsumo, sull'accumulo dell'energia e sull'efficienza energetica programmata supportata da tecnologie digitali e dall’intelligenza artificiale. Le comunità energetiche rinnovabili, concepite in un'ottica solidaristica offrono, infine, un'opportunità democratica e partecipativa per affrontare nuove e vecchie forme di disuguaglianze, come la povertà energetica. 11-13 dicembre 2023. Il documento finale dell'Accordo di Dubai - Transitioning away from fossil fuels Conta poco quello che è successo nei giorni 11 e 12. Conta invece la plenaria del 13 mattina, Santa Lucia, (video) in cui al Jaber ha presentato il frutto del suo lavoro, il documento finale della COP 28. Dalle COP tutti si aspettano risultati trasformativi, capaci cioè di far fare al mondo intero passi in avanti sostanziali. Questo in realtà è avvenuto poche volte, solo 2 su 28, a Kyoto e a Parigi. Poi si è trattato più che altro di un riflesso dell’esistente o, come è stato detto dallo stesso Presidente, di una politica del “minimo comune denominatore”. Anche qui a Dubai, con molti sforzi, si è riusciti a fatica in una presa d’atto di eventi ormai in corso, si prende cioè atto di una transizione ormai in cammino per abbandonare i combustibili fossili. Non si dice come e in quanto tempo deve avvenire la transizione in armonia con i risultati scientifici condivisi. Ha un indubbio valore che la presa d’atto sia condivisa da tutti, compresi Iran, Russia, Arabia Saudita, Bolivia, Venezuela e via carogneggiando. Che ci sia la importante benedizione della Cina, dell’India e degli Stati Uniti, al netto delle opinioni degli americani e dei vari trumpisti in agguato, questo conta. Conta anche la fermezza dell’Europa e perfino della UK, che ha appena finito di smantellare la sua di transizione. Il wording di Dubai pesa in fondo come un phase-down, meno del phase-out che a Glasgow fu cancellato all’ultimo momento dall’India, ma più di quello perché comprende petrolio e gas.
Quasi 200 paesi al vertice sul clima della COP 28 hanno concordato un documento che per la prima volta invita tutte le nazioni ad abbandonare i combustibili fossili per evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico e a incrementare rapidamente le energie rinnovabili. Il testo del documento ve lo riproponiamo nei punti salienti, come si deve, in lingua originale. Subito notiamo che di fossil fuels, un neologismo importante per la COP, si parla una sola volta al punto 28: 28. Further recognizes the need for deep, rapid and sustained reductions in greenhouse gas emissions in line with 1.5 °C pathways and calls on Parties to contribute to the following global efforts, in a nationally determined manner, taking into account the Paris Agreement and their different national circumstances, pathways and approaches: (a) Tripling renewable energy capacity globally and doubling the global average annual rate of energy efficiency improvements by 2030; (b) Accelerating efforts towards the phase-down of unabated coal power; (c) Accelerating efforts globally towards net zero emission energy systems, utilizing zero and low-carbon fuels well before or by around mid-century; (d) Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science; (e) Accelerating zero- and low-emission technologies, including, inter alia, renewables, nuclear, abatement and removal technologies such as carbon capture and utilization and storage, particularly in hard-to-abate sectors, and low-carbon hydrogen production; (f) Accelerating and substantially reducing non-carbon-dioxide emissions globally, including in particular methane emissions by 2030; (g) Accelerating the reduction of emissions from road transport on a range of pathways, including through development of infrastructure and rapid deployment of zero and low-emission vehicles; (h) Phasing out inefficient fossil fuel subsidies that do not address energy poverty or just transitions, as soon as possible; 29. Recognizes that transitional fuels can play a role in facilitating the energy transition while ensuring energy security; L’accordo non include un impegno esplicito a eliminare né a ridurre gradualmente i combustibili fossili. Ha invece raggiunto un compromesso che invita i paesi a contribuire agli sforzi globali per la transizione via dai combustibili fossili nei sistemi energetici. Al Jaber ricorda che: “Per la prima volta in assoluto nel nostro accordo finale è presente un testo sui combustibili fossili”. Il documento rafforza l’obiettivo degli 1,5 °C e riconosce necessario un taglio delle emissioni del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019, aumentando il livello richiesto per gli NDC di tutti i paesi quando si presenteranno al GST del 2025. Di grande rilievo il riconoscimento della urgenza di triplicare l’energia rinnovabile globale e raddoppiare il tasso di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030.
L’affermazione secondo cui le emissioni globali dovrebbero raggiungere il picco entro il 2025 è stata abbandonata. La Cina si è opposta, pur se sembra essere sulla buona strada per raggiungere il picco delle proprie emissioni entro quella data. Le argomentazioni in difesa dei combustibili fossili si sono fatte strada nel testo con i carburanti di transizione (il gas naturale, è ovvio) e la immaginifica CCS. Pochi o nulli i progressi sull’adattamento e sui finanziamenti necessari, peraltro ciclopici. Il fondo per perdite e danni, grande successo di al Jaber all’apertura della COP, non si capisce come dovrebbe essere strutturato e finanziato dopo le generosità della prima ora. I paesi del sud del mondo e i sostenitori della giustizia climatica constatano che non si quantifica il necessario in termini di riduzione delle emissioni globali e finanziamenti per aiutare i più vulnerabili a far fronte al peggioramento delle dei condizioni meteorologiche estreme e delle ondate di calore. L’Alleanza dei piccoli stati insulari (AOSIS), che rappresenta 39 paesi, ha lamentato di non essere stata presente quando l’accordo è stato adottato poiché impegnata a formulare le sue proposte. Alla fine ha accettato il testo, dichiarandolo però pieno di scappatoie, come è del resto facile constatare. Raccogliamo dalla stampa alcuni commenti. Il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha twittato: “Piaccia o non piaccia, l’eliminazione graduale dei combustibili fossili è inevitabile. Speriamo che non arrivi troppo tardi”. Johan Rockström, del Potsdam Institut: “L’accordo non consentirà al mondo di mantenere il limite degli 1,5 °C (opinione condivisa dal mainstream scientifico), ma il risultato è un punto di riferimento fondamentale. Questo accordo mira a chiarire a tutte le istituzioni finanziarie, imprese e società, che ora siamo finalmente, otto anni in ritardo rispetto al programma di Parigi, al vero inizio della fine dell’economia mondiale basata sui combustibili fossili”. Al Jaber gliene sarà riconoscente. John Kerry, inviato speciale di Biden, ha dichiarato: “Anche se nessuno qui vedrà pienamente rispecchiate le proprie opinioni, il fatto è che questo documento invia un segnale molto forte al mondo”. Molti paesi sviluppati si sono uniti ai più vulnerabili e ai più poveri, un’alleanza del tutto inedita, nello spingere apertamente per l’eliminazione graduale del carbone, del petrolio e del gas. L’Unione Europea ha affermato che c’è una “supermaggioranza” a sostegno dell’idea, ma molti paesi ricchi vorrebbero che si applicasse solo ai combustibili fossili unabated, quelli in cui le emissioni derivanti dalla loro combustione non vengono catturate. Catturate come? L’Arabia Saudita e paesi alleati si sono opposti all’inclusione di qualsiasi riferimento alla riduzione della produzione e del consumo di combustibili fossili nel testo dell’accordo ottenendo un successo, va detto, tanto grande quanto deleterio. Il capo della UN FCCC, Stiell, ha affermato che la COP 28 che avrebbe dovuto segnare un duro stop ai combustibili fossili lascia alla fine molto spazio all’interpretazione e che quindi spetta ai paesi impegnarsi nella sua lettura più ambiziosa. Dall’Africa si segnala che l’accordo invia un segnale forte al pianeta ma ci sono troppe lacune su tecnologie non provate e costose come la CCS, l’ultimo escamotage del mondo dei fossili che hanno dichiaratamente tutte le intenzioni di proseguire nei loro commerci. Però, aggiungono, questo risultato sarebbe stato impossibile solo due anni fa, specialmente in una COP in un petrostato. Dal nostro paese, che non ha giocato come al solito un grande ruolo a Dubai, Edo Ronchi dichiara che la sostituzione di phase-down con transitioning away non pare un cedimento sostanziale: sia la fuoriuscita dai fossili, sia l’accelerazione, sia l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nette, sono obiettivi affermati chiaramente. È ormai palese, dice, che le azioni chiave necessarie per ridurre le emissioni al 2030 sono ampiamente conosciute e nella maggior parte dei casi molto convenienti e che è ormai largamente diffusa nelle opinioni pubbliche in tutto il mondo e fra i governi la convinzione che dobbiamo abbandonare i fossili, che dobbiamo accelerare la decarbonizzazione e che, in modo articolato, con tappe diverse, per i diversi livelli di sviluppo, siamo in grado di farlo, tecnicamente ed economicamente. Italy for climate lamenta l’assenza di una roadmap chiara per il transitioning away. L’unico anno citato è il 2050, troppo lontano per tradursi davvero in impegni concreti e stringenti. Mancano date e numeri certi e ci sono degli accrediti ambigui di soluzioni tecnologiche discutibili, nucleare, CCS. Si tratta alla fine di un traguardo probabilmente storico, ma di una vittoria figlia di un compromesso, peraltro forse inevitabile portato del multilateralismo in un quadro di enorme complessità. Mariagrazia Midulla, per il WWF Italia, dichiara pessima la menzione dei combustibili per la transizione, una transizione che gli interessi del gas tendono a rendere infinita ed enormemente più dispendiosa, proprio perché consistenti fondi tengono in piedi il sistema fossile. Per un pianeta vivibile abbiamo bisogno della completa eliminazione di tutti i combustibili fossili e della transizione verso un futuro di energia rinnovabile nonché a un sistema votato a risparmiare energia e risorse e a usarle nel modo più efficiente possibile. Nel testo sentiamo ancora gli interessi non solo dei Paesi produttori di idrocarburi, ma soprattutto delle potenti compagnie occidentali, incluse le nostre, che i combustibili fossili li estraggono, gestiscono e vendono. La Legambiente approva l’impegno a triplicare le rinnovabili e il raddoppio dell’efficienza energetica. L’accordo sancisce per la prima volta l’uscita dalle fonti fossili in modo da raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, con un’accelerazione dagli anni di qui al 2030, triplicando le rinnovabili e raddoppiando l’efficienza energetica. La scelta di prevedere una “transition away” graduale per la fuoriuscita da gas, petrolio e carbone rappresenta un timido passo avanti. Per l’Italia ci aspettiamo la rimodulazione e la cancellazione dei sussidi ambientalmente dannosi entro il 2030. Tre talloni d’Achille dell’accordo sono, segnala Legambiente, la CCS, il ricorso al gas come combustibile di transizione e la mancanza di un serio impegno per la finanza climatica per aiutare i paesi più poveri.
2022. LA COP 27 di SHARM EL-SHEIKH. PERDITE E DANNI CAUSATI DAL CLIMA A CARICO DEI PAESI INQUINATORI (Resoconti disponibili su VOLUME VI) 23 Novembre 2022. Ragionamenti finali sulla COP 27. Tramontati gli 1,5 °C? (tratto liberamente da IISD) La COP 27 doveva essere una di COP di attuazione, come il nuovo segretario esecutivo dell'UNFCCC Simon Stiell ha ribadito nel giorno dell'apertura. Tuttavia, due cose hanno complicato l'adempimento di questo compito: il 2022 è stato un anno di crisi verticale, con i prezzi di energia e cibo in aumento, impatti prolungati della pandemia di COVID-19, rallentamenti economici e, non ultime, le tensioni geopolitiche. Le prospettive di riduzione delle emissioni e l'esborso dei necessari finanziamenti per il clima per raggiungere a breve l'obiettivo degli 1,5 °C si sono maledettamente complicate. Peggio ancora, le idee dei vari paesi sull'attuazione dell'Accordo di Parigi si sono diversificate e forse confuse.
Durante la plenaria di chiusura, le parti hanno convenuto che il meglio di questa COP è stata l'istituzione di un fondo dedicato a perdite e danni. Tuttavia, le valutazioni sono contrastanti su come i risultati dimostrino la determinazione sull'implementazione e le ambizioni. Piuttosto che mantenere in vita gli 1,5 °C, alcuni temono che questa potrebbe essere la COP del loro tramonto. La conferenza di Sharm avrebbe dovuto avere il difficile compito di passare dalla costruzione del programma e dall'innalzamento delle ambizioni al compito apparentemente più banale (ma critico) di mettere in pratica l'uno e le altre. Con il regolamento dell'Accordo di Parigi completato e gli obiettivi di emissione definitivamente stabiliti a Glasgow nel 2021, la COP 27 avrebbe dovuto concentrarsi sull'attuazione. Nell'Agenda c'erano i programmi di lavoro sull'ambizione di mitigazione e sull'obiettivo globale dell'adattamento concordato a Glasgow. Ma c'era anche qualcosa di nuovo nelle crescenti richieste dei paesi in via di sviluppo per stabilire uno strumento di finanziamento per le perdite e i danni. L'incapacità dei paesi sviluppati di mantenere il loro impegno finanziario di 100 miliardi di dollari per il clima, deliberato a Copenaghen nel 2009, ha continuato a scavare la fossa della sfiducia tra Sud e Nord. Le parti dell'Accordo di Parigi generalmente concordano sui suoi pilastri principali: implementazione delle azioni di mitigazione e adattamento e supporto per i paesi in via di sviluppo attraverso la finanza e altri mezzi di implementazione. La questione delle perdite e danni ha invece acquisito visibilità e consensi crescenti solo negli ultimi anni, con i disastri climatici che hanno provocato il caos in tutto il mondo. Per molti paesi rimane la massima priorità la riduzione accelerata delle emissioni e dare una chance all'invito della COP 26 a mantenere in vita gli 1,5 °C. Tra essi ci sono i paesi più sviluppati, lo Environmental Integrity Group e alcuni dei paesi più vulnerabili del mondo, tra cui i paesi meno sviluppati (LDC) e l'Alleanza degli Island Developing States (AOSIS), insieme all'Associazione per l'America Latina e i Caraibi (AILAC), che vedono l'abbandono degli 1,5 °C come una minaccia esistenziale. I diversi paesi in via di sviluppo ad alto e medio reddito e le principali economie emergenti, raccolti nel gruppo negoziale dei paesi in via di sviluppo like-minded (LDMC), a loro volta, credono di sentirsi sempre più sotto pressione per ridurre ulteriormente le proprie emissioni. Sostengono che il principio di Rio della responsabilità comune ma differenziata, sancito dalla Convenzione del 1992, che chiede ai paesi sviluppati di assumersi ruolo e responsabilità dell'azione climatica, non è affatto venuto meno, ma che viene sempre più chiesto a loro di fare fronte a delle responsabilità che non gli competerebbero, un fardello causato dalla mancanza di azione dei paesi sviluppati. Alla COP 27, questa analisi è ststa particolarmente visibile durante le discussioni sul “Programma di lavoro per aumentare urgentemente la mitigazione ambizione e attuazione in questo decennio critico", stabilito a COP 26. Qui, la decisione finale chiarisce che questo programma di lavoro sarà “non prescrittivo, non punitivo, facilitativo, rispettoso della sovranità nazionale, … e non imporrà nuovi obiettivi". Per questo gruppo, gli altri pilastri dell'Accordo di Parigi sono altrettanto importanti della mitigazione, e sottolineano che le priorità dei paesi in via di sviluppo, tra cui l'adattamento e la finanza, continuano ad essere affrontati in maniera insufficiente. Proprio per essere sul suolo africano, molti si aspettavano che la COP 27 avrebbe avuto a tema centrale l'adattamento e la finanza, che sono priorità per il continente. Le discussioni sull'obiettivo globale dell'adattamento continuano: è un obiettivo ambizioso fissato nell'Accordo di Parigi, che i negoziatori hanno affrontato per chiarirlo pur in un contesto difficile che ha comportato discussioni fino alle ultime ore della COP. Alcuni esperti di adattamento a lungo termine ritenevano che il problema non avesse avuto l'attenzione che meritava, con il timore che quelle risorse, proprio quando le cose iniziavano ad andare, potevano essere trasferite alle perdite e danni. Per molti, l'unico risultato nuovo e tangibile sull'adattamento è stata la decisione di iniziare lo sviluppo di un quadro programmatico da adottare il prossimo anno, per guidare la Convenzione verso l'obiettivo globale sull'adattamento. Una parte fondamentale del programma di lavoro mira a migliorare la comprensione di cosa significa effettivamente l'adattamento e come misurare i progressi verso il suo raggiungimento. Le esigenze di adattamento possono essere molto locali e qualitative, e rendono difficile la formulazione di provvedimenti aggregati nel segno di un obiettivo globale. Ci si aspettava che la finanza fosse un'altra voce importante a Sharm El-Sheikh, con le agende dei vari organismi negoziali che la stanno trattando sotto una straordinaria molteplicità di forme. Tra i problemi più controversi c'è quello del tracciamento dei pagamenti dei paesi sviluppati della loro quota dei 100 miliardi di dollari entro il 2020. Anche l'OECD ha dichiarato che finora non si superano i 17 miliardi di dollari e che non si va oltre l'impegno preso a Glasgow di raddoppiare entro il 2025 i finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2019. Allo stesso tempo, i paesi sviluppati vorrebbero espandere il pool di contributori ai finanziamenti per il clima estendendolo al settore privato, alla filantropia, alle fonti di beneficenza, alle banche di sviluppo e persino ad alcuni paesi in via di sviluppo. Benché durante le COP siano stati presi nuovi impegni di finanziamento per il clima, che hanno spesso contribuito a mitigare le dispute, il valore dei contributi alla COP 27 è stata piuttosto scarsa. L'Adaptation Fund ha conseguito 230 milioni di dollari di nuovi impegni e promesse iniziali per il nuovo Global Shield, il regime assicurativo contro i rischi climatici, che ha totalizzato 210 milioni di euro. Le decisioni finali della COP 27, col nome di Piano di attuazione di Sharm El-Sheikh, mettono assieme alcuni dei risultati principali dei documenti della conferenza e non fanno altro che evidenziare tutte le difficoltà di conciliare le diverse visioni a proposito di implementazione. Durante la plenaria di chiusura, molti gruppi e paesi hanno sottolineato che i testi non sono andati oltre Glasgow nel dimostrare maggiore ambizione e che a loro avviso avrebbero dovuto includere riferimenti al picco delle emissioni globali entro il 2025 e alla graduale riduzione di tutti i combustibili fossili, non solo del carbone. Altri, a loro volta, erano più preoccupati dell'erosione dei principi di equità e della responsabilità comune ma differenziata e della capacitazione e accusavano i sostenitori di una maggiore ambizione di tentare di mascherare la mancanza di volontà di provvedere al sostegno ai paesi in via di sviluppo. La presenza di 112 leader mondiali durante la prima settimana può aver creato l'impressione di un grande impegno sull'implementazione. Forse però l'implementazione non è così attraente come l'ambizione, il solito rapporto tra i fatti e le chiacchiere. Con scarse risorse finanziarie disponibili nel breve periodo, l'attenzione si è concentrata su chi dovrebbe avere la priorità nella fruizione. A fronte della lunga lista di richieste del gruppo africano, gli appelli ad avere altrettanta attenzione da parte di altre regioni in via di sviluppo hanno rallentato il negoziato. Alla fine l'Africa ottiene solo due brevi riferimenti nel testo. Le perdite e danni, che colpiscono i paesi e le comunità più vulnerabili, sono state una priorità per lo sviluppo delle piccole isole fin dagli anni '90. I paesi sviluppati hanno tradizionalmente resistito alle richieste di finanziamenti specifici per perdite e danni, in parte per paura delle relative responsabilità e delle richieste di risarcimento che potrebbero derivarne per essere stati causa della maggior parte delle emissioni storiche. La decisione che ha adottato l'Accordo di Parigi nel 2015 è che l'articolo sulla perdita e il danno non include né responsabilità né compensi. Alla COP 27, questo avvertimento contro l'interpretazione di qualsiasi finanziamento come responsabilità o compensazione è stato accuratamente richiamato come nota a piè di pagina in tutti i testi, un compromesso che ha permesso di avere finalmente all'ordine del giorno un articolo sugli accordi di finanziamento per perdite e danni e un spazio dedicato nei negoziati formali per discutere la questione. Nel corso degli anni, l'esigenza di un accordo di finanziamento ha ricevuto il sostegno di tutti i paesi in via di sviluppo. Alla COP 27 è stato finalmente raggiunto un accordo per istituire un fondo dedicato per perdite e danni, insieme a un comitato di transizione incaricato di elaborare i dettagli e identificare opportunità e lacune in modo che possa essere reso operativo alla COP 28 nel 2023. A Sharm alcuni paesi sviluppati hanno insistito per il diritto di sostener tale fondo solo in favore dei paesi più vulnerabili e solo se i finanziamenti proverranno da una più ampia base di donatori, come, ognuno ha pensato, la Cina. Alla fine la formula trovata è per “assistere i paesi in via di sviluppo che sono particolarmente vulnerabile agli effetti negativi del cambiamento climatico", ma senza specificare quali sarebbero questi paesi. La decisione non identifica chi finanzierebbe, ma semplicemente rileva che le risorse saranno "nuove. aggiuntive e complementari e includeranno fonti, fondi, processi e iniziative sotto e al di fuori della Convenzione e dell'Accordo di Parigi”. La decisione raccomanda inoltre l'allargamento delle fonti di finanziamento. Un'altra importante forza trainante per il fondo perdite e danni è stata la società civile, che si è mobilitata per la richiesta del fondo, la giustizia climatica e l'equità. I negoziati sull'articolo 6 sono continuati in sottofondo durante le due settimane di COP e sono riusciti a fornire significative indicazioni che aiuteranno a rendere operativa e ad ampliare la cooperazione internazionale con approcci di mercato e non di mercato per ridurre le emissioni, sostenere l'adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile. La società civile ha seguito da vicino queste discussioni, intervenendo dove le tutele ambientali, sociali e umane e i diritti delle popolazioni indigene non sono stati rispettati. Ciò vale in particolare per l'area dell'offsetting, che si riferisce all'estrazione della CO2 dall'atmosfera con mezzi naturali o tecnologici per aiutare i paesi a raggiungere emissioni nette pari a zero. Nella decisione finale, una prima bozza che la società civile credeva fosse vaga e priva di salvaguardie critiche e disposizioni sui diritti, è stata riconsegnata all'Organismo di Vigilanza del meccanismo di mercato ex art. 6.4 per ulteriori approfondimenti. Tuttavia, gli osservatori rilevavano un'assenza di “riferimenti alla necessità di qualsiasi mercato di contribuire all'ambizione generale e all'imperativo di rispettare e proteggere i diritti umani”. La COP 27 ha ha tenuto la linea degli 1,5 °C, che rimangono ancora in vita. La conferenza ha anche preso decisioni sostanziali nelle principali aree cruciali per l'attuazione, compresa la mitigazione, l'adattamento, la finanza e i mercati, ma ha lasciato molti a chiedersi quando questi diversi elementi dell'azione per il clima verranno realizzati. I riferimenti alla scienza e all'urgenza sono presenti nella decisione sul programma di lavoro sulla mitigazione, ma alcuni paesi in via di sviluppo, gli LMDC, hanno ritenuto che l'articolo avrebbe dovuto introdurre nuovi elementi rispetto al mandato di Parigi, come gli obiettivi a medio termine, e stabilire la conclusione del programma di lavoro nel 2023 invece di proseguire fino al 2030. Come compromesso, il programma di lavoro ora ha il limite al 2026. Allo stesso modo, c'è stato un invito a riflettere sulle nuove indicazioni dell'IPCC sulla necessità che il picco delle emissioni globali avvenga prima del 2025 per limitare il riscaldamento a 1,5 °C. Analoga disputa c'è stata nelle discussioni sulla finanza, dove i paesi in via di sviluppo hanno sottolineato l'urgenza di fare chiarezza sul “quantum” e sui tempi di di fissazione post-2025 sui finanziamenti per il clima. I paesi sviluppati hanno continuato a insistere per discutere prima degli aspetti tecnici e poi concordare un obiettivo quantitativo nel 2024.
21 Novembre 2022. Conclusa la COP 27 con l'assemblea plenaria. Il documento finale, consensi e delusioni La plenaria ha inizio domenica poco dopo le due di notte ora locale. Poi subisce ulteriori rinvii (video). Nella bozza di testo presentata in plenaria, gli obiettivi di mitigazione sembrano essere niente più di una copia di quanto concordato a Glasgow nel 2021, quando è stata concordata anche una riduzione graduale (phase down) per il carbone. C'erano speranze che il presidente avrebbe ampliato questa "fase di riduzione" per includere tutti i combustibili fossili, ma non c'è nessun riferimento in questo testo. Ecco cosa dice: "Invita le parti ad accelerare lo sviluppo, e la diffusione delle tecnologie e l'adozione di politiche per la transizione verso sistemi energetici a basse emissioni, anche aumentando rapidamente l'adozione di misure di generazione di energia pulita e di efficienza energetica, tra cui l'accelerazione degli sforzi verso la l'eliminazione graduale dell'energia a carbone senza sosta e l'eliminazione graduale delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili, fornendo nel contempo un sostegno mirato ai più poveri e ai più vulnerabili in linea con le circostanze nazionali e riconoscendo la necessità di sostegno verso una transizione giusta". Ci sono state molte discussioni sull'obiettivo di Glasgow degli 1,5 °C. Alcuni paesi hanno cercato di rinnegare l'obiettivo di 1,5 °C e di abolire il meccanismo della irreversibilità degli impegni (ratcheting up). Hanno fallito, ma è stata eliminata dal testo finale una risoluzione per raggiungere il picco delle emissioni entro il 2025. ll gas è stato il grande protagonista di questa COP, con un numero sorprendentemente elevato di accordi firmati a margine del vertice. Il documento finale della COP 27 contiene un provvedimento per incentivare “l'energia a basse emissioni”. Ciò potrebbe significare molte cose, dai parchi eolici e solari ai reattori nucleari e alle centrali elettriche a carbone dotate di cattura e stoccaggio del carbonio. Poiché a pensar male ... potrebbe anche valere per il gas, che ha emissioni inferiori rispetto al carbone, un fossile "buono". Non c'è stato alcun miglioramento rispetto all'impegno dello scorso anno di ridurre gradualmente l'uso del carbone, nonostante l'intensa le pressioni di molti Paesi che volevano inserire nel testo un impegno a "ridurre gradualmente tutti i combustibili fossili". Ecco invece le parole del documento concordato alla COP 27 che istituisce il fondo per aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici. Il linguaggio è significativo. "La Conferenza delle Parti ... decide di istituire nuovi accordi di finanziamento per assistere i paesi in via di sviluppo che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, in risposta a perdite e danni, anche con particolare attenzione ad affrontare perdite e danni fornendo e assistendo nella mobilitazione di risorse nuove e aggiuntive, e che questi nuovi accordi integrino e includano fonti, fondi, processi e iniziative nell'ambito e al di fuori della Convenzione e dell'Accordo di Parigi. Decide inoltre, nel contesto dell'istituzione delle nuove modalità di finanziamento ... di istituire un fondo per la risposta a perdite e danni il cui mandato include un focus sulla gestione di perdite e danni". Il testo, concordato da quasi 200 paesi, istituisce anche un comitato per elaborare le regole per realizzare il fondo. Quel comitato riferirà alla COP del prossimo anno. Con la creazione di un nuovo Fondo perdite e danni, peraltro ancora vuoto, la COP 27 manda un avvertimento agli inquinatori che non possono più andare avanti senza problemi con la loro distruzione climatica. D'ora in poi dovranno risarcire i danni che hanno causato e rendere conto alle persone che stanno affrontando tempeste , inondazioni devastanti e mari in sollevamento (CAN). Lo stesso Guterres si compiace del risultato ottenuto su loss and damage (video) ma dice: "Siamo chiari. Il nostro pianeta è ancora in rianimazione. Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni ora, e questo è un problema che questa COP non ha affrontato. Un fondo per perdite e danni è essenziale, ma non è una risposta se la crisi climatica cancella dalla mappa un piccolo stato insulare o trasforma un intero paese africano nel deserto. Il mondo ha ancora bisogno di passi da gigante in termini di ambizione climatica. La linea rossa che non dobbiamo oltrepassare è la linea che porta il nostro pianeta oltre il limite di temperatura di 1,5 gradi. C'è stato anche probabilmente qualche progresso nella riforma del sistema finanziario globale, con un numero crescente di paesi alla ricerca di modifiche urgenti alle banche multilaterali del mondo che, sostengono, non riescono a fornire i finanziamenti necessari. Questo è ora diventato un argomento serio di discussione. Consensi anche per l'apertura di un possibile processo di riforma del sistema finanziario delle Nazioni Unite: è stato accolto qualche elemento dell'Agenda di Bridgetown, promosso da Mia Mottley, la coraggiosa leader delle Barbados. Nel testo si legge: le nazioni del mondo "invitano gli azionisti delle banche multilaterali di sviluppo (MDB) e le istituzioni finanziarie internazionali a riformare pratiche e priorità, allineare e aumentare i finanziamenti … e incoraggiare le MDB a definire una nuova visione adatta allo scopo di affrontare l'emergenza climatica globale". Gli altri risultati di COP 27 sembrano però, ancora una volta, deludenti. L'europeo Timmermans dice che avremmo dovuto fare molto di più. I nostri cittadini si aspettano che noi prendiamo la leadership della lotta climatica, cosa che significa ridurre le emissioni molto più rapidamente. L'Australia (Umbrella Group da cui, recentemente, sono state espulse Russia e Bielorussia) dichiara: "Dobbiamo andare oltre, alla luce delle dure scoperte della scienza più recente, anche riconoscendo che le emissioni globali devono raggiungere il picco entro il 2025 per mantenere in vita gli 1,5 °C". L'influenza dell'industria dei combustibili fossili è stata evidente su tutta la trattativa. Questa COP ha indebolito i paesi che assumono impegni nuovi e più ambiziosi. Il testo non fa menzione della graduale eliminazione dei combustibili fossili e fa scarso riferimento alla scienza e all'obiettivo degli 1,5°C (Tubiana). La presidenza egiziana ha prodotto un testo che protegge chiaramente gli stati del petrolio e del gas e le industrie dei combustibili fossili. Questa tendenza va fermata prima della COP negli Emirati Arabi Uniti il prossimo anno. Se il rinnovato impegno formale mantenuto sul limite di riscaldamento globale di 1,5 °C è fonte di sollievo, rimane il fatto che i progressi compiuti in materia di mitigazione dopo la COP 26 di Glasgow sono stati troppo lenti. L'azione per il clima alla COP 27 mostra che siamo sulla soglia di un mondo di energia pulita, ma solo se i leader del G 20 saranno all'altezza delle proprie responsabilità, manterranno la parola data e rafforzeranno la loro volontà. L'onere è su di loro. Tutti gli impegni sul clima devono essere trasformati in azioni concrete, compresa la rapida eliminazione dei combustibili fossili, una transizione molto più rapida verso l'energia green e piani tangibili per fornire sia finanziamenti per l'adattamento che per perdite e danni. Vanessa Nakate, giovane leader dei Fridays for future (in figura), ugandese, ha una visione molto più pessimistica: “Doveva essere la COP africana, ma i bisogni del popolo africano sono stati ostacolati dappertutto. Perdite e danni nei paesi vulnerabili sono ormai evidenti, ma alcuni paesi sviluppati qui in Egitto hanno deciso di ignorare la nostra sofferenza. I giovani non hanno potuto far sentire la loro voce alla COP 27 a causa delle restrizioni alla protesta, ma il nostro movimento sta crescendo e i comuni cittadini di ogni paese stanno iniziando a ritenere i loro governi responsabili della crisi climatica". Alla plenaria ha chiesto a tutti i paesi di una "urgente intensificazione degli sforzi" e si è detta profondamente delusa dal fatto che alcune Parti abbiano cercato di frenare l'ambizione di tutti di moltiplicare gli sforzi per l'abbattimento delle emissioni. L'anno scorso, per la prima volta, un combustibile fossile, vale a dire il carbone, è stato menzionato per la "riduzione graduale" in un accordo sul clima delle Nazioni Unite. A Sharm diversi paesi e la società civile hanno spinto affinché tutti i combustibili fossili, inclusi petrolio e gas, fossero inclusi per l'eliminazione graduale. ma questo non è accaduto, né è stato in alcun modo rafforzato l'impegno sul raggiungimento dell'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Ancora peggio per alcuni è stata l'inclusione nel testo dell'accordo del concetto di "basse emissioni" accanto all'energia rinnovabile, che, come abbiamo detto, è una formulazione che potrebbe essere interpretata come un'approvazione del gas, che è un combustibile fossile più pulito del carbone e tuttavia produce emissioni sostanziali per il riscaldamento del pianeta. Nonostante una discussione senza precedenti sull'equa eliminazione graduale di petrolio, gas e carbone, il risultato finale è stato l'ennesimo rifiuto del riconoscimento formale che tutti i fossili stanno causando la crisi climatica e danneggiando le comunità. Al momento la traiettoria delle emissioni è pericolosamente fuori rotta e l'accordo di Sharm fa ben poco per correggerla. Dalla società civile vengono ovunque preoccupazioni: la mancanza di progressi nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili mostra l'ipocrisia dei governi dei paesi ricchi nel loro bla bla bla nel mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi e rivela la egemonia esercitata nella COP dalle industrie dei combustibili fossili. Disappunto anche sull'articolo 6 che regola il mercato del carbonio, l'offsetting e i permessi di emissione. Cerca di bloccare le scappatoie per le industrie e i paesi inquinanti per fare il greenwashing e ritardare le riduzioni delle emissioni di gas serra, ma manca di trasparenza, consente pratiche contabili discutibili, fa marcia indietro sui diritti umani e sui diritti delle popolazioni indigene. Tra i non molti meriti del documento per la prima volta in assoluto, una decisione della COP fa menzione di soluzioni basate sulla natura (nature based) e dedica una sezione alle foreste. Questa è ovviamente un'ottima notizia. Menziona anche il ruolo dell'alimentazione ed anche questa è la prima volta. La formulazione è però piuttosto opaca e non riconosce apertamente il ruolo che i sistemi agricoli svolgono nella generazione di emissioni di carbonio e altri gas serra. Il testo riconosce che gli impatti del cambiamento climatico aggravano le crisi energetiche e alimentari globali, e viceversa. Si parla di sicurezza alimentare e della particolare vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli impatti negativi del cambiamento climatico. Parimenti notevole di citazione è il fatto che, anche qui per la prima volta, il testo negoziale accrediti quelli che siamo abituati a chiamare tipping point, cambiamenti irreversibili del clima: "Riconosce l'impatto del cambiamento climatico sulla criosfera e la necessità di ulteriori comprensione di questi impatti, compresi i tipping point". La scienza ha per tempo avvisato di questo tipo di criticità anche oltre la criosfera. Uno studio recente ne ha rilevate cinque già a rischio a 1,1 °C: il crollo della calotta glaciale della Groenlandia, che alla fine produrrà un enorme innalzamento del livello del mare, il crollo di una corrente chiave nell'Atlantico settentrionale, l'interruzione della pioggia da cui dipendono miliardi di persone per il cibo e un improvviso scioglimento del permafrost ricco di carbonio. A 1,5°C di riscaldamento, quattro dei cinque punti critici passano da possibili a probabili. Sempre a 1,5°C, diventano possibili altri cinque punti critici, compresi i cambiamenti nelle vaste foreste settentrionali e la perdita di quasi tutti i ghiacciai montani. In totale, i ricercatori hanno trovato prove di 16 punti critici, con gli ultimi sei oltre i 2°C, su scale temporali che variano da pochi anni a secoli. Durante tutta la conferenza ci sono state critiche sul modo in cui è stata gestita dalla presidenza egiziana. In alcuni momenti sembrava che si stesse muovendo troppo lentamente e negli ultimi due giorni è stato riferito che seguiva procedure tutt'altro che trasparenti, il che significava che era difficile per i delegati essere sicuri che tutti stessero avendo la stessa visione delle cose. Annalena Baerbock, il ministro degli Esteri tedesco, ha rilasciato una dichiarazione accusando la presidenza di "ostruzionismo e carenze organizzative", e ha affermato che solo un'alleanza transcontinentale progressista ha impedito il "fallimento totale della Conferenza". Che ruolo ha avuto l'Europa alla COP 27? Il capo dell'esecutivo, Ursula von der Leyen, ha descritto l'accordo COP 27 come "un piccolo passo verso la giustizia climatica", ma ha affermato che per il pianeta serve molto di più. "Abbiamo curato alcuni dei sintomi ma non curato il paziente dalla febbre. COP 27 ha mantenuto vivo l'obiettivo degli 1.5 °C. Sfortunatamente, tuttavia, non ha ottenuto l'impegno dei principali emettitori mondiali di ridurre gradualmente i combustibili fossili, né nuovi impegni sulla mitigazione del clima". Venerdì, con una drammatica inversione a U, l'Unione Europea ha aderito alle richieste dei paesi poveri di creare un nuovo fondo per affrontare le perdite e i danni causati dal riscaldamento globale, una decisione che ha aperto la strada all'accordo all'inizio di domenica. Si è poi dichiarata lieta che la COP 27 abbia aperto un nuovo capitolo sul finanziamento delle perdite e dei danni e abbia gettato le basi per un nuovo metodo di solidarietà tra chi ha bisogno e chi può aiutare, così contribuendo a ricostruire la fiducia tra Sud e Nord del mondo. C'è una lezione che viene dalla COP 27 per la COP del prossimo anno nello Stato petrolifero per eccellenza, secondo la UCL:
Alla fine della ennesima delusione, tutti stiamo vedendo, ancora una volta, i limiti delle COP nella governance della lotta ai cambiamenti climatici. Come andare oltre? Secondo ancora la UCL quello che serve è un apparato meno ingombrante e più maneggevole, che si concentri sugli aspetti più critici della crisi climatica, che faccia il suo lavoro in gran parte al riparo dei media e che presenti un volto meno amichevole verso il settore dei combustibili fossili. Una via da seguire, quindi, potrebbe essere quella di istituire una serie di organismi più piccoli, ognuno dei quali si occupi di una delle questioni chiave, in particolare energia, agricoltura, deforestazione, trasporti, perdite e danni e forse altri. Tali organismi funzionerebbero a tempo pieno, mantenendosi in contatto tra loro e forse riunendosi un paio di volte all'anno. Idealmente, dovrebbero essere composti da rappresentanti sia dei paesi sviluppati che di quelli della maggioranza del mondo. In contatto diretto con i rappresentanti dei governi nazionali, parte del loro mandato consisterebbe nel negoziare accordi che siano realizzabili, legalmente vincolanti e che effettivamente svolgano il lavoro, sia che si tratti di invertire la deforestazione, ridurre le emissioni di metano o ridurre il consumo di carbone. Man mano che tutti i termini e le condizioni saranno concordati, questi potrebbero essere convalidati e firmati dai leader mondiali come una cosa ovvia e senza la necessità del clamore di una conferenza globale. Per concludere la nostra documentazione, teniamo conto che i commenti sulla COP 27 sono e saranno sempre più numerosi. Incominciamo a segnalare progressivamente i più pertinenti. Il primo posto spetta al Guardian, cui tutti dobbiamo riconoscere un giornalismo di straordinaria qualità nei giorni di Sharm. Ci sono poi IISD, Nature, Carbonbrief, WRI, BBC, Washington Post, Le Monde_1, Le Monde_2, La Repubblica Green and Blue, Climate Home News, Italy for climate, Reuters, The Times, Politico, Huffington Post, Quartz, Financial Times, Axios, El Pais, Bloomberg, Al Jazeera, CMCC, Daily Star, Inside Climate News, Sbilanciamoci, Valigia Blu, Resilience ... 28 Maggio 2022. Transizione ecologica e cambiamenti climatici di Toni Federico Il concetto di transizione non si applica ai cambiamenti climatici. Anzi il clima, come ogni altra risorsa ambientale, deve essere restituito agli equilibri che hanno preceduto l’impennata delle temperature. La lotta ai cambiamenti climatici è piuttosto l’obiettivo principale della transizione ecologica in tutte le sue componenti, in particolare quella energetica che deve garantire la neutralizzazione delle emissioni serra a metà secolo. Le transizioni climatiche, i cosiddetti tipping point, sono viceversa i limiti delle variabili di stato climatiche oltre i quali si determina un cambiamento irreversibile del sistema, del quale non possiamo prevedere le conseguenze. Il clima è gravemente compromesso già oggi, quando siamo ai due terzi dell’anomalia termica media terrestre fissata come limite dall’Accordo di Parigi in +1,5 °C. Le concentrazioni di CO2 alle Hawaii (Mauna Loa), causa principale del riscaldamento terrestre, sono a maggio 2022 di 421,72 ppm, +3,84 ppm in 12 mesi. Le emissioni antropogeniche di questo gas che, ricordiamo, non sono una variabile di stato del sistema climatico ma una forzante esogena, cioè una variabile di input. In piena lotta internazionale ai cambiamenti climatici, sono passate dalle 22,75 Gt del 1990 a 35,5 nell’anno di Parigi (+56%) a 36,7 nel 2019 (+61%) a 36,3 nel 2021 dopo ben due anni di crisi pandemica globale. Il trend marginale della crescita al 2019 era di poco meno di un miliardo di tonnellate all’anno. Ci siamo dati in Europa un ben chiaro obiettivo di abbattimento al 2030 del 55%, rispetto al 1990, confermato dal recente REPower EU, che ci deve portare entro il 2030 in EU 27 da 5,7 a 2,5 Gt, e in Italia da 0,52 a 0,23 Gt di emissioni GHG, mentre oggi siamo ancora a 0,42 Gt. Il salto programmato ha l’aspetto di una brusca inversione di tendenza a livello mondiale e di una estrema accelerazione in Europa e in Italia, ma non si tratta di una transizione, concetto che non si applica alle forzanti ma allo stato del sistema, quanto piuttosto di una forte accelerazione delle politiche di mitigazione. Mitigazione ed adattamento sono i due approcci possibili alla lotta per il clima. Mitigare significa ridurre le forzanti dell’effetto serra in atmosfera, cioè le emissioni. Le riduzioni non possono avere effetto immediato sulle concentrazioni, e quindi sulla temperatura media terrestre, a causa della lunga persistenza in atmosfera dei vari gas, che per la CO2 supera i cento anni. La mitigazione ha un effetto globale, come le emissioni che si diffondono rapidamente su scala mondiale. Dovunque effettuata, la mitigazione beneficia l’intero pianeta. Per converso le emissioni di ogni paese danneggiano l’intera umanità per tutto il tempo di permanenza dei gas in atmosfera. Ne deriva che le responsabilità del cambiamento climatico non sono addebitabili al paese che sta emettendo di più su base annua (la Cina), ma a quello che ha il valore massimo dell’integrale delle emissioni su tutto il tempo delle permanenze in atmosfera dei diversi gas (gli Stati Uniti, seguiti dall’Europa). Per una autentica giustizia climatica lo sforzo di mitigazione dovrebbe essere proporzionato al danno arrecato sia in termini di responsabilità storica che di emissioni procapite anche considerando le importazioni ma, questo principio (il noto “chi inquina, paga”) non ha trovato udienza nel negoziato multilaterale sul clima, così perpetuando uno stato di tensione tra Sud e Nord del Mondo con la Cina, ormai il grande emettitore, a fare da avvocato dei paesi in via di sviluppo. L’uso del suolo è causa indiretta di emissioni equivalenti. Qui è in causa lo stato di conservazione del bioma terrestre e degli oceani, capaci entrambi di assorbire CO2 dall’atmosfera, talché la deforestazione di una determinata area verde o forestale, la impermeabilizzazione, la desertificazione di un territorio e il riscaldamento oceanico si traducono in quantità equivalenti di CO2 che restano in atmosfera assumendo il ruolo di emissioni virtuali. Qui c’è spazio per le cosiddette Nature Based Solution, NBS, una tipologia di interventi per proteggere e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e gli ecosistemi... in grado di portare benefici sia per la qualità della vita umana che per la biodiversità (IUCN). Al momento attuale si valuta che a livello mondiale il contributo dell’uso del suolo, delle foreste e dei relativi cambiamenti (LULUCF) equivalga ad una significativa fonte netta di emissioni di GHG, contribuendo a circa il 23% delle emissioni antropogeniche di CO2, metano e protossido di azoto nel 2007-2016, calcolato in CO2eq. Per EU 27 nel 2019 il bilancio è vantaggioso, pari a -249 MtCO2eq e per l’Italia è pari a -40 MtCO2eq. Alcune NBS si possono prestare a forme di greenwashing , come il carbon offsetting, alberi in cambio di emissioni, utilizzato da aziende di ogni tipo per mettere in atto una sorta di carbon land grab (Monbiot). Se si calcola che la riforestazione può catturare al massimo 2,5 Gt di CO2 ogni anno (il 6% delle emissioni) i programmi di offsetting dovrebbero occupare 3,6 Mkm2, oltre la metà di tutta la terra disponibile nel mondo per praticare qualche forma di offset. L’adattamento è invece l’insieme delle politiche di intervento sul territorio che dovrebbero contenere gli effetti del cambiamento climatico, riducendo la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici. Per un verso non ci possono essere politiche, misure o cambiamenti capaci di contrastare gli eventi climatici estremi, in aggravamento già con un warming medio di un solo °C; per un altro verso le azioni di adattamento sono necessariamente locali, ne beneficiano solo le comunità che le mettono in atto e sono le più disparate e non sono nemmeno necessariamente green. Adattamento e mitigazione sono pertanto complementari e sono sinergici solo in alcuni casi, come avviene per le soluzioni NB. Per ridurre l’impatto dei fenomeni estremi, come tifoni e inondazioni, si può infatti ricorrere alla protezione, rigenerazione e ampliamento delle barriere naturali costiere, costituire dai mangrovieti, dalle aree umide o dalle strutture coralline. Operazioni che garantiscono anche una fonte vitale di cibo e di materiali per le popolazioni locali.
Gli strumenti a disposizione sono quelli della transizione energetica e dell’economia circolare. Negli ultimi trent’anni in Italia si è assistito ad un processo di decarbonizzazione molto significativo nel settore elettrico. Fra il 1990 e il 2019 la generazione elettrica da fonti fossili è rimasta stabile (-2%) ma il mix è cambiato, con il carbone ridotto del 40% e il gas che ha sostituito il petrolio come fonte primaria. La crescita della produzione nazionale di elettricità nel periodo (+35%) è avvenuta totalmente a carico delle fonti rinnovabili, che in trent’anni sono più che triplicate e hanno raggiunto oggi il 40% della produzione nazionale. Nel 1990 era il 16%, allora composto solo da idroelettrico e geotermico. Nel 2020 la generazione elettrica ha subito una lieve contrazione del 5%, avvenuta interamente a carico delle fonti fossili. In trent’anni il settore elettrico nazionale ha più che dimezzato le proprie emissioni specifiche passando da 578 nel 1990 a 258 gCO2/kWh nel 2020. Questo imponente processo di decarbonizzazione è dovuto innanzitutto alla penetrazione delle fonti rinnovabili, in particolare tra il 2008 e il 2014, in secondo luogo ai miglioramenti tecnologici e di efficienza degli impianti alimentati a gas naturale e infine al graduale phase out del carbone, iniziato nel 2012 e acceleratosi negli ultimi anni. La più attesa delle transizioni abilitanti è quella dei trasporti, responsabili di oltre 109 MtCO2eq di GHG e ancora dipendenti dai combustibili fossili per più dell’80%. Con il 25% delle emissioni totali, i trasporti sono il terzo settore a livello nazionale in termini di emissioni GHG, dopo l’industria e gli edifici. Sono l’unico settore che non ha ridotto le proprie emissioni dal 1990. Il 97% delle emissioni dei trasporti deriva dall’utilizzo di carburanti fossili. Le emissioni associate ai consumi elettrici sono il 3% del totale e riguardano ancora quasi esclusivamente il trasporto su rotaia, sia urbano che extraurbano. Il modo di spostare passeggeri e merci in Italia resta profondamente insostenibile da molti punti di vista, con un impatto negativo sulla qualità della vita di milioni di cittadini. Quello che si chiede è ridurre il più possibile la domanda di trasporto e decarbonizzare la domanda rimanente tramite l’utilizzo di veicoli a emissioni zero, per tre obiettivi: risparmiare traffico evitando gli spostamenti non necessari (avoid); attuare lo spostamento modale di passeggeri e merci verso sistemi di trasporto pubblico a basso impatto (shift); migliorare l’efficienza propria del mezzo di trasporto per mezzo dell’elettrificazione (improve). L’industria è il primo settore per emissioni GHG in Italia: nel 2019 è responsabile del 37% delle emissioni nazionali (46% nel 1990). Al tempo stesso, l’industria ha contribuito più di ogni altro settore alla mitigazione: dal 1990 al 2019 le emissioni si sono ridotte del 36%, pari a 86 MtCO2eq, in buona parte per l’elettrificazione, l’innovazione e anche per il rallentamento della produzione industriale, aggravato dalla crisi economico - finanziaria del 2008. L’intensità carbonica del valore aggiunto si è ridotta di oltre un terzo dal 2005 al 2019, segnando un importante trend di decarbonizzazione che si è arrestato solo nel 2020 a causa della pandemia. Il settore degli edifici è il secondo per emissioni in Italia, con 116 MtCO2eq, il 57%, lo stesso del 1990 quando però era il 70% del totale. Gli edifici residenziali hanno ridotto le emissioni del 26% mentre gli edifici del terziario le hanno aumentate del 25%, in linea con la crescita economica del settore. Nel periodo dal 1990 al 2019, le emissioni del settore agricolo si sono ridotte del 13% passando da 46 a 40 MtCO2eq, principalmente per la riduzione delle emissioni non energetiche che assommano a circa i tre quarti delle emissioni del settore. Di queste, quasi due terzi, la metà delle emissioni totali del settore agricolo, sono originate dagli allevamenti di bestiame, a causa della digestione enterica degli animali (oltre 13 MtCO2eq) ma anche della gestione delle deiezioni (6,3 MtCO2eq). La rimanente parte delle emissioni non energetiche riguardano la gestione del suolo agricolo (8,1 MtCO2eq). Tutte le fonti che compongono la parte non energetica delle emissioni agricole si sono ridotte o sono rimaste stabili negli ultimi trent’anni, con la gestione del suolo agricolo che ha fornito il contributo più significativo alla comunque lieve riduzione delle emissioni (fonte: I4C). Dobbiamo definire un sistema alimentare sostenibile, solido e resiliente in accordo con la strategia europea Farm to Fork che garantisca sicurezza alimentare e riduca l'impronta climatica e ambientale, promuovendo la riduzione degli sprechi e il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili, dal punto di vista dell'accesso al cibo, della salute e dell'ambiente, basati maggiormente sul consumo di frutta, verdure e cereali, anche per contenere il grave impatto della zootecnia sui cambiamenti climatici e sulle materie prime. Sul fronte dell’adattamento la Strategia italiana non ha ancora trovato applicazione sul territorio a causa della mancata finalizzazione del cosiddetto PNACC, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. La procedura di VAS, infatti, ne ha messo in evidenza i numerosi limiti, comportando la necessità di apportare correzioni e modifiche con un allungamento delle tempistiche di approvazione. È da 15 anni che si discute del tema in Italia ma ancora si agisce con lentezza, pur nella consapevolezza che il nostro territorio sia altamente vulnerabile. In quest’ottica è quindi grave l’assoluta assenza dell’adattamento (o di qualche richiamo al PNACC che ne potesse accelerare l’approvazione e implementazione) nel PNRR dove si parla solo di dissesto idrogeologico. In discussione è anche il target 13.2 dell’Agenda 2030 che prescrive di migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce. Pandemia guerra e soprattutto malcelati opportunismi sembrano aver sottratto all’attenzione della politica e del pubblico la grave minaccia dei cambiamenti climatici: un problema in meno, si dirà, salvo poi ad accorrere all’ultimo momento quando sarà troppo tardi. L’obiettivo dell’Agenda sembra ormai nelle mani delle giovani e dei giovani, delle organizzazioni della società civile, dei movimenti come FfF, delle donne, le cui associazioni sono meno ciniche delle controparti maschili, e perfino dei bambini (UNICEF). Riteniamo che l’Italia debba dotarsi al più presto di una Legge nazionale sul clima, seguendo il modello europeo. La Legge dovrà stabilire tutte le modalità, gli obblighi e i target della mitigazione e dell’adattamento, assicurando i relativi finanziamenti. Può sostituire e finalizzare il PNIEC, di ingloriosa memoria, ormai dimenticato dal MITE, perché stabilirebbe i fini obbligatori della decarbonizzazione e, con essi, i mezzi necessari a intraprendere un percorso ormai condiviso e reso obbligatorio dall’Europa.
2021. DOPO LA PANDEMIA LA COP 26 di GLASGOW. PHASEOUT DEL CARBONE (Resoconti disponibili su VOLUME V) Sabato 13 Novembre 2021. Finisce qui la COP 26 con l'Assemblea plenaria di chiusura e il documento finale emendato dall'India
Oggi alle 8:00 precise vengono rilasciati una nuova bozza di accordo finale in sette pagine e 71 punti, e una nuova bozza di decisione dell'organismo di gestione dell'Accordo di Parigi, CMA, in nove pagine e 97 punti. L'assemblea informale di stocktaking è rimandata di qualche ora al primo pomeriggio. Il confronto tra i due documenti, quello di oggi e quello di mercoledì, mette in evidenza qualche ulteriore passo indietro frutto della negoziazione e delle discussioni di questa notte. La terza bozza di questa mattina ha mantenuto le risoluzioni chiave per perseguire i tagli delle emissioni di gas serra in linea con l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C. Alle nazioni verrà chiesto di tornare il prossimo anno per rafforzare i loro obiettivi sui tagli alle emissioni, gli NDC che finora sono inadeguati, e per accelerare l'eliminazione graduale dei sussidi per l'energia a carbone e i combustibili fossili. I delegati studieranno attentamente la decisione fino all'una, ora locale, quando saranno chiesti i loro commenti, dopo di che la presidenza cercherà di passare rapidamente a una sessione conclusiva in cui possono essere adottate le decisioni finali. I paesi lasceranno Glasgow ben consapevoli che gli attuali impegni collettivi per la riduzione delle emissioni entro il 2030 non sono abbastanza ambiziosi. Non sono allineati con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento del riscaldamento ben al di sotto dei 2 °C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. La migliore delle stime pubblicate in questi giorni proietta l'anomalia termica a fine secolo a 2,4 °C, guadagnando appena 0,3 °C rispetto agli NDC ufficiali di Luglio. Il progetto di testo della presidenza invita inoltre tutti i paesi ad accelerare gli sforzi verso l'eliminazione (phaseout) dell'energia a carbone e dei sussidi inefficienti (termine rimasto per tutti misterioso) per i combustibili fossili. L'atmosfera dei colloqui è stata generalmente costruttiva, sebbene alcune nazioni abbiano cercato di annacquare gli accordi sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili e di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. I paesi in via di sviluppo vogliono, da parte loro, ulteriori garanzie sui finanziamenti per il clima, necessari per aiutarli a far fronte agli impatti di condizioni meteorologiche estreme, perdite e danni. La plenaria conclusiva ha inizio alle 19:25 di Sabato. All'esterno Greta Thunberg sventola il cartellino rosso alla COP 26. Le opposizioni di Cina ed India al phaseout tendenziale del carbone e dei combustibili fossili sembrano insuperabili, così come la riluttanza dei paesi poveri al testo del documento a causa del deficit dei finanziamenti tanto del GCF di Copenhagen quanto delle perdite e danni di Varsavia, il WIM. Cina ed India alla fine avranno ragione della resistenza presidenziale. Il testo viene emendato last minute suscitando una marea di dissensi. Dopo il primo, cash, salta così anche il terzo punto del programma della presidenza inglese: il coal. Opportunamente Boris Johnson si guarda bene dal farsi vedere. Draghi non può fare diversamente. Hollande a Parigi era andato. Il Presidente Sharma, visibilmente contrariato, nel suo ultimo commosso intervento dichiara: "è il momento della decisione e delle scelte di importanza vitale che tutti voi avete impostato e che hanno lanciato un decennio di crescente ambizione sui temi come l'adattamento, la mitigazione, la compensazione delle perdite finanziarie e dei danni e per rimanere sulla strada per mantenere gli 1,5 °C a portata di mano. Abbiamo confermato l'obiettivo dei cento miliardi di dollari e abbiamo quantificato il nuovo obiettivo per la Climate Finance. Queste decisioni concludono gli elementi in sospeso del libro delle regole dell'Accordo di Parigi. Credo che le decisioni che stiamo per prendere dimostrino la rilevanza e la leadership di questo processo multilaterale che promuovono un'azione per il clima inclusiva, riconoscendo l'importante ruolo svolto dai giovani, dalla società civile, delle popolazioni indigene, delle comunità locali e degli altri stakeholder. Ci complimentiamo per l'impressionante impegno e le azioni di tutti coloro che si sono uniti a noi a Glasgow nella nostra visione cash, car, coal, trees. I negoziati sono stati tutt'altro che facili. ve lo dico sinceramente, ma sono rimasto colpito dall'impegno che avete dimostrato per portare a termine il nostro lavoro, per creare consenso su un'agenda senza precedenti e alla fine concordare qualcosa di significativo per la nostra gente e il nostro pianeta. Ognuno di voi e la nazione che rappresentate si è fatto avanti qui a Glasgow accettando di fare ciò che serve per mantenere gli 1.5 °C alla portata. è mio grande onore accompagnarvi attraverso la procedura formale di adozione della decisione finale. Pertanto invito ora la COP ad adottare la decisione denominata Patto sul clima di Glasgow contenuta nel documento FCCC/PA/CMA/2021/L.16. Rispetto a questo testo l'India ha proposto un emendamento dell'ultimo minuto che sostituisce il "phase out" del carbone con un "phase down", ovvero una riduzione graduale. Il nuovo testo in lingua originale è: Parties would commit to “escalating efforts to phase down unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies while providing targeted support to the poorest and the most vulnerable in line with national circumstances and recognising the need for support towards a just transition.” Il testo di questa mattina era invece: “including accelerating efforts towards the phase out of unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies, recognising the need for support towards a just transition.” In data 17 novembre il Glasgow Climate Pact, emendato, si trova ancora in forma "unedited" sui siti UN FCCC. In precedenza, India, Iran e alcuni altri paesi avevano espresso opposizione ai riferimenti alla graduale eliminazione dei sussidi al carbone e ai combustibili fossili. Molti delegati dei paesi svantaggiati hanno espresso il loro disappunto per la proposta dell'India, ma hanno affermato che l'avrebbero accettata, sia pure con riluttanza. Il testo non prevede strumenti di finanziamento specifici per perdite e danni, una richiesta cruciale dei paesi in via di sviluppo. Ma la Guinea, parlando a nome dei paesi del G77, ha affermato che con questa grave mancanza "si può convivere", purché non porti pregiudizio alle nostre sacrosante aspirazioni. "Accettiamo questo cambiamento con la massima riluttanza", hanno detto le Isole Marshall. La Svizzera fa eco alla delusione generale dei paesi occidentali, ribadisce che l'eliminazione del carbone è indispensabile ma non si oppone al documento emendato dall'India. Pesante il dissenso dell'Europa, che si sente tagliata fuori dall'intesa USA - Cina. "Sappiamo benissimo che il carbone non ha futuro", afferma Timmermans, chairman del clima dell'UE, "ma questo non dovrebbe impedirci di prendere oggi una decisione storica". "Per il bene più grande, dobbiamo ingoiare questo boccone amaro", ha dichiarato il Lichtenstein. L'Europa dichiara: "è importante che siamo stati in grado di concordare sulla necessità di ridurre significativamente le emissioni globali in questo momento critico in cui le parti devono aggiornare i loro NDC per dare risposta all'emergenza climatica in linea con ciò che la scienza dice per mantenere vivo l'obiettivo degli 1,5 °C. Per l'UE è di fondamentale importanza che si sia stati in grado di concludere il Rulebook che consentirà di attuare pienamente l'accordo di Parigi. Altrettanto importante è la determinazione ad aumentare la finanza per il clima soprattutto per l'adattamento per i paesi in via di sviluppo più vulnerabili. EU si impegna ad aumentare i suoi contributi e a sostenere la Rete di Santiago per perdite e danni. Il fatto che abbiamo stabilito che dobbiamo mantenere in vita gli 1,5 °C è di importanza storica, ha aggiunto Timmermans. Per molta gente gli 1.5 °C non significano niente. Ma noi potremo dire ai nostri figli che, se facciamo quello che abbiamo promesso qui, l'umanità imparerà a vivere dentro precisi confini, il che significa che c'è un futuro prospero per ogni essere umano su questo pianeta. John Kerry, che certamente ha consentito a Cina e India di prevalere, dichiara che: "La negoziazione perfetta è quella che scontenta tutti", con buona pace di Obama. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che i testi finali sono sostanzialmente dei compromessi che riflettono gli interessi, le condizioni, le contraddizioni e lo stato della volontà politica nel mondo di oggi. “Stiamo ancora bussando alla porta della catastrofe climatica”, ha detto."... credo ancora che il mondo debba eliminare gradualmente il carbone, porre fine ai sussidi ai combustibili fossili e dare un prezzo al carbonio, oltre a onorare l'impegno di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima a sostegno dei paesi in via di sviluppo. Non abbiamo raggiunto questi obiettivi in questa conferenza. Ma abbiamo alcuni elementi per andare avanti”. In poche ore, a fine Conferenza, sono stati annunciati e pubblicati resoconti e commenti da tutte le parti, operatori, esperti, giornalisti, radio e TV, per lo più improntati ad uno scetticismo che talvolta è interessato, talaltra segno di delusione da parte di chi, nel combattimento contro i cambiamenti climatici, non vuol cadere nella abusata trappola di dare spazio a chi cerca di far profittare i propri interessi in salsa green. Ma quella che impressiona è la mobilitazione intorno ai temi del clima, che a questi livelli non si era mai vista: la società civile è in moto e questo ci sembra più importante degli esiti della riunione di condominio di Glasgow o del G20.
24 Giugno 2021. Il Parlamento europeo approva la EU Climate Law, la legge delle leggi
La legge sul clima guiderà la governance dell'UE nei prossimi decenni, a cominciare dall'ampio pacchetto di politiche che la Commissione proporrà il 14 luglio, progettate per ridurre le emissioni più velocemente per raggiungere gli obiettivi climatici. Comprenderà obiettivi più ambiziosi in materia di energie rinnovabili, riforme del mercato del carbonio dell'UE e norme più severe in materia di CO2 per le nuove auto. La maggior parte delle leggi dell'UE sono progettate per raggiungere il precedente obiettivo del blocco di ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 e necessitano di un aggiornamento per raggiungere i nuovi obiettivi. Le emissioni dell'UE nel 2019 sono state inferiori del 24% rispetto al 1990. I nuovi obiettivi sono progettati per mettere l'UE su un percorso che, se seguito a livello globale, limiterebbe l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C, come richiesto dall'Accordo di Parigi. Il 28 giugno i rappresentanti dei paesi membri dell'UE approveranno formalmente la legge. Parlamento e Ue firmeranno poi il testo, un passaggio formale, prima che diventi legge. La legge crea un organismo indipendente di esperti scientifici, due per ciascun paese, per fornire consulenza sulle politiche climatiche, seguire le indicazioni dell'IPCC e definire il budget per i gas serra per le emissioni totali che l'UE può produrre dal 2030 al 2050 per raggiungere i suoi obiettivi climatici. Dopo il 2050, l'UE punterà alle emissioni negative. La Commissione presenterà una proposta per un ulteriore obiettivo per il 2040 sei mesi al più tardi dopo la prima revisione globale nel 2023 prevista dall'Accordo di Parigi. La commissione pubblicherà una stima della quantità massima di emissioni di gas serra che l'UE può emettere fino al 2050 senza mettere in pericolo gli impegni di Parigi (il cd. carbon budget), che servirà anche per definire l'obiettivo rivisto dell'UE per il 2040. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà i progressi collettivi compiuti da tutti i paesi dell'UE, nonché la coerenza delle misure nazionali, verso l'obiettivo dell'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050. La proposta di Climate Law dovrebbe essere approvata a breve dal Consiglio europeo. Sarà poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.
10 Marzo 2021. Il Parlamento europeo propone l’adozione del Carbon Border Adjustment Mechanism Con un meccanismo di adeguamento alle frontiere, CBAM, il prezzo delle merci importate in Europa rifletterebbe più accuratamente il loro contenuto di carbonio. Ciò garantirebbe che gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi dal trasferimento della produzione in paesi con politiche climatiche meno ambiziose. Nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), le industrie dell'UE si trovano ad affrontare una riduzione del limite delle emissioni verso il 2030, insieme a un prezzo da pagare se le emissioni superano un certo livello di riferimento. L'obiettivo è quello di guidare le industrie europee verso un percorso di riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, le importazioni nell'UE non sono soggette all'ETS e quindi acquisiranno un vantaggio competitivo sempre maggiore se i produttori di paesi terzi beneficeranno di costi del carbonio interni inferiori o nulli. Nell'attuale sistema ETS, l'assegnazione gratuita di diritti di emissione a livelli di riferimento mira a salvaguardare la competitività dell'industria ed evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, più diventeranno asimmetrici gli obiettivi di emissione e le misure politiche, più sarà fondamentale livellare efficacemente le condizioni di scambio per l'industria dell'UE attraverso disposizioni rafforzate sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Nel 2015 il rapporto tra le emissioni importate e le emissioni esportate dall'UE era di 3:1, dal momento che l'UE importava 1317 Mt di CO2 e ne esportava 424. L'UE è il principale importatore di carbonio al mondo e il tenore di carbonio delle merci esportate dall'UE è nettamente inferiore a quello delle merci importate. Il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 10 marzo 2021, parte dalla osservazione che gli sforzi europei volti a contrastare i cambiamenti climatici sono superiori alla media degli sforzi internazionali e sottolinea che, per misurare l'impronta climatica complessiva dell'Unione, è necessario un efficace metodo di rendicontazione che tenga conto delle emissioni delle merci e dei servizi importati. Circa il 27 % delle emissioni globali di CO2 dovute alla combustione riguarda attualmente merci scambiate a livello internazionale. Alle importazioni nette di beni e servizi nell'UE è riconducibile oltre il 20 % delle emissioni interne di CO2 dell'Unione. Benché l'UE abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas serra, le emissioni GHG incorporate nelle importazioni verso l'UE hanno registrato un costante aumento, compromettendo in tal modo gli sforzi compiuti dall'UE per ridurre la sua impronta carbonica globale. Il Parlamento chiede pertanto alla Commissione di mettere a punto metodologie intese a determinare l'impronta di carbonio e ambientale di ogni prodotto, adottando un approccio basato sull'intero ciclo di vita e garantendo che la contabilizzazione delle emissioni incorporate dei prodotti sia quanto più realistica possibile, includendo le emissioni prodotte dai trasporti internazionali. Sulla base di tale metodologia si può dare attuazione al meccanismo di CBAM previsto dal Green Deal, a condizione che sia compatibile con le norme del WTO e con gli accordi di libero scambio dell'UE, che non sia discriminatorio e non costituisca una restrizione dissimulata del commercio internazionale. Un CBAM creerebbe un incentivo per le industrie europee e i partner commerciali dell'UE a decarbonizzare le proprie industrie e sosterrebbe pertanto le politiche climatiche dell'UE e globali a favore della neutralità GHG in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il CBAM dovrebbe essere concepito esclusivamente per promuovere gli obiettivi climatici e non dovrebbe essere utilizzato impropriamente come strumento per rafforzare il protezionismo, le discriminazioni o le restrizioni ingiustificabili e al contempo dovrebbe essere non discriminatorio e mirare a garantire condizioni di parità a livello globale. Il Parlamento chiede alla Commissione di proporre, a integrazione dell'introduzione del CBAM, norme e standard più ambiziosi e vincolanti relativi alla riduzione delle emissioni GHG e ai risparmi in termini di risorse e di energia per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, a sostegno del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Ritiene che, al fine di evitare eventuali distorsioni nel mercato interno e lungo la catena del valore, il CBAM dovrebbe applicarsi a tutte le importazioni di prodotti e materie prime coperti dal sistema EU ETS, anche se integrati in prodotti intermedi o finali. In una fase iniziale (già entro il 2023) e previa una valutazione d'impatto, il CBAM dovrebbe applicarsi al settore energetico e ai settori industriali ad alta intensità energetica come quelli del cemento, dell'acciaio, dell'alluminio, della raffinazione del petrolio, della carta, del vetro, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, che continuano a beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 % delle emissioni. Il contenuto di emissioni GHG delle importazioni dovrebbe essere contabilizzato sulla base di parametri di riferimento trasparenti, affidabili e aggiornati per prodotto a livello degli impianti nei paesi terzi e che, qualora l'importatore non renda disponibili i dati, dovrebbe essere contabilizzato il contenuto medio globale di emissioni GHG dei singoli prodotti, ripartito per i diversi metodi di produzione che presentano intensità di emissioni differenti. La fissazione del prezzo del carbonio per le importazioni dovrebbe coprire le emissioni dirette e indirette e quindi anche tenere conto dell'intensità di carbonio della rete elettrica di ciascun paese o, qualora l'importatore renda disponibili i dati, l'intensità di carbonio del consumo energetico a livello di impianto. Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, nel rispetto delle norme del WTO, il CBAM deve imporre oneri per il contenuto di carbonio delle importazioni in modo da rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai produttori dell'UE e la fissazione del prezzo del carbonio dovrebbe rispecchiare l'evoluzione dinamica del prezzo delle quote dell'UE nel quadro del sistema EU ETS. Secondo il Parlamento gli importatori dovrebbero acquistare le quote da una riserva distinta di quote rispetto all'EU ETS, in cui il prezzo del carbonio corrisponde a quello del giorno dell'operazione nell'EU ETS. L'iniziativa deve mirare a rendere superfluo il CBAM man mano che il resto del mondo avrà raggiunto il livello di ambizione che l'UE ha fissato in termini di riduzione delle emissioni di CO2. A tal fine la Commissione deve intensificare gli sforzi per conseguire una fissazione del prezzo globale della CO2 e per agevolare il commercio di tecnologie per la protezione del clima e dell'ambiente, ad esempio attraverso iniziative di politica commerciale come l'accordo sui beni ambientali del WTO. Consequenzialmente l'attuazione del CBAM deve essere accompagnata dall'eliminazione di tutte le forme di sovvenzioni dannose per l'ambiente concesse alle industrie ad alta intensità energetica a livello nazionale.
2019. LA COP 25 di MADRID. TIME FOR ACTION (Resoconti disponibili su VOLUME V) Domenica 15 Dicembre 2019. Termina una inutile COP 25 a Madrid. Conclusioni e cronaca giorno per giorno hanno finalmente avuto un po' di attenzione da parte dei media italiani
P er chi come noi del comitato scientifico segue e rendiconta da anni, giorno dopo giorno, le varie sessioni del negoziato per il clima, la penna si fa pesante nel registrare un'altra delusione ancora. COP 25 è stata sostanzialmente inutile, nonostante la ormai enorme mobilitazione, in particolare dei giovani, tranne che per un aspetto: COP 25 ha messo definitivamente in chiaro che esiste una ridotta di paesi sedicenti avanzati, che ne guidano alcuni altri che avanzati non sono, che non intende rinunciare di un epsilon ai propri affari fossili. Lo scontro con i volenterosi o come li volete chiamare è ormai netto. Il negoziato è negato in radice quando le parti vanno in trincea. Sarà difficile con la sola arma del blame and shame arrivare ad un compromesso e salvare Parigi, né gli appelli alla COP 26 dell'anno prossimo riusciranno a tanto. Il cambiamento climatico ci verrà addosso con tutta la sua forza e pagheranno i più deboli.Ci consola relativamente che stampa e TV italiane si siano finalmente accorte che esiste un problema climatico, più per merito di Greta che per il drammatico spettacolo di Venezia. Così possiamo trovare le cronache climatiche sulle pagine dei giornali e dei TG, e forse questo nostro lavoro non serve più. Ma l'atteggiamento dei giornalisti, benché in divenire, sembra ancora di chi pensa che i nostri problemi sono ben altri. La sinistra si distingue, guarda un po', per i suoi distinguo, un esempio dei quali sono gli articoli di un sempre più desolante Federico Rampini su Repubblica. La destra è viceversa compatta sul chissenefrega. Intanto quali conclusioni dalla COP 25? • La COP 25 aveva il motto "Time for action" e avrebbe dovuto essere, secondo la presidenza cilena, l'occasione per dispiegare le nuove ambizioni in vista dell'impegno per il 2020, preso a Parigi, di rappresentare una progressione che rispecchi la più alta ambizione possibile di ogni paese, anche se molti NDC coprivano il periodo fino al 2030. Il testo di Parigi non richiede esplicitamente nuovi impegni: le parti possono semplicemente [ri] comunicare la stessa offerta che avevano fatto nel 2015 o nel 2016. Dato che gli attuali NDC non sono sufficienti per limitare il riscaldando a 1,5 °C, ci sono stati sforzi nelle COP successive a concordare messaggi che richiedono maggiori ambizioni da tutte le parti. COP 25 era il vertice finale prima della scadenza del 2020, ed è quindi stata vista da molti, ONU, Cile e Spagna compresi, come un ltima possibilità per garantire maggiore ambizione. Allo stato solo 80 paesi, principalmente paesi piccoli e in via di sviluppo, hanno dichiarato la loro intenzione di migliorare i loro NDC entro il 2020, rappresentando solo il 10,5% delle emissioni mondiali. Tutti i grandi emettitori sono assenti da questo elenco. Fa eccezione l'Europa, della quale abbiamo rappresentato nel corso della settimana finale il Green Deal climatico, che però non ha avuto effetti di trascinamento. • La versione di sabato del documento finale della COP 25 si limitava a "reiterate the invitation to parties to communicate their plans". Meno di niente. Forti reazioni generalizzate portavano domenica all'ora di pranzo a un nuovo testo di 1/CMA.2 che richiama con grave preoccupazione l'urgente necessità di affrontare il divario significativo tra l'ambizione attuale e gli obiettivi di limitare il riscaldamento a 1,5 °C o ben al di sotto di 2 °C. Al paragrafo 7, il testo esorta le parti a considerare [quel] divario quando [ri] comunicano o aggiornano i loro NDC, anche se non in un tempo stabilito. Chiede inoltre al segretariato dell'UNFCCC di preparare un rapporto sommando gli NDC prima della COP 26. poco più di niente. • Tutti i problemi del mercato del carbonio di cui all'articolo 6 di Parigi, così come i requisiti di rendicontazione, trasparenza e tempi comuni per gli impegni sul clima sono stati tutti rimandati al 2020, quando i paesi dovrebbero anche sollevare l'ambizione dei loro sforzi. Sull'articolo 6 alla fine della settimana l'accordo era sembrato molto vicino, ma così non è stato. Se ne riparlerà a Bonn, a giugno 2020, una specie di COP 25 e mezza, ricominciando da capo, come molti temono. Lo scontro duro è stato e sarà sul double counting e sul riuso dei permessi di emissione di Kyoto. Poche le prospettive di accordo. • Ci sono state iniziative per aumentare l'ambizione da parte di alcuni attori non statali, ad esempio di 177 aziende, parti della Climate Ambition Alliance, disponibili a tagliare le loro emissioni in linea con l'obiettivo degli 1.5 °C, dopo che un gruppo di 477 investitori, che controllano 34 GUS$ in attività, avevano invitato i leader mondiali ad aggiornare i loro NDC e intensificare l'ambizione. Nessun effetto. • Su Loss and damage la discussione è stata durissima ma alla fine hanno avuto ragione gli Stati Uniti, che pure stanno uscendo da Parigi, nel rifiutare ogni responsabilità e ogni finanziamento aggiuntivo da parte dei paesi sviluppati, anche a testimonianza del loro rifiuto di assumersi una responsabilità diretta di tali danni. Resta un rimando al GCF, peraltro non ancora finanziato, e un generico invito ad una generica platea di donatori ad aumentare la contribuzione. • Sulla contemporaneità dell'assunzione degli NDC, nota come common timeframes, alla fine, non è stato possibile raggiungere un accordo a Madrid e la questione sarà ripresa automaticamente alla prossima riunione intersessionale a Bonn. • Nessun accordo sui formati e i contenuti del reporting. Rinvio a Bonn anche qui. • Entrambi i Rapporti dell'IPCC, quello sugli 1,5 °C, SR15, e quello sugli oceani, SROCC, sono stati solo registrati (noted), piuttosto che accolti (welcomed), dalla risoluzione politica finale. In più il documento esprime gratitudine e riconoscenza agli scienziati che hanno fatto il lavoro. • Sugli effetti dei cambiamenti climatici su oceani e terraferma in materia di adattamento, uno dei testi delle decisioni finali chiede che sia aperto un dialogo a Bonn nel giugno 2020. • Una delle poche, se non l'unica storia di successo alla COP di quest'anno è stata una decisione sul nuovo piano d'azione quinquennale per il genere (GAP), destinato a supportare l'implementazione delle decisioni e dei mandati relativi al genere nell'UNFCCC. Tutto ciò premesso, cioè una battuta d'arresto esiziale, pur conservando al prossimo anno il ruolo di un importante traguardo per l'Accordo di Parigi, molti alla COP 25 stavano addirittura prendendo in considerazione il fatto che potrebbe essere necessario cambiare l'intero processo delle COP dopo Glasgow e ripensare tutto il metodo multilaterale della negoziazione sul clima. I fatti però suonano diversamente. La UK (e l'Italia, partner della COP 26 che fine ha fatto?), ora con un governo conservatore e populista, dovrà fronteggiare la brexit in totale disaccordo con la Scozia che ospiterà la COP 26. Il presidente scozzese della COP 26, Claire O’Neill, non ha potuto nemmeno aprir bocca a Madrid perché impedita da una legge che regola i periodi pre- elettorali. Si attendono i risultati di un vertice UE-Cina a settembre 2020 e le elezioni presidenziali statunitensi a novembre. Entrambi gli eventi potrebbero svolgere un ruolo critico nell'ambizione climatica, inviando un chiaro segnale di intenzione di altri paesi o, nel caso degli Stati Uniti, invertendo la decisione di lasciare l'accordo di Parigi. Nel frattempo i vertici del G7 e del G20 del prossimo anno saranno organizzati dai paesi che hanno svolto un ruolo dirompente nelle COP recenti: Stati Uniti e Arabia Saudita, rispettivamente. Auguri!
2019. LA COP 24 di Katowice. La transizione giusta(Resoconti disponibili su VOLUME IV) I colloqui sul clima delle Nazioni Unite - la COP 24 - sono i più importanti da quando è stato firmato l'Accordo di Parigi nel 2015, perché devono scrivere un nuovo regolamento per i governi per ridurre i gas serra e aumentare le ambizioni, dopo i gravi avvertimenti dell'IPCC se il riscaldamento globale aumentasse di oltre 1,5 °C sopra i livelli preindustriali. Si sono registrati alla COP 24 22.771 partecipanti di cui 13.898 facenti parte delle delegazioni. Gli umori generali non sono affatto buoni all'apertura dei lavori. Ad essi contribuisce non poco il drammatico smog carbonioso polacco offerto ai partecipanti. Durante la settimana che precede la conferenza le concentrazioni di particolato PM 2,5 sono state in media di 47 μg/m3 su Katowice, la seconda città più inquinata d'Europa, due volte superiori alla linea guida dell'OMS per un periodo di 24 ore, e di 59 μg/m3 il sabato, quando i delegati hanno iniziato ad arrivare alla Conferenza. In fatto di umori delle delegazioni il punto più basso della settimana arriverà con la pubblicazione di mercoledì dei risultati annuali del Global Carbon Project. Hanno rivelato che le emissioni di carbonio dai combustibili fossili e dall'industria cresceranno di circa il 2,7% nel 2018. Questo è l'aumento più rapido in sette anni e cancella le speranze che le emissioni abbiano iniziato a raggiungere il picco.
Non ci possiamo sottrarre al desiderio affidare il messaggio di apertura della COP 24 alla piccola svedese Greta Thunberg che ha commosso tutto il mondo. L'incontro di Katowice è il termine ultimo per finalizzare l'Accordo di Parigi e stabilirne il Programma di lavoro (PAWP), con i dettagli necessari per renderlo operativo. I paesi avevano stabilito questa scadenza nel 2016, dopo l'entrata in vigore storicamente rapida dell'Accordo. Tutti i problemi nell'ambito del PAWP sono ancora in fase di negoziazione. Alcune delle questioni principali riguardano la natura ciclica dell'Accordo, in base alla quale i paesi firmatari presentano o aggiornano i propri contributi nazionalmente determinati (NDC) a intervalli di cinque anni, riferiscono regolarmente sui progressi nell'ambito della trasparenza e della responsabilità onde consentire la definizione di un quadro generale che va valutato ogni cinque anni per verificare i progressi collettivi verso gli obiettivi. Le discussioni alla COP 24, in particolare quelle affidate al cosiddetto Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA), si incentreranno su:
Agli altri organi tecnici della COP saranno affidati tra l'altro, gli argomenti seguenti:
Non si può fare a meno di un cenno al Kyoto 2, scaturito dal Doha Amendment e sottoscritto al gennaio 2018 da un numero insufficiente di 122 paesi sui 144 necessari per entrare in forza. Avrebbe dovuto rappresentare la continuazione dello sforzo dei paesi Annesso 1 prima del 2020, anno dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi. Nonostante un invito della Segreteria UN FCCC a procedere su basi voolontarie anche in assenza di ratifica, molti dei paesi coinvolti sono ancora al di sotto del trend di mitigazione che dovrebbe portarli a conseguire l'obiettivo 2020 del Kyoto 2. Per l'Europa, tra i pochi in linea, si tratta del -20% su base 1990. La Silesia Declaration che dà origine al movimento per la just transition (in originale)
We, the Heads of State and Government, Emphasizing that climate change is one of the greatest challenges of our time and a common concern of humankind and that Parties to the Paris Agreement recognized the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge; Stressing that addressing climate change requires a paradigm shift towards building a low greenhouse gas emission and climate resilient economies and societies for all that offers substantial opportunities and ensures continued high growth and sustainable development, while ensuring a just transition of the workforce that creates decent work and quality jobs; Reaffirming that Parties to the Paris Agreement on climate change are taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs, in accordance with nationally defined development priorities, and also reaffirming that the Paris Agreement emphasizes the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with equitable access to sustainable development and eradication of poverty; Recognizing the specific needs and special circumstances of developing countries, especially those that are particularly vulnerable to the to the adverse effects of climate change and that natural disasters and other exogenous shocks, exacerbated by climate change, bring devastating effects to vulnerable workers and people living in poverty with limited savings and no social safety net, increasing the challenges of and the obstacles to just transition, especially for countries characterized by fragile environmental conditions and least developed countries; Also recognizing that circumstances of economic sectors, cities and regions that are most likely to be affected by the transition vary from country to country depending on their level of development; Taking note of the importance of the International Labour Organization’s “Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all”, and its considerations, as appropriate, by Parties while fulfilling their commitments under the Paris Agreement on climate change; Highlighting that the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as its Sustainable Development Goals confirm the need to tackle environmental, social and economic problems in a coherent and integrated manner: 6. Stress that just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs are crucial to ensure an effective and inclusive transition to low greenhouse gas emission and climate resilient development, and to enhance the public support for achieving the-long term goals of the Paris Agreement; 7. Emphasize that development measures to make infrastructure climate-resilient and enhance institutional capacity in this respect have the potential to be a source of decent jobs creation for both women and men while improving resilience, especially in vulnerable countries; 8. Underline employment opportunities that the transition to low-greenhouse gas emission and climate resilient economies have already created and the potential for the creation of a number of additional jobs as a result of increased global ambition; 9. Recognize the challenges faced by sectors, cities and regions in transition from fossil fuels and high emitting industries, and the importance to ensure a decent future for workers impacted by the transition, while working to ensure sustainable development and community renewal; 10. Note the importance of a participatory and representative process of social dialogue involving all social partners to promote high employment rates, adequate social protection, labour standards and wellbeing of workers and their communities, when developing nationally determined contributions, long-term low greenhouse gas emission development strategie 11. Highlight the importance of further work on the just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs, including:
12. Invite all relevant United Nations agencies, including the International Labour Organization, and international and regional organizations, observer organizations including social partners as well as other stakeholders and interested Parties to implement this Declaration. 8 Ottobre 2018: Il Rapporto speciale dell'IPCC sul riscaldamento della terra a 1,5 °C Atteso, arriva puntualmente oggi il Rapporto speciale SR15 dell'IPCC, come dagli impegni presi dal pool di scienziati a Parigi, alla COP 21 del 2015. Il piano editoriale del Rapporto SR15 è impostato su cinque capitoli per un totale di 225 pagine ed è preceduto dal Sommario per i decisori politici, votato in plenaria dall'IPCC riga per riga dopo una settimana di dure trattative ad Incheon nella Corea del Sud, complicate dall'atteggiamento negazionista della delegazione statunitense post-Obama. Il Rapporto dovrà essere modificato per tener conto dei cambiamenti introdotti per far approvare il Sommario. C'è un documento che li contiene, fatto sta che il testo dello SR15 che qui presentiamo non è ancora definitivo. La lista degli autori, inclusi i revisori, è composta da 91 scienziati ed esperti di politica provenienti da 44 nazionalità. I capitoli sono i seguenti:
Va innanzitutto segnalata l'eliminazione della premessa contenuta nella prima bozza del documento come High level statement (> vedi) che sarebbe stata ottima per chiarezza per illustrare i risultati del Rapporto. È un chiaro segno delle difficoltà che ci sono state per ottenere l'unanimità dei governi su quali elementi evidenziare nella presentazione del documento. La fattibilità e le linee guida dell'azione per mantenere l'aumento della temperatura a 1,5 ° C e l'importanza di renderla coerente con l'Agenda 2030 sono state tagliate dalla prima sezione del documento. Sono considerate in dettaglio altrove, ma questa censura dimostra la mancanza di consenso sulle conclusioni generali. I contenuti del Rapporto SR15 nella sua edizione definitiva si possono così rappresentare: Per capire di cosa si tratta parlando di 1,5 °C: Il mondo si è riscaldato di 1 °C sin dai tempi pre-industriali (1850 -1900 secondo IPCC) a causa dell'attività umana. “Estimated anthropogenic global warming matches the level of observed warming to within ±20%” In base alle tendenze attuali, è probabile che supereremo il limite di 1,5 ° C tra il 2030 e il 2052. Il pianeta si sta riscaldando in modo tutt'altro che uniforme", la terraferma più velocemente degli oceani e l'Artico si sta riscaldando a 2-3 volte il tasso medio globale. Il trend del riscaldamento antropogenico è di 0,2 °C per decade (linea rossa nella fig. SPM_1). “Warming greater than the global annual average is being experienced in many land regions and seasons, including two to three times higher in the Arctic. Warming is generally higher over land than over the ocean" C'è un lasso di tempo tra le emissioni di gas serra e il loro effetto sul clima. Ciò significa che il mondo si sta riscaldando ulteriormente e che il livello del mare sta crescendo. Il Rapporto però ritiene improbabile che le emissioni passate siano sufficienti a far salire le temperature oltre la soglia del 1,5 ° C. The anthropogenic emissions ... will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts” Per stabilizzare le temperature, le emissioni devono raggiungere lo zero e rimanerci (Fig. SPM_1). Ciò significa ridurre le emissioni il più possibile e sottrarre l'anidride carbonica dall'aria per eliminare le emissioni residue. L'entità del riscaldamento è in definitiva determinata dal tempo che impiegheremo per raggiungere le zero emissioni. Il riscaldamento globale sta già impattando le persone e gli ecosistemi. I rischi tra 1,5 °C e 2 °C sono proporzionalmente crescenti. “Temperature rise to date has already resulted in profound alterations to human and natural systems, bringing increases in some types of extreme weather, droughts, floods, sea level rise and biodiversity loss, and causing unprecedented risks to vulnerable persons and populations" Gli impatti e i rischi del cambiamento climatico. Ci saranno ondate di caldo, siccità e inondazioni più pesanti a 2 °C rispetto a 1,5 °C. La bozza le definiva "differenze sostanziali negli estremi". Questa formulazione è stata sostituita da "robuste differenze nelle caratteristiche climatiche regionali", dando ragione agli Stati Uniti che sostenevano che sostanziale era un concetto troppo soggettivo. Si prevede che i livelli del mare aumenteranno in questo secolo di 10 cm in più sotto i 2 °C di riscaldamento rispetto agli 1,5 °C. Ciò espone 10 milioni di persone in più ad impatti come le inondazioni costiere, l'acqua salata che si riversa nei loro campi e le forniture di acqua potabile. Il riscaldamento più lento fa loro guadagnare tempo per potersi adattare. Nel corso di secoli e millenni i livelli del mare continueranno a salire dopo che le temperature si saranno stabilizzate. Il disfacimento delle calotte glaciali in Groenlandia e in Antartide potrebbe portare a innalzamenti di diversi metri. Uno dei risultati quantitativi più eclatanti riguarda la perdita di biodiversità. SR15 prevede la proporzione di specie che perderanno metà della loro estensione geografica. Su 105.000 specie studiate, il tasso raddoppia tra il riscaldamento di 1,5 °C e quello del 2 °C, al 16% per le piante, all'8% per i vertebrati e al triplo, il 18% per gli insetti. Circa 1,5-2,5 milioni di chilometri quadrati di permafrost in più scongeleranno in questo secolo con un riscaldamento 2 °C rispetto a 1,5 °C. Una superficie equivalente all'area geografica dell'Iran, del Messico o dell'Algeria. In un circolo vizioso, lo scongelamento del permafrost rilascia metano, uno dei gas serra. La probabilità di un'estate artica senza ghiaccio in mare aumenta di dieci volte, da una volta al secolo a 1,5 °C a una volta ogni dieci anni a 2 °C. Gli ecosistemi marini saranno colpiti dall'acidificazione e dal riscaldamento degli oceani. I 2 °C eliminano virtualmente le barriere coralline, rispetto a un calo del 70-90% per gli 1,5 °C. Le comunità agricole e di pesca saranno colpite più duramente da questi effetti, in particolare nell'Artico, nelle zone aride, nelle isole e nei paesi più poveri. Limitare il riscaldamento globale a 1.5 °C riduce l'importo dei rischi associati alla povertà e ai cambiamenti climatici per un valore che arriva a diverse centinaia di milioni di dollari entro il 2050. Quel mezzo grado di riscaldamento in più è molto negativo per la salute. Espande la gamma di zanzare che trasportano malattie come la malaria e la dengue e il caldo rende l'intera gamma di condizioni più letali. La quantità e la qualità delle colture di base soffrono maggiormente un riscaldamento di 2 °C rispetto agli 1,5 °C, così come il bestiame, peggiorando la disponibilità di cibo in molte parti del mondo. “Overall, food security is expected to be reduced at 2 °C warming compared to 1.5 °C warming, due to projected impacts of climate change and extreme weather on crop nutrient content and yields, livestock, fisheries and aquaculture, and land use (cover type and management)” Si prevede che la crescita economica subirà gli effetti del riscaldamento globale, a parità di tutte le altre condizioni. SR15 non tenta di bilanciare questi danni valutando con i costi e i benefici del taglio delle emissioni e dell'investimento nella resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici. Esistono molti strumenti per proteggersi dagli impatti del riscaldamento globale, come le dighe sulle coste marine o le colture resistenti alla siccità. Ma questi adattamenti hanno dei limiti e alcune popolazioni vulnerabili subiscono perdite. L'Accordo di Parigi ha dato riconoscimento al capitolo "perdite e danni", ma il sistema delle Nazioni Unite non ha ancora dato un sostegno concreto alle vittime. I percorsi verso gli 1.5 °C (Figura SPM_1). Vengono prefigurati due tipi di percorso, il secondo dei quali caratterizzato da un overshoot che si riduce a zero a fine secolo. Solo 9 dei 91 scenari referenziati in SR15 si mantengono sempre sotto gli 1,5°C. Per mantenersi sotto gli 1,5 °C, le emissioni di CO2 dovrebbero diminuire di circa il 45% tra il 2010 e il 2030 e raggiungere lo zero netto nel 2050. Questo percorso è significativamente più arduo di quello necessario per 2 °C che comporta una riduzione di circa il 20% entro il 2030 e zero netto solo entro il 2075. “The first involves global temperature stabilising at or below before 1.5 °C above pre-industrial levels. The second pathway sees warming exceed 1.5 °C around mid-century, remain above 1.5 °C for a maximum duration of a few decades, and return to below 1.5C before 2100. The latter is often referred to as an ‘overshoot’ pathway” Il grafico sottostante (Figura SPM_3a) mostra quanto siano rapide le discese delle emissioni di CO2 (a sinistra) e di non CO2 (a destra) per conseguire gli 1,5 °C. Le linee e le ombreggiature blu mostrano esempi di percorsi che soddisfano il limite di 1,5 ° C con poco (< 0,2 °C) o nessun superamento, mentre il grigio mostra quelli in cui le temperature hanno un overshoot alto temporaneo prima di tornare indietro di nuovo. L'obbligo di raggiungere lo zero netto entro il 2050 è lo stesso per i percorsi futuri con e senza overshoot. Il metano e il black carbon, i gas serra più potenti, dovranno essere ridotti di almeno il 35% entro il 2050, rispetto al 2010. Tuttavia, i tagli delle emissioni non di CO2 devono essere effettuati con attenzione. Il maggior utilizzo di bioenergia per sostituire i combustibili fossili, potrebbe spingere verso l'alto l'inquinamento da ossido di azoto dall'agricoltura che riscalda il clima.
Figura SPM_3a Nel complesso il Rapporto SR15 prefigura una transizione senza precedenti verso una green economy. “These systems transitions are unprecedented in terms of scale, but not necessarily in terms of speed, and imply deep emissions reductions in all sectors, a wide portfolio of mitigation options and a significant upscaling of investments in those options.” I dettagli di questa transizione sono illustrati nel capitolo due di 113 pagine del Rapporto e in un allegato tecnico di 99 pagine, basato sulla ricerca che utilizza modelli di valutazione integrati (IAM > vedi più avanti). Questi modelli combinano diversi filoni di conoscenza per esplorare in che modo lo sviluppo umano e le scelte sociali interagiscono e influenzano l'ecosistema globale. Ci sono molti modi diversi per rispettare il limite dell'1,5 °C sotto un'ampia gamma di ipotesi sul futuro sviluppo umano ed economico. Questi percorsi riflettono diversi futuri in termini di politiche globali e preferenze sociali, implicando compromessi e co-benefici diversi per lo sviluppo sostenibile e altre priorità. Tuttavia, tutti i percorsi 1,5 °C condividono alcune caratteristiche, tra cui le emissioni di CO2 che scendono a zero netto e il consumo di carbone residuo che è in gran parte eliminato gradualmente entro la metà del secolo. Includono anche le energie rinnovabili che soddisfano la maggior parte delle future forniture di energia elettrica, con un uso dell'energia resa più efficiente. Gli investimenti negli usi industriali del carbone non diminuiti sono fermati entro il 2030 nella maggior parte dei percorsi 1,5 °C, dice il secondo capitolo. Alcuni investimenti fossili realizzati nei prossimi anni, o quelli realizzati negli ultimi anni trascorsi, avranno probabilmente bisogno di essere ritirati prima di recuperare completamente i loro investimenti di capitale o prima della fine della loro vita operativa. Questi cambiamenti sono ancora più marcati per il settore elettrico, che va decarbonizzato intorno alla metà del secolo. Ciò significa che entro il 2050 l'utilizzo del carbone nel settore energetico si ridurrà vicino allo 0% e le fonti rinnovabili forniranno il 70-85% del mix energetico. Non includendo la bioenergia, il dispiegamento di energie rinnovabili nei percorsi 1.5C aumenta tra le sei e le 14 volte entro il 2050, rispetto al 2010. L'uso di energia nucleare aumenta nella maggior parte dei percorsi 1.5 °C, ma non in tutti. Tutti i percorsi di 1,5 ° C includono tutti profondi tagli in altri gas a effetto serra, come una riduzione del 35% delle emissioni di metano al di sotto dei livelli del 2010 entro il 2050. La transizione energetica è accelerata di diversi decenni nei percorsi di 1,5 °C rispetto ai percorsi dei 2 °C. Oltre a passare all'elettricità a zero emissioni di carbonio, le riduzioni supplementari nei percorsi da 1,5 °C a quelle da 2 °C provengono principalmente dai trasporti e dall'industria, con le emissioni dell'industria che scendono del 75-90% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2050. Inoltre, la domanda di energia deve essere ridotta in misura maggiore mediante gli sforzi per migliorare l'efficienza degli usi finali.
Vale la pena notare che gli IAM hanno una ben nota propensione verso le
soluzioni tecnologiche, come la commutazione della fonte di
approvvigionamento energetico o l'aggiunta della cattura e stoccaggio del
carbonio (CCS). Gli scienziati IPCC hanno iniziato a esplorare altri modi
per limitare il riscaldamento a 1,5 °C, ad esempio cambiando radicalmente il
modo in cui viene utilizzata l'energia. Infine, vale la pena aggiungere che
i modelli IAM sono in grado di esplorare ciò che è tecnicamente fattibile,
ma non ciò che è socialmente, ambientalmente, politicamente o
istituzionalmente fattibile. Forse la più dibattuta tra le questioni è stata in questi anni quella delle tecnologie carbon negative (NET o CDR). Il rapporto SR15 riconosce che limitare il riscaldamento a 1,5 °C richiederà l'uso delle NET che rimuovono la CO2 dall'atmosfera. Per limitare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5 °C senza overshoot, sarà necessario un certo utilizzo delle NET: “All pathways that limit global warming to 1.5C with limited or no overshoot project the use of CDR on the order of 100-1000 GtCO2 [billion tonnes] over the 21st century” Vale la pena notare che l'SPM sembra sottovalutare il grado in cui potrebbero essere necessarie le NET per limitare il riscaldamento a 1,5 °C rispetto al rapporto SR15 completo. Il SPM afferma che la mitigazione convenzionale non è sufficiente e che c'è un ulteriore bisogno di NET ma dipinge un'immagine troppo rosea su questo. L'SPM parla di rimozione 100-1000 GtCO2 entro il 2100. Ma il rapporto completo mostra un valore medio molto più vicino all'estremità superiore dell'intervallo. Anche con sforzi di mitigazione rapidi, è probabile che le NET saranno tenuti a compensare le emissioni di settori che non possono facilmente ridurre le loro emissioni a zero. Questi settori includono la produzione di riso e carne, che producono metano e il trasporto aereo. Il grado in cui saranno necessarie le NET è importante perché ognuna di esse incontra "barriere economiche e istituzionali" e può essere causa di possibili impatti su persone e animali selvatici. Molte tecnologie NET richiederebbero di cambiare drasticamente il modo in cui utilizza la terra. Ciò include bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) e afforestazione. La BECCS coinvolge coltivazioni, bruciandole per produrre energia, catturando la CO2 rilasciata durante il processo e conservandola in un sito sotterraneo. Non ci sono nemmeno, finore, esperienze significative di BECCS che ne possano assicurare l'efficacia e la sostenibilità. L'afforestazione comporta inoltre la trasformazione di terre sterili in foreste: “Afforestation and bioenergy may compete with other land uses and may have significant impacts on agricultural and food systems, biodiversity and other ecosystem functions and services” Alla geoingegneria viene dedicata poca attenzione. La cosiddetta modificazione della radiazione solare - il pompaggio di particelle nell'aria per riflettere la luce solare - potrebbe essere "teoricamente efficace" nel raggiungere l'obiettivo degli 1,5 °C. Ma è escluso dagli scenari SR15 del modello a causa di "grandi incertezze", "il gap di conoscenza", "rischi sostanziali" e "vincoli istituzionali e sociali". La eccessiva attenzione dedicata dai media e dal mondo industriale alla geoingegneria finirà, si teme, per creare un alibi ai decisori politici per ritardare ulteriormente l'inizio delle azioni necessarie. Una domanda comune sul limiti dell'obiettivo degli 1,5 °C è se ne vale la pena dal punto di vista economico. In altre parole, i benefici dei danni climatici evitati dovuti alle inondazioni, ad esempio, superano i costi cumulativi di riduzione delle emissioni? Sfortunatamente, SR15 non considera esplicitamente il costo totale dei percorsi per gli 1,5 °C, perché la letteratura scientifica sull'argomento è limitata. Invece, il rapporto SR15 esamina i costi di abbattimento marginali globali di questo secolo, i costi per tonnellata delle emissioni evitate. Questi costi sono talvolta calcolati come prezzo del carbonio utilizzato dai modello IAM che utilizzano spesso un prezzo del carbonio come proxy per tutte le politiche climatiche. Il prezzo del carbonio può essere imposto direttamente dal mercato come costo marginale effettivo di abbattimento o implicitamente da politiche di regolamentazione. In generale, l'SPM afferma che i costi di abbattimento marginali sono circa tre o quattro volte più alti nei percorsi degli1,5 ° C, rispetto ai 2 °C. Stabilisce inoltre le esigenze di investimento previste per i percorsi di 1,5 °C: per il periodo dal 2015 al 2050 i costi dei percorsi che limitano il riscaldamento a 1,5 °C sono stimati in circa 900 miliardi di dollari. Si deve tener conto che gli investimenti annuali in tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e nell'efficienza energetica devono aumentare di circa 5 volte nel 2050 rispetto al 2015. Il SPM aggiunge che le "lacune di conoscenza" rendono difficile confrontare questi costi di mitigazione con i benefici del riscaldamento evitato. Ad esempio, i costi dell'adattamento a 1,5 °C potrebbero essere inferiori a quelli dei 2 °C, anche se sono "difficili da quantificare e confrontare". In particolare, tuttavia, mentre i percorsi IAM stabiliscono i costi per limitare il riscaldamento a 1,5 °C, in genere non ne considerano i vantaggi. Questi potenziali danni climatici evitati, limitando il riscaldamento a 1,5 °C, sono molto incerti: “Balancing of the costs and benefits of mitigation is challenging because estimating the value of climate change damages depends on multiple parameters whose appropriate values have been debated for decades (for example, the appropriate value of the discount rate) or that are very difficult to quantify (for example,the value of non-market impacts; the economic effects of losses in ecosystem services; and the potential for adaptation, which is dependent on the rate and timing of climate change and on the socioeconomic content)” L'altro grande capitolo della via agli 1,5 °C è quello dell'adattamento. Il rapporto rileva che, in generale, la necessità di adattamento ai cambiamenti climatici sarà inferiore a 1,5 °C rispetto a 2 °C. Tuttavia, avverte che, anche se il riscaldamento globale è limitato a 1,5 °C, non sarà possibile prepararsi a tutti gli impatti dei cambiamenti climatici. Il rapporto descrive l'adattamento umano ai cambiamenti climatici come "il processo di adeguamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti, al fine di moderare il danno o sfruttare opportunità vantaggiose". La prima opzione di una lista di otto, la gestione del rischio di catastrofi, è definita dagli autori come "un processo per progettare, implementare e valutare strategie, politiche e misure per migliorare la comprensione del rischio di catastrofi e promuovere il miglioramento nella preparazione, risposta e recupero di emergenza". Mentre le temperature continuano a salire, è probabile che ci sia una richiesta crescente di integrazione tra mitigazione e adattamento, "per ridurre la vulnerabilità, anche se capacità istituzionali, tecniche e finanziarie nelle agenzie in prima linea costituiscono dei vincoli". Un'altra opzione di adattamento è la migrazione climatica. Il rapporto rileva che, al momento, vi è "poco accordo sul fatto che la migrazione sia adattabile, in relazione al rapporto costo-efficacia": “Migrating can have mixed outcomes on reducing socio-economic vulnerability and its feasibility is constrained by low political and legal acceptability, and inadequate institutional capacity” Diversamente dal testo del Rapporto SR15, la migrazione non è elencata come opzione di adattamento nell'SPM. L'ultima opzione di adattamento, si riferisce alla possibile diffusione di informazioni climatiche pertinenti tramite previsioni giornaliere e avvisi meteorologici, oltre a previsioni stagionali e persino proiezioni multi-decadali. Questi tipi di servizi sono già utilizzati in settori come l'agricoltura, la salute e la gestione delle catastrofi. Per ridurre i rischi per gli ecosistemi naturali si può procedere con il ripristino degli spazi naturali degradati, il rafforzamento delle azioni per fermare la deforestazione e il perseguimento di un'agricoltura e un'acquacoltura sostenibili. Anhe i costi totali associati all'adattamento al riscaldamento globale di 1,5 °C sono difficili da quantificare e confrontare con i 2 °C per effetto delle lacune nella letteratura scientifica. Il SPM rileva che l'adattamento è stato, in genere, finanziato da fonti del settore pubblico, come i governi nazionali, i canali associati all'ONU e attraverso fondi multilaterali sul clima. L'Accordo di Parigi e lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi climatici si collocano nell'SDG 13 dell'Agenda 2030, il cui obiettivi e target furono lasciati generici quando l'Agenda 2030 fu votata nel 2015, prima dell'Accordo di Parigi. Ma questo non risolve tutti i problemi: tra lotta ai cambiamenti climatici e obbiettivi di sviluppo sostenibile ci possono essere contraddizioni. Il capitolo finale del rapporto (il quinto) è dedicato all'esame di come i cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto sullo sviluppo sostenibile, la povertà e la disuguaglianza. Il SPM rileva che, in tutto il mondo, le comunità più povere, svantaggiate e vulnerabili, alcune popolazioni indigene e comunità locali dipendenti da mezzi di sussistenza agricoli o costieri, rischiano di essere influenzate in modo sproporzionato dal riscaldamento globale. Una gran parte dei poveri del mondo fa affidamento sull'agricoltura di sussistenza e quindi sarà direttamente influenzata dall'impatto dei cambiamenti climatici su temperatura, precipitazioni e siccità. Una affermazione chiave del rapporto è che questi sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C possono effettivamente andare di pari passo con molti altri intesi a risolvere i problemi di disuguaglianza e di eliminazione della povertà. In effetti, limitare la temperatura a 1,5 °C anziché a 2 °C potrebbe risparmiare la povertà, entro il 2050, a diverse centinaia di milioni di persone. La limitazione del riscaldamento globale potrebbe anche aiutare il mondo a raggiungere molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (gli SDG), afferma il rapporto. I 17 SDG sono una serie di obiettivi, concordati nel 2015, che mirano a "porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare a tutti i popoli pace e prosperità" entro il 2030, secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Già segnalate da molti autori, alcune contraddizioni potrebbero sorgere tra le azioni per limitare il riscaldamento a 1,5 °C e gli SDG. Le opzioni di mitigazione coerenti con i percorsi 1.5 °C determinano molteplici sinergie e qualche contraddizione con gli SDG. Gli effetti netti dipenderanno dalla velocità e dall'entità dei cambiamenti, dalla composizione del portafoglio di mitigazione e dalla gestione della transizione. L'adattamento agli effetti del cambiamento climatico e la riduzione delle vulnerabilità climatica può promuovere lo sviluppo sostenibile. Può garantire la sicurezza di cibo e acqua, ridurre i rischi di disastri, migliorare la salute e ridurre la povertà e la disuguaglianza. Le misure di adattamento che riducono anche le emissioni, come gli edifici a basse emissioni di carbonio efficientemente raffreddati, possono aiutare i settori a diventare più green a un costo inferiore. La mitigazione si adatta particolarmente bene agli obiettivi di sviluppo per la salute, l'energia pulita, le città e le comunità e il consumo e la produzione responsabili. Ma se non correttamente gestiti, potrebbero danneggiare gli obiettivi di povertà, fame, acqua e accesso all'energia. Indirizzare i finanziamenti verso infrastrutture che riducano le emissioni e si adattino ai cambiamenti climatici può contribuire a raggiungere l'obiettivo degli 1,5 °C in modo da sostenere lo sviluppo sostenibile e ridurre la povertà. Si intendono compresi fondi privati da investitori istituzionali, gestori patrimoniali e banche di sviluppo o di investimento, nonché fondi pubblici. I governi possono aiutare con politiche che riducono il rischio di investimento per i progetti a bassa emissione e per l'adattamento. Nel SPM viene pubblicato il grafico seguente che riassume gli effetti positivi (sinergie) e negativi (contraddizioni) delle opzioni di mitigazione per raggiungere gli 1,5 °C su ciascuno degli SDG. Sul grafico, la lunghezza totale delle barre rappresenta la dimensione dell'effetto positivo o negativo, mentre l'ombreggiatura mostra il livello di sicurezza (da chiaro a scuro: da basso a molto alto). Le tecniche di mitigazione sono suddivise in tre settori: approvvigionamento energetico, domanda di energia e terra. Le opzioni valutate nel settore dell'approvvigionamento energetico includono biomassa e fonti rinnovabili, nucleare, CCS con i combustibili fossili e BECCS. Il settore della domanda energetica comprende opzioni per migliorare l'efficienza energetica nei settori dei trasporti e dell'edilizia. Il settore fondiario comprende l'afforestazione e la riduzione della deforestazione, l'agricoltura sostenibile, le diete a basso contenuto di carne, una riduzione degli sprechi alimentari e la gestione del carbonio nel suolo.
Il grafico a barre mostra come le opzioni di mitigazione che riducono la domanda di energia, in gran parte attraverso il passaggio a tecnologie e comportamenti più efficienti dal punto di vista energetico, hanno i maggiori impatti positivi e il minimo impatto negativo sugli SDG. Gli obiettivi che vedono i maggiori impatti positivi includono quelli per città e comunità sostenibili, buona salute e benessere ed energia pulita a prezzi accessibili. Impatti negativi possibili e temibili sono quelli della crescita delle popolazioni svantaggiate che fanno ricorso ai consumi di energia fossile o, al converso, politiche di contenimento dei consumi e delle emissioni che aggravano l'arretratezza e la disponibilità di risorse proprio per coloro che già stanno pagando i prezzi maggiori del cambiamento climatico a causa della loro posizione geografica o dell'arretratezza tecnologica. Del pari grave potrebbe essere l'esclusione dal lavoro di coloro che contribuiscono alla catena del valore dei combustibili fossili, ove non si provveda per tempo alle conversioni tecnologiche ed occupazionali necessarie. Le opzioni legate sia all'approvvigionamento energetico che al settore terrestre potrebbero avere un impatto considerevole sulla disponibilità di acqua dolce e sui servizi igienico-sanitari, così come sulla vita terrestre, come mostra il grafico. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che queste opzioni si basano sulla BECCS e sull'afforestazione, che, se implementati su larga scala, potrebbero assorbire grandi quantità di suolo e altre risorse, come l'acqua e la biodiversità. Le contraddizioni tra mitigazione e adattamento, limitando il riscaldamento globale a 1,5 °C, come quando le colture bioenergetiche, il rimboschimento o l'afforestazione invadono il terreno necessario per l'adattamento agricolo, possono minare la sicurezza alimentare, i mezzi di sostentamento, le funzioni e i servizi ecosistemici e altri aspetti della sostenibilità. La gestione di queste contraddizioni richiederà una attenta governance delle energie rinnovabili e delle tecnologie come la BECCS. Afferma il rapporto: "I risultati sottolineano l'importanza di un approccio integrato nello sviluppo di acqua, energia e politica climatica". Le cose da fare. Le più grandi industrie inquinanti dovranno intraprendere cambiamenti radicali. Le energie rinnovabili dovranno fornire dal 70 all'85% di energia entro il 2050. C'è ancora spazio per la generazione da combustibili fossili se combinata con la tecnologia per catturare e immagazzinare le emissioni di CO2, ma è un piccolo spazio: circa l'8% per il gas e quasi zero per il carbone entro il 2050. Le industrie ad alta intensità energetica dovranno ridurre la loro CO2 dal 75 al 90% entro il 2050 rispetto al 2010, se si vogliono rispettare gli 1,5 °C. Un limite a 2 °C richiederebbe una riduzione dal 50 all'80%. Questi abbattimenti possono essere ottenuti con tecnologie nuove e già esistenti che sono tecnicamente provate, ma devono ancora essere implementate su larga scala e sono limitate dai costi e da altri vincoli. Anche l'edilizia e i trasporti dovranno spostarsi pesantemente verso l'elettricità. Gli edifici dovrebbero usare energia elettrica dal 55 al 75% della loro energia consumata entro la metà del secolo, mentre il settore dei trasporti dovrebbe spingere le sue fonti a basse emissioni dal 35 al 65% dei consumo energetico, da meno del 5% nel 2020. Ci saranno scelte difficili su come usare il terreno. Molti scenari dipendono in larga misura dalla bioenergia e/o dall'espansione delle foreste, la afforestazione, potenzialmente in conflitto con la domanda di pascoli e seminativi. Una maggior sostenibilità dell'agricoltura e "diete a minor consumo di risorse", cioè mangiare meno carne, può aiutare a mitigare i fattori di pressione. La riduzione delle emissioni nel settore dell'energia per l'obiettivo degli 1,5 °C richiederà circa 900 miliardi di dollari di investimenti all'anno tra il 2015 e il 2050. L'investimento totale necessario per l'approvvigionamento energetico sale così a livelli tra 1600 a 3800 GUS$ e per la domanda di energia da 700 a 1000 GUS$ in 35 anni. L'investimento necessario è superiore del 12% circa rispetto ai 2 °C. Saranno necessari strumenti per rimuovere la CO2 dall'atmosfera, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio e/o le foreste, per catturare da 100 a 1000 Gt nel corso del secolo, per stare entro gli 1,5 ° C. Se il consumo di materia viene tenuto sotto controllo (tipicamente con l'economia circolare), si riduce al minimo la necessità di rimozione del carbonio dall'atmosfera. Le misure di rimozione del carbonio potrebbero contribuire a contenere o riportare il riscaldamento a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali se il mondo superasse la soglia ma, se utilizzate su larga scala potrebbero avere impatti significativi su terra, energia, acqua e sostanze nutritive. I governi dovranno limitare le contraddizioni (trade offs) e assicurarsi che la CO2 sia rimossa in modo effettivamente permanente. Gli attuali impegni nazionali sul clima previsti dall'accordo di Parigi sono inadeguati all'obiettivo. Porterebbero a 52-58 Gt di emissioni di CO2 all'anno nel 2030, in linea con un aumento della temperatura di 3 °C. Quasi tutti i percorsi verso gli 1,5 °C richiedono che le emissioni di gas a effetto serra scendano al di sotto delle 35 Gt / anno. Minori saranno le emissioni nel 2030, più facile sarà limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Il ritardo nella riduzione dei gas serra rischia di aumentare il costo delle riduzioni, di legare i paesi ad infrastrutture che emettono carbonio o, al contrario, di sprecare gli investimenti effettuati in attività ad alte emissioni. Potrebbe anche aggravare la distribuzione disomogenea degli impatti climatici tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. Nel complesso, gli autori del Rapporto mettono nel Sommario per gli operatori politici che precede il Rapporto stesso solo argomentazioni di cui sono ragionevolmente sicuri. Alcuni resoconti hanno valutato l'entità del consenso contando le quotazioni riportate nelle parentesi che accompagnano le affermazioni. "Sicurezza molto alta" appare cinque volte, "Alta confidenza" 107 volte, "Media confidenza" 60 volte e "Scarsa confidenza" solo due volte. 2017. LA COP 23 di BONN (Resoconti disponibili su VOLUME IV) 6 -17 Novembre 2017: La COP 23 a Bonn sotto la presidenza delle isole Fiji La COP23 tenuta a Bonn è stata in realtà la prima presieduta da una piccola isola in via di sviluppo, le isole Fiji, ma ospitata dalla Germania per motivi logistici e solidaristici. Le speranze erano che questa novità avrebbe dato ulteriore slancio ai negoziati. Un ragazzino figiano di 12 anni ha ricordato kennedianamente ai delegati che "non si tratta di come o chi, ma di ciò che puoi fare come individuo". Almeno il “Piano d'azione per la parità di genere” che evidenzia il ruolo delle donne nell'azione per il clima e promuove l'uguaglianza di genere nel negoziato e la piattaforma delle Comunità locali e dei popoli indigeni, che mira a sostenere il scambio di esperienze e condivisione delle migliori pratiche in materia di mitigazione e adattamento, e l'Ocean Pathway Partnership che mira a rafforzare l'inclusione degli oceani all'interno del negoziato, sono risultati che la Presidenza Fiji può vantare. I discorsi ufficiali della sezione ministeriale della COP23 sono terminati durante le prime ore del sabato mattina, dopo qualche discussione all'ultimo minuto sulla difficile questione della finanza per il clima.
Il Brasile ha presentato un'offerta ufficiale per ospitare la COP25 nel 2019, che dovrebbe essere assegnata all’America Latina o ai Caraibi (anche l'Argentina e la Giamaica sarebbero in corsa). L'offerta del Brasile è stata inizialmente "accettata con apprezzamento” ma un intervento all'ultimo minuto dal Venezuela ha riportato la questione in assemblea. Nel frattempo, Turchia e Italia hanno entrambi segnalato il loro interesse ad ospitare la COP26 nel 2020, un altro anno chiave per il prossimo ciclo di verifica degli NDC. A due anni dall’Accordo di Parigi era previsto che la COP23 sarebbe stata un affare per addetti ai lavori per stabilire le regole di implementazione di quell’accordo. I cronisti riferiscono invece che cj ha pensato la delegazione nordamericana, post Trump natum, a movimentare la platea. Cominciamo allora dalla fine. Dopo la decisione di Trump a giugno che voleva far uscire gli Stati Uniti dal Accordo di Parigi, tutti gli occhi erano sulla delegazione ufficiale degli Stati Uniti per vedere come si sarebbe comportata nei negoziati. Intanto nella prima settimana una Ngo africana chiede di escludere la delegazione US dal negoziato, in altri termini “o dentro o fuori”. Poi, il secondo giorno della COP, la Siria ha annunciato che avrebbe firmato l'accordo di Parigi. Con la recente firma del Nicaragua, in chiave antiamericana più che per abbandono della posizione espressa a Parigi, gli Stati Uniti restano soli al mondo a negare il loro contributo al contrasto ai cambiamenti climatici di cui poi, è incredibile, sono una delle principali vittime. Tuttavia, la delegazione americana ha mantenuto un profilo relativamente basso se si esclude un side event sui “combustibili fossili puliti”, un po’ ridicolo e pesantemente contestato. La delegazione statunitense ha co-presieduto validamente un gruppo di lavoro con la Cina sugli NDC, Nationally Determined Contributions. Vale la pena notare, al proposito, che molti dei negoziatori statunitensi sono gli stessi funzionari che hanno rappresentato gli Stati Uniti ai COP per anni, Parigi compresa. Apparentemente hanno continuato i negoziati con pochi cambiamenti di atteggiamento, anche se si sono messi in posizioni più rigide su questioni come "perdita e danni" e sui finanziamenti. Un po’ di trambusto lo ha provocato un tale Banks dichiarandosi, a nome del governo americano, contrario alla "differenziazione", che è la formula con la quale si recepisce nel cuore dell’Accordo di Parigi il Principio di Rio (e della Convenzione) delle responsabilità comuni ma differenziate, un passo diplomatico essenziale per mettersi alle spalle il muro contro muro tra i paesi Annesso 1 e tutti gli altri, durato dal Mandato di Berlino della COP1 fino alla COP21 di Parigi, venti anni. Per il resto il comportamento della delegazione statunitense non ha mostrato differenze significative rispetto agli anni precedenti. Ma di delegazione americana ce n’era un’altra: la "We Are Still In" che ha allestito un grande padiglione appena fuori dalla sede principale per i colloqui. Ne hanno fatto parte figure importanti, come l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg e il governatore della California Jerry Brown, per dimostrare che ci sono molte voci negli Stati Uniti contro le politiche negazioniste di Trump. La coalizione di città, stati e imprese rappresenta di fatto oltre la metà dell'economia americana. Alla presentazione del Rapporto, Bloomberg ha quindi sostenuto al gruppo dovrebbe essere assegnato un posto al tavolo dei negoziati sul clima: una proposta off the records ma tutt’altro che scandalosa. Il ruolo guida della Cina. Questo ruolo, indiscutibile, è un regalo di Trump. Un modo concreto in cui la Cina ha iniziato a svolgere questo ruolo è nella nuova coalizione Ministerial on Climate Action, MOCA, un gruppo misto costituito da UE, Cina e Canada, concepita durante la COP dello scorso anno dopo il risultato delle elezioni americane. Vale la pena notare, come fa Greenpeace, che questo è unico tra processi negoziali climatici di alto livello in collaborazione tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. È anche un caso molto concreto che dimostra che la Cina sta supportando il negoziato climatico internazionale come partner in una leadership collettiva e condivisa. Il carbone messo al bando? Regno Unito e Canada hanno lanciato a Bonn la "Powering Past Coal Alliance" cui hanno aderito più di 20 paesi e altri attori subnazionali, tra cui Danimarca, Finlandia, Italia, Nuova Zelanda, Etiopia, Messico e gli Stati americani di Washington e Oregon. L'analisi dell’Alleanza dimostra che l'eliminazione del carbone è necessaria entro e non oltre il 2030 nell'area OECD e nell'UE28 ed entro il 2050 nel resto del mondo, pur concedendo che rispettare l'accordo di Parigi, non obbliga i firmatari a iniziare il phase out del carbone ad una specifica data. Inoltre, non impegna i firmatari a porre fine al finanziamento delle centrali elettriche a carbone quanto più semplicemente a limitarlo. Il Regno Unito è già impegnato a eliminare il carbone entro il 2025, come l’Italia, mentre il Canada ha la scadenza al 2030. Non ci sono ovviamente gli Stati Uniti, ma nemmeno Germania, Polonia, Australia, Cina e India. Può sembrare a questo punto paradossale che la cancelliera tedesca Angela Merkel abbia manovrato a Bonn nel tentativo di mantenere la sua leadership climatica sulla scena mondiale. La storia è che il 19 novembre, poco dopo la conclusione della COP23, si è chiuso in Germania il tavolo della possibile coalizione con i grunen e i liberali, anche proprio sulla questione climatica. Per di più la Merkel sa che la Germania non centrerà l’obiettivo di abbattimento delle emissioni di EU 2020. Separatamente, Michael Bloomberg ha usato un side event per impegnare 50 M$ a sostegno della sua campagna anti-carbone negli Stati Uniti e in Europa. Che si fa tra oggi e il 2020? Manca ormai poco al 2020 ma Kyoto2 non è stato ancora ratificato. I PVS possono così accusare i pochi ex Annesso 1 che hanno sottoscritto il Doha amendment (Kyoto2) di non aver fatto abbastanza per rispettare gli impegni presi per il periodo fino al 2020 e tutti gli ex Annesso 1 di non aver dato fondi sufficienti al Global Climate Fund, concordati nel 2009 a Copenhagen. Cina e India, sono stati particolarmente duri rispetto agli impegni pre-2020 anche se Kyoto2 non aveva uno spazio formale nell'agenda dei negoziati della COP23. Facevano notare che, al di là dell’agenda formale, è una questione che mina la fiducia degli uni negli altri. Probabilmente molti paesi sviluppati volevano glissare su Kyoto2 e concentrarsi sul post-2020, ma gli altri hanno insistito per effettivamente raggiungere il picco delle emissioni globali entro il 2020 nei paesi Kyoto2. Alla fine hanno avuto ragione e l'implementazione pre-2020 trova posto nel testo decisionale della COP23. concordato e pubblicato il sabato mattina. L’accordo finale include un accordo per tenere nel 2018 e 2019 ulteriori sessioni di valutazione (stocktaking) dei progressi nella riduzione delle emissioni, nonché due valutazioni dei finanziamenti per il clima che dovranno essere pubblicati nel 2018 e nel 2020. Questi contributi saranno quindi riuniti in una relazione di sintesi sull'ambizione pre-2020 in vista della COP24, che si svolge a dicembre l'anno prossimo a Katowice, in Polonia. Le comunicazioni relative saranno inviate anche ai paesi firmatari del Protocollo di Kyoto che non hanno ancora ratificato l'emendamento di Doha invitandoli a depositare i loro strumenti di accettazione il prima possibile. Diversi paesi europei hanno persino ratificato l'emendamento di Doha qui a Bonn, tra essi Germania e Regno Unito mentre la Polonia, il paese zavorra dell’UE che ha impedito finora la ratifica di Kyoto2 a livello comunitario, ha annunciato i suoi intendimenti di ratificare l'emendamento quest'anno. L'Unione Europea che è formalmente una Parte dell’UNFCCC ha anche suggerito di ratificare Kyoto2 senza la Polonia. Il “dialogo Talanoa”. A Parigi si stabilì che nel 2018 dovrebbe esserci un momento unico per "fare il punto" di come starà procedendo l'azione per il clima. Queste informazioni saranno utilizzate per informare il prossimo round degli NDC, previsto per il 2020. Questo modo di riconoscere "l'ambizione potenziata (enhanced)" - un termine ormai di gergo - è stato visto come un importante premessa del meccanismo di ratcheting a lungo termine dell'Accordo di Parigi che mira ad aumentare l'ambizione in cicli scanditi con scadenze ogni cinque anni. Originariamente chiamato "dialogo facilitativo", il nome di questo processo una tantum del 2018 è stato cambiato in "dialogo Talanoa" per riflettere un approccio tradizionale alle discussioni utilizzato nelle isole Fiji per un modo di dialogare "partecipativo, trasparente e inclusivo". L’approccio" finale del dialogo Talanoa è stato incluso in un allegato di quattro pagine al documento finale della COP23. È strutturato attorno a tre domande: "Dove siamo? Dove vogliamo andare? Come ci arriviamo? ", ma include anche nuovi dettagli, come la decisione di accettare interventi da stakeholder non governativi e la decisione di creare una piattaforma online per ricevere contributi e dare una nuova enfasi sugli sforzi compiuti nel periodo pre-2020. Inoltre, afferma esplicitamente che il dialogo "non dovrebbe portare a confronti conflittuali che escludono talune Parti. Il dialogo Talanoa, che partirà nel 2018 (ma perché non da subito?), è stato inserito nelle decisioni della COP23. Questo testo è stato soggetto a modifiche fino alla fine della COP23, quando le Parti hanno negoziatola misura in cui volevano essere impegnate nel processo Talanoa. Alla fine si dice di "accogliere con apprezzamento" il dialogo, una frase significativa, posto che una bozza precedente, che pure parlava di endorsment, non lanciava ufficialmente il dialogo Talanoa come ha fatto il testo finale. Sul tavolo c’erano anche proposte più deboli. La fase preparatoria del dialogo Talanoa inizierà nel prossimo anno in vista della fase politica condotta dai ministri del COP24 in Polonia. Un momento chiave per il dialogo Talanoa sarà anche la pubblicazione dell'IPCC del Rapporto speciale sugli 1.5 °C previsto per il settembre 2018.
Il libro delle regole di Parigi. Come già alla COP22 di Marrakech, l'anno scorso, i negoziati in questa sessione erano centrati attorno ai tentativi del GdL APA di compiere progressi significativi nello sviluppo delle regole di attuazione di Parigi. Il lavoro dell’APA copre diversi settori, tra cui la definizione del quadro degli impegni delle Parti, gli NDC, la segnalazione trqasparente degli sforzi di adattamento e delle azioni intraprese per un "stocktacking globale" degli sforzi di mitigazione nel 2023 e come monitorare il rispetto dell'accordo di Parigi. La scadenza per questo lavoro è la COP del prossimo anno in Polonia, ma l'obiettivo a Bonn era di creare una bozza di queste linee guida per l'implementazione, con opzioni e disaccordi delineati nel modo più chiaro possibile per mostrare ciò che ancora occorre risolvere. Il testo finale COP23 dà atto che nel 2018 potrebbe essere necessaria una sessione negoziale supplementare tra i colloqui intersessionali di maggio e la COP24 a dicembre per garantire che il regolamento di Parigi sia finito in tempo. Questo sarà deciso durante l'incontro di maggio, anche se le prime bozze del testo suggerivano agosto-settembre 2018 come il momento preferito per tale sessione aggiuntiva. Gli NDC. È stato rilasciato all'inizio della settimana un documento di 179 pagine che raccoglie le posizioni di tutte le Parti sulle modalità necessarie per comunicare i piani d'azione nazionali NDC sul clima. La dimensione del testo indica che rimangono differenze significative su come dovrebbero essere organizzati, consegnati e aggiornati gli NDC. Il WRI dice che le Parti si sarebbero bloccate sui temi della flessibilità e della differenziazione. Il documento va perciò sintetizzato nelle opzioni possibili. Migliore l’intesa su come affrontare il global stocktacking del 2023 e poi ogni cinque anni, per cui si prevede una versione più formale del dialogo Talanoa. Le discussioni si sono incentrate sull'equità, così come lo scopo dello stock, cioè per esempio se includerà perdite e danni. Hanno mostrato progressi reali anche i negoziati sulla trasparenza prevista dal regolamento di Parigi riguardano il monitoraggio della conformità egli impegni delle Parti, in linea con il "quadro di trasparenza rafforzata" definito dall’Accordo di Parigi. Per ora il testo sulla trasparenza è di 46 pagine.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai delegati della COP23 durante il suo discorso che l'Europa coprirà eventuali deficit di finanziamento per l'IPCC causati dal dietro-front degli Stati Uniti decisione di tirare il suo finanziamento del corpo scientifico. "Non mancherà un euro", ha detto Macron. Il Regno Unito ha anche annunciato che si impegnava a raddoppiare il suo contributo.
I big data. La Repubblica Democratica del Congo (RDC) e sei altri Paesi hanno chiesto un nuovo punto all'ordine del giorno per considerare un nuovo “Gateway” informatico, come piattaforma di scambio delle emissioni controllata dalle Nazioni Unite e progettata per "incoraggiare, misurare, riferire, verificare e rendere conto delle maggiori ambizioni da parte di entità aziendali, investitori, regioni, stati, province, città e organizzazioni della società civile". La proposta ha suscitato preoccupazioni perché potrebbe aumentare l'influenza delle multinazionali sui negoziati delle Nazioni Unite. Preoccupazioni simili sono emerse durante la prima settimana della COP23 in ordine ad una proposta dall'Ucraina per avvicinare le società energetiche al processo negoziale climatico dell'ONU posizionando le multinazionali dell'energia in un "livello intermedio" tra l'UNFCCC e i governi nazionali. Strada da esplorare nel 2018.
2016. LA COP 22 di MARRAKECH
(Resoconti disponibili su
VOLUME IV)
Novembre 2016: Chiusa la COP 22 di Marrakesh in un clima avvelenato dall'elezione di Donald Trump “Nessuno può fermare l’azione globale per il clima e “L’azione pre-2020 deve essere rafforzata e accelerata”. Con queste parole d’ordine si è conclusa il 18 di novembre 2016, ad un anno dall’Accordo di Parigi, la 22° Conferenza delle Parti della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici. Quali sono i passi in avanti concreti, se ci sono stati, al di là della grande preoccupazione per il possibile cedimento degli Stati Uniti? Per uno strano gioco del destino i delegati della COP 22 si sono trovati a Marrakech per rendere operativo l’Accordo di Parigi, la stessa città dove si tentò 15 anni fa di avviare l’attuazione del Protocollo di Kyoto, che andò come sappiamo. Coincidenza infausta. L’euforia dei primi giorni per la ratifica straordinariamente tempestiva dell’Accordo di Parigi è naufragata pochi giorni dopo nella preoccupazione per l’elezione di Donald Trump, forse il peggiore dei negazionisti, certo il più pericoloso, alla Casa Bianca. Ebbene, che lo si voglia o no, Trump è stato il protagonista della COP 22 e resocontare su questo evento rischia di diventare una cronaca delle congetture fiorite a Marrakech sul ruolo futuro degli Stati Uniti. Per molti aspetti il mondo è politicamente ed economicamente molto diverso da quello che era 15 anni fa. L'Accordo di Parigi è entrato in vigore, fornendo certezza al lavoro dei delegati che devono preparare il “Libro delle regole” dell’accordo ed eliminando la possibilità che alcuni paesi possano richiedere concessioni e indebolire il Trattato. Gli Stati Uniti non sono più il maggior emettitore del mondo. Economicamente, l’energia rinnovabile, in diversi paesi sviluppati e in via di sviluppo, compete ormai come prezzo e capacità tecnologica con i combustibili fossili. Questa da sola è più che una ragione che ha spinto un gran numero di multinazionali a scegliere la strada dello sviluppo low carbon, una scelta di strategia su cui Trump non potrà fare molto. Dal Marocco le prese di posizione di 360 imprese sono arrivate chiare, molte di loro erano state finanziatrici della campagna dei repubblicani negli Stati Uniti.. Il timore non è che queste cambino idea, ma che Trump possa invertire il trend recente degli Stati Uniti favorendo le produzioni più inquinanti e ostacolando lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Ma c’è il resto del mondo e il mercato è ormai definitivamente globale. Con l’inizio della operatività del sistema cap&trade nazionale cinese, nel marzo 2017, il 60% del prodotto interno lordo del mondo includerà un prezzo del carbonio. Dalla COP 22 ci si aspettavano due cose: dimostrare che la Convenzione è in grado di dare concretezza allo a slancio generato da Parigi come è avvenuto a Kigali con l’emendamento del Protocollo di Montreal che ha messo al bando gli idrofluorocarburi (HFC), potenti gas serra, o con il nuovo meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio dal settore dell'aviazione civile internazionale (ICAO). C’era poi da avviare un imponente lavoro tecnico per il completamento accelerato delle modalità, procedure e linee guida che renderanno l'accordo di Parigi implementabile. È difficile rendicontare di progressi significativi a fronte di un lavoro tecnico ancora troppo preliminare. COP 22 è riuscita a creare un senso di urgenza e di responsabilità per la messa a punto di un “Libro delle regole” che dovrà essere concluso per il 2018 come termine ultimo: un anno in meno di quanto molti avevano previsto a Parigi, ma un anno in più di quanto richiesto dai paesi meno sviluppati e più vulnerabili che sostengono l'adozione delle decisioni quando sono pronte, per evitare l’attesa della decisione dell’ultima regola e la pubblicazione del Libro. La storia dice che per le regole di Kyoto ci sono voluti tre anni e la convocazione di una COP supplementare ad-hoc. I delegati a Marrakech si sono fatti effettivamente carico di un lavoro tecnico accelerato, ma i segnali di natura politico-economica attesi dalla seconda settimana ministeriale sono piuttosto quelli che vengono dall’esterno della COP 22.
La Presidenza marocchina ha invitato e ospitato circa 50 capi di Stato e di governo e ha convocato molti eventi di alto livello, tra cui una iniziativa per accelerare l'azione sui finanziamenti per il clima. È stata inoltre rafforzata l’Agenda d'azione globale per il clima, lanciata nel 2014 con lo scopo di catalizzare l'azione pubblica, privata e della società civile pre-2020 mediante il lancio del Partenariato di Marrakech, che mira a concretizzare l'agenda e dare una roadmap per l'azione 2017-2020. Molti paesi hanno infatti lamentato che, nonostante l'Accordo di Parigi in vigore, l’emendamento Doha del 2012 non ha ancora una ratifica e le parti non hanno negoziato il nuovo accordo per migliorare l’azione pre-2020 ai sensi del Protocollo di Kyoto. Per i paesi in via di sviluppo, questa è stata una promessa ancora non onorata. Il documento è stato ridotto nel corso della seconda settimana da quattro ad una sola pagina che ribadisce l’Accordo di Parigi nelle sue parti meno controverse. Voluto dal paese ospitante, vuole evitare che l’eredità di Marrakech sia solo quella dei piccoli passi in avanti sull’implementazione tecnica di Parigi. Nei fatti gli incontri ad alto livello sono stati un campionario di perorazioni dei governi, delle imprese e della società civile contro un probabile “trumpismo” climatico negli anni avvenire. Sul concetto di irreversibilità dell’Accordo di Parigi si sono spesi Ban Ki-moon, alla sua ultima COP, Patricia Espinosa, alla sua prima ed anche l’inviato speciale obamiano per i Cambiamenti climatici Jonathan Pershing, per cui questa potrebbe essere l’ultima. Secondo tutti loro la rapida entrata in vigore dell'Accordo di Parigi lo renderebbe a prova di Trump in quanto una volta entrato in vigore vi è un periodo di attesa di tre anni per qualsiasi paese che intenda ritirarsi, seguito da un anno prima che il ritiro abbia effetto. Non è pero chi non abbia visto, tra i delegati, che un conto è non ritirarsi, altro è coinvolgersi attivamente nell’azione climatica. John Kerry, segretario di Stato americano, infine pessimisticamente ha detto che "nessuno ha il diritto di prendere decisioni basate esclusivamente sulla ideologia per conto di miliardi di persone". Un elemento su cui hanno fatto leva tutti è che la politica di Trump consegnerebbe la leadership mondiale della green economy nelle mani della Cina e con essa tutti i vantaggi del mercato … e del prestigio, anche perché ora, a differenza dei tempi di Kyoto, tutti gli emettitori, grandi e piccoli, aziende e società civile, sono dentro l’Accordo, quello che per anni aveva chiesto l’altro Presidente negazionista Bush figlio, l’affossatore di Kyoto. Ha finito per passare in secondo piano l’elemento di maggiore importanza nella dinamica globale del clima, cioè che a conti fatti gli impegni attuali (INDC) sono inadeguati a rimanere al di sotto di 2 °C a fine secolo e a colmare il divario delle emissioni stimato in 12-14 GtCO2eq, pari ad un quindicennio delle emissioni delle auto in Europa. Parzialmente consolatorio è risultato l’annuncio che il Fondo per l’adattamento ha ricevuto contributi per il 2016 di 81 milioni di dollari, superando il suo obiettivo di raccolta fondi. Tornando alle tecnicalità interne all’Accordo di Parigi, Marrakech ha registrato discreti progressi nella definizione del Libro delle regole da scrivere entro il 2018 e per la gestione delle cosiddette "questioni orfane”, come l'articolo 12 (istruzione, formazione e sensibilizzazione del pubblico), che non erano ancora state esplicitamente incluse nelle agende degli organi della Convenzione. Nuovi elementi di chiarezza sono stati forniti sui preparativi per il dialogo facilitante del 2018, che dovrà fare avanzare l’ambizione dell’Accordo di Parigi e orientare la preparazione degli NDC, la versione aggiornata degli INDC alla luce degli obiettivi e del Rapporto sullo scenario a 1,5 °C che l’IPCC sta preparando. Progressi sono stati compiuti durante la prima settimana della conferenza su vari elementi di merito, vale a dire la mitigazione, l'adattamento, la trasparenza, lo stocktake globale del 2023, l'implementazione e la conformità, e altre questioni relative all'attuazione. Proficuo anche il lavoro degli organi tecnici SBI e SBSTA, su una serie di questioni come la capacitazione, le perdite e i danni per i quali è stato approvato un Piano di lavoro quinquennale a partire dal 2017, la trasparenza e la contabilità dei contributi pubblici ai paesi in via di sviluppo. Si poteva fare di più, dicono molti, anche perché il negoziato non è andato avanti nella settimana ministeriale pur essendo tutti i delegati ancora a Marrakech. Nella realtà poi i delegati stessi dichiaravano per lo più di non essere ancora pronti a discutere le regole e che preferivano per ora i piccoli passi. Nella discussione in APA, il Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, non poteva che evidenziarsi il perdurare delle contraddizioni pur sempre ancora presenti alla conclusione di Parigi, in particolare la non chiara differenziazione delle responsabilità tra paesi con livelli di sviluppo diversi, la troppo diversa attenzione ai periodi pre e post 2020 che preoccupa i paesi che temono che l’atteggiamento dei paesi sviluppati sia meramente dilatorio, la portata non ben definita degli NDC, ora che è chiaro che gli INDC non sono adeguati agli obiettivi dell’Accordo, se registrali in maniera separata o unitaria, come dare lo spazio necessario all’adattamento, compito per ora mal supportato negli INDC anche se si è raggiunto l’accordo che tutti i Paesi dovranno rendicontare sull’adattamento entro i primi cinque mesi del 2017, i flussi dei finanziamenti e delle tecnologie ed altro ancora. A Conferenza chiusa dobbiamo ammettere che le aspettative per quanto riguarda i progressi a Marrakech sono state, forse ingiustamente, esaltate dalla rapida entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, e sono ulteriormente cresciute per la necessità di inviare forti segnali di unità e determinazione data l'incertezza causata dai risultati delle elezioni americane. Un'altra lezione appresa è che in tempi di incertezza il mondo guarda ad una nuova leadership. Alla COP 7, nel vuoto lasciato dagli Stati Uniti usciti dal Protocollo di Kyoto, la leadership fu dell'UE che riuscì a portare dentro Canada, Giappone e Federazione Russa. Con un vuoto di leadership in arrivo, molti stanno scrutando i segni di una nuova guida. Saranno i grandi player, vale a dire la Cina e l'UE, a portare avanti l’azione per il clima? L’Europa francamente non ci sembra godere di buona salute. La Cina, pur da sempre leader indiscusso dei paesi in via di sviluppo e dotata di capacità, prestigio e forza economica, non è un paese democratico e finora avrebbe badato piuttosto alle proprie convenienze, ma resta il candidato d’elezione: una vera rivoluzione. Intanto 48 paesi membri del Forum vulnerabili si sono impegnati ad avere il 100% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2050. Può essere un segno di spostamento della leadership verso i paesi di piccole dimensioni e grandi in ambizione. Sembra poco probabile. L’incredibile è che a metà della seconda settimana il vice ministro degli Esteri cinese, Liu Zhenmin, ha dovuto dichiarare che il suo paese non ha inventato il cambiamento climatico per ingannare gli Stati Uniti, secondo l’accusa elettorale di Trump. Se si guarda alla storia dei negoziati sul cambiamento climatico, ha detto Liu, l’IPCC è nato con il sostegno dei repubblicani durante l'amministrazione di Reagan e del Bush senior alla fine degli anni 1980. Siamo al punto che la Cina deve garantire agli Stati Uniti che il cambiamento climatico è un fatto serio e certo quando, fino a ieri, erano gli Stati Uniti ad accusare la Cina di approfittare del suo status di esente da obblighi di mitigazione ai sensi della Convenzione pre-Parigi. Tutti i documenti della COP 22 si possono scaricare dalla pagina dedicata del sito dell’UNFCCC. Intanto apprendiamo che la COP 23 sarà presieduta dalle Isole Fiji ma ospitata dalla Germania a Bonn, perché il piccolo Stato non ha proprie strutture e capacità.
Giugno 2016: Parigi: una nuova governance per il cambiamento climatico, di Toni Federico Abstract C’è una crisi climatica in atto che mette in seria discussione l’equilibrio ecologico del pianeta e lo stesso sviluppo economico e sociale così come lo conosciamo. La base scientifica del cambiamento climatico è piuttosto evidente, al di là di ogni inutile polemica: pompando in atmosfera gas serra oltre la resilienza dell’ecosistema atmosfera-oceano, cambiano i flussi di energia riemessi dalla terra che si scalda in misura proporzionale all’aumento dello stock atmosferico di gas ad effetto serra. A Parigi, nel Dicembre 2015, al culmine di un quarto di secolo di trattative in un quadro di governance globale piuttosto incerta, si è finalmente trovato un Accordo in base al quale l’aumento della temperatura media terrestre dovrebbe stare ben al di sotto dei 2° C di anomalia rispetto al periodo preindustriale. (> leggi il testo completo)
2016. PARIGI, LA COP 21 CAMBIA LA STORIA DEL NEGOZIATO (Resoconti disponibili su VOLUME III)
L'ACCORDO DI PARIGI, VERSIONE ITALIANA a cura della Fondazione per lo sviluppo sostenibile Il testo dell'accordo come entra a Parigi Ruolo e responsabilità della COP 21 I governi di più di 190 nazioni vanno a Parigi per discutere un nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici, per ridurre le emissioni antropogeniche globali di gas serra ed evitare la minaccia di cambiamenti irreversibili del clima. Ma a Parigi c’è il terrore e la guerra. Non ce lo saremmo mai aspettato ma la COP 21 è blindata, le manifestazioni vietate e gli ambientalisti obbligati agli arresti domiciliari. Ci saranno Barack Obama degli Stati Uniti, Xi Jinping della Cina, Narendra Modi dell’India, Angela Merkel, David Cameron e anche Matteo Renzi. A differenza dei colloqui di Copenaghen, in cui i leader mondiali sono arrivati all'ultimo minuto delle due settimane di colloqui, per trovare i loro team negoziali nel caos e senza un accordo chiaro per consentire loro di firmare, questa volta i leader arriveranno all'inizio della conferenza e potranno dare ai loro team negoziali istruzioni chiare per un accordo definitivamente strutturato alla fine delle due settimane. Lunedì mattina la Presidenza francese aprirà la conferenza con una sessione riservata ai capi di stato, un “leaders event” sollecitato dal governo francese, e guidato dal ministro degli Esteri Laurent Fabius, Presidente della COP 21, e dal ministro dell'ambiente Ségolène Royal. Certo è che negli incontri bilaterali si parlerà di terrorismo più che di clima. La speranza è che la gravità del contesto porti a risultati per l’uno e per l’altro. Sappiamo che se le emissioni di gas a effetto serra continueranno ad aumentare, passeremo la soglia oltre la quale il riscaldamento globale diventa catastrofico e irreversibile. Tale soglia è stimata probabilisticamente ad un aumento della temperatura superficiale media terrestre a fine secolo di 2 °C di sopra dei livelli pre-industriali, mentre sulle traiettorie delle emissioni attuali ci stiamo dirigendo verso un aumento di circa 5 °C, la differenza di temperatura tra il mondo di oggi e l'ultima era glaciale. Nonostante un apparente rallentamento del riscaldamento terrestre le temperature continuano a salire, smentendo i proclami degli scettici, ormai pochi ma agguerriti e ben finanziati. I record termici degli ultimi mesi confermano purtroppo che le variazioni osservate nei ritmi di crescita non sono statisticamente significative. Per invertire questa tendenza occorre il contributo di tutti, in parziale contraddizione con quelli che sono stati i primi passi della Convenzione climatica alle COP di Berlino e di Kyoto. Quel mondo diviso in due, tra poveri e ricchi, Nord e Sud, Paesi obbligati ed esentati dall’abbattere le emissioni non esiste più. Ma raggiungere un accordo tra 196 paesi sarà mai facile, come abbiamo visto nel 2009 a Copenhagen, dove la COP fu accompagnata da attese paragonabili a quelle di oggi per Parigi, dove c’era il nuovo Presidente americano e un nuovo Patto si prevedeva che sarebbe stato scritto. A distanza di sei anni ed altrettante COP, un osservatore da lontano potrebbe dire che siamo allo stesso punto. Abbiamo invece ragione di credere che il lungo e logorante lavoro di questi anni darà i suoi frutti, anche sotto la spinta dei sempre più frequenti disastri climatici che colpiscono tutti, anche i più tiepidi come la Federazione Russa. Come si legge sul Guardian il Protocollo di Kyoto è stato un trattato internazionale ben scritto, a tenuta stagna, completamente giuridicamente vincolante, un trattato sotto la Convenzione climatica di Rio de Janeiro, essa stessa vincolante. Ma non ha raggiunto i suoi obiettivi, perché non è stato ratificato dagli Stati Uniti, e perché la Russia gli ha dato il via quando forse era troppo tardi. E nessuno dei paesi che non hanno rispettato i loro impegni assunti nel quadro di Kyoto è stato sanzionato né lo sarà mai. Il disimpegno dei paesi non Annesso 1 si è inoltre rivelato una applicazione restrittiva e controproducente del Principio delle responsabilità comuni ma differenziate che non si è ancora riusciti a rimontare adeguatamente. Il peso di un accordo a Parigi, questo lo si sa, ricadrà finalmente su tutti i paesi in modo proporzionato, ma il successo della lotta al cambiamento climatico dipende dai grandi emettitori. L'UE taglierà le proprie emissioni del 40%, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030. Gli Stati Uniti ridurranno le emissioni del 26-28%, rispetto ai livelli del 2005, entro il 2025. La Cina porterà le sue emissioni al picco entro il 2030. La diplomazia climatica ha adottato per Parigi un approccio bottom-up che è quanto di più lontano ci possa essere da un impegno globale vincolante. Anzi si è chiesto ad ogni paese di fare la sua proposta e inviarla alla Convenzione con un formato che conosciamo con l’acronimo INDC. Il cambio di tattica ha avuto successo: nazioni responsabili di oltre il 90% delle emissioni globali di oggi hanno inviato i loro INDC con i loro obiettivi. Ci sono tutti i principali paesi sviluppati e in via di sviluppo, anche se il loro contributo è alquanto differenziato: nel caso dei paesi sviluppati si sono richiesti tagli effettivi delle emissioni, ma per i paesi in via di sviluppo il discorso si è articolato in una serie di obiettivi tra cui certamente l’abbattimento delle emissioni rispetto al business as usual, ma anche impegni per aumentare l'energia a basse emissioni, per l’adattamento e per preservare le foreste. Le analisi degli INDC approvati dalle Nazioni Unite, che presentiamo in altra parte di questa stessa pagina, dicono che questi impegni volontari sarebbero sufficienti a tenere il mondo a circa 2.7-3 °C dell’anomalia termica terrestre. Non è sufficiente senza impegni vincolanti a rispettare le proposte, a non retrocedere da esse (backsliding) ed anzi a istituire un sistema di revisione in avanti degli obiettivi di emissione ogni cinque anni, tutti elementi chiave di qualsiasi accordo di Parigi. Parigi lancerà poi un appello universale al di fuori della cerchia delle sue competenze, rivolto alla società civile e alle imprese affinché le città, i governi locali e le imprese stesse diano il loro contributo alla mitigazione. Qui siamo certi, leggendo i movimenti in atto in tutto il mondo, che questa chiamata di corresponsabilità avrà successo. L'altra questione chiave è il finanziamento. I paesi più poveri vogliono che si fornisca loro aiuto per investire in tecnologie pulite, per ridurre le loro emissioni di gas serra, e per adattare il loro territorio ai più che probabili danni del cambiamento climatico. Si tratta di un problema estremamente controverso. A Copenaghen, i paesi donatori hanno deciso di erogare 30 miliardi US$ all’anno come assistenza finanziaria "fast-start” ai paesi poveri, e hanno dichiarato che entro il 2020 , avrebbero portato i flussi finanziari ad almeno 100 miliardi di US$ l'anno. Come pietra angolare di qualsiasi accordo di Parigi, i paesi poveri vogliono assicurazioni che questo impegno sarà coperto. Vogliono anche che i danni climatici (Loss and Damage) siano risarciti con fondi ulteriori e che si diano garanzie per gli anni oltre il 2020. Ci sono valutazioni moderatamente ottimistiche. Vedremo. Certo è che finora l’impegno non è stato confermato ed anzi si è chiesto che non solo i paesi ricchi, ma tutti contribuiscano con la formula “qualora siano in condizioni di farlo”. Il cambiamento climatico aumenta il rischio degli eventi estremi come tempeste, siccità e inondazioni, precipitazioni ricorrenti e cambiamenti a lungo termine delle temperature e dei livelli del mare. Sarebbe un errore limitare le valutazioni d'impatto alla natura ed alle infrastrutture, perché il cambiamento climatico interessa una gamma di questioni relative allo sviluppo sostenibile molto più ampia come la salute, la sicurezza alimentare, l'occupazione, i redditi e le condizioni di vita, l'uguaglianza di genere, l’istruzione, le abitazioni, la povertà e la mobilità. I disastri legati al clima interessano già oltre 200 milioni di persone ogni anno. Per gli oltre due miliardi e mezzo di persone che vivono con meno di 2$/die, le crisi climatiche possono innescare temibili spirali di sottosviluppo. Persone e paesi ad alto reddito possono far fronte agli shock attraverso assicurazioni private, vendendo beni o impegnando risorse economiche. I poveri possono solo ridurre i consumi, l'alimentazione, rinunciare alla cura delle malattie, all’istruzione dei bambini o vendere risorse da cui dipende la loro sopravvivenza. Emissioni pro-capite di CO2 nel mondo (fonte: IEA WEO 2015)
Gli impatti sulla salute sono causati dal degrado ambientale dell’aria, dell’acqua potabile, del cibo e delle abitazioni. In forma acuta sono causati dalle ondate di calore, da inondazioni e siccità, dalle tempeste tropicali, da inattese forme di infezioni. Aggravano inoltre la cronica scarsità d'acqua, la malnutrizione, lo stress psicosociale, gli spostamenti, le migrazioni e i conflitti. È stato stimato che entro il 2004, il modesto riscaldamento in corso dal 1970 aveva già provocato oltre 140 000 vittime in più all'anno. Il cambiamento climatico può contribuire alla diffusione del virus HIV, a causa della crescente povertà e degli spostamenti delle popolazione. I bambini di età fino a due anni, nati durante una siccità, hanno oltre il 70% di probabilità di patire la malnutrizione. Negli anni che seguono le inondazioni, sono stati riscontrati gravi effetti tra i bambini in età prescolare a causa di un accesso ridotto al cibo, di una maggiore difficoltà di fornire cure adeguate e di una maggiore esposizione ai contaminanti ambientali. Il cambiamento climatico agisce come un moltiplicatore del rischio della fame che, entro il 2050, subirà un aumento dal 10 al 20% a causa delle perdite di produttività. Per quella data si prevedono 24 milioni di bambini malnutriti in più, +21%, quasi la metà nell’Africa sub-sahariana. Al contempo i prezzi per le colture più importanti, riso, grano, mais potrebbero aumentare fino al 150% entro il 2060. Studi recenti (FAO) sostengono che i prezzi dei prodotti alimentari saranno più che raddoppiati nei prossimi 20 anni con un trend superiore a quello del decennio a venire e con il cambiamento climatico tra le cause più importanti.
Il cambiamento climatico aumenta la vulnerabilità, impattando i sistemi e le istituzioni che sostengono la salute umana e il benessere, compresi gli ecosistemi, i mezzi di sussistenza, l'occupazione, e la prestazione di servizi sociali. La sola Africa è la patria di più di 650 milioni di persone che dipendono da colture pluviali in ambienti già colpiti da carenza idrica e dal degrado del territorio. Due terzi della superficie coltivabile potrebbe essere persi entro il 2025. Disastri legati al clima possono danneggiare le infrastrutture che supportano la salute e il benessere, come i servizi sanitari, i servizi pubblici comuni, l’energia, i sistemi di comunicazione, la polizia, ed anche sovraccaricare i sistemi di protezione sociale e le reti di sicurezza. 5,3 miliardi di persone non hanno alcun accesso alla copertura di sicurezza sociale, e le politiche esistenti e i sistemi di protezione sociale sono spesso insufficienti per migliorare la resilienza del territorio. Il cambiamento climatico potrebbe causare un picco della disoccupazione e un peggioramento delle condizioni di lavoro nelle aree urbane, a cominciare dai trasporti. A causa dell’esistente marginalità sociale, delle discriminazioni o di politiche e istituzioni di protezione insufficienti, gli impatti del cambiamento climatico sono distribuiti tra i diversi gruppi sociali in maniera ineguale. Alcune caratteristiche come l'età, il sesso, l’etnia, il ceto sociale o la casta, sono fortemente associate alla vulnerabilità sociale. In particolare le norme, i ruoli e le relazioni di genere già determinano impatti diversi su uomini e donne, anche per la salute. Il mondo si sta sempre più urbanizzando: già più della metà della popolazione vive in aree urbane, ed entro il 2050 potrebbe arrivare ai due terzi. Quasi tutta la crescita urbana avverrà nei paesi in via di sviluppo, dove più del 50% della popolazione vive in baraccopoli, luoghi altamente vulnerabili, con materiali edilizi precari, accesso limitato alle infrastrutture e mancanza di sicurezza. Ciò è aggravato dal fatto che il 15% della popolazione urbana mondiale vive in zone costiere basse, altamente esposte agli impatti dell'aumento del livello del mare e agli eventi climatici estremi. (> more)
LA CHIUSURA DELLA COP 21 Sabato 12 Dicembre, ore 19:30. Si chiude la COP 21 con l'approvazione per acclamazione del Patto di Parigi (> vedi l'assemblea di chiusura in differita) Laurent Fabius si scusa del ritardo, motivato da questioni rilevanti. Il testo (> vedi) risulta modificato rispetto a quello distribuito alle 13:30, correzioni puramente materiali, dice il Presidente. Dopo alcune precisazioni formali, alcune dalla sala, il Presidente dichiara: "L'Accord de Paris est acceptèe" il martello con cui dichiaro accolto l'accordo è piccolo ma è per una grande cosa. La commozione del Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile Cronaca e storia del negoziato climatico pag. 4 L'assemblea acclama l'Accordo. La retorica è misurata. Il Sud Africa dedica l'Accordo a Nelson Mandela. Dure critiche del Nicaragua. L'Europa dice ai francesi che il Patto è un loro successo, e che tutti noi europei ne siamo orgogliosi: sarebbe il primo atto di successo del negoziato multilaterale sul clima dopo il Protocollo di Kyoto, 18 anni fa. La Cina dice che il Patto forse lascia aree di miglioramento, ma è un passo in avanti storico. Un segnale forte per uno sviluppo low carbon e sostenibile. John Kerry definisce il Patto una tremendous victory per noi e per le future generazioni. 196 paesi e 196 opinioni oggi si riuniscono in una visione unica e progressiva. Diamo un forte segnale ai mercati in favore di una innovazione sostanziale del modello di sviluppo. Gli Stati uniti e Obama personalmente ringraziano la Francia, vittima del terrorismo. Il Venezuela definisce il preambolo del Patto come incredibilmente rivoluzionario perché restituisce all'accordo tutte le dimensioni sociali e i diritti umani, della donna e dell'ambiente. Ringrazia Papa Francesco la la sua enciclica Laudato sì. Ringrazia il comandante Ugo Chavez che ha voluto questo accordo. Dice Ban Ki-moon che il Patto di Parigi è monumentale. L'accordo dimostra una nuova solidarietà. Prefigura una nuova era di energia pulita e rinnovabile. La leadership francese è stata determinante in un quadro irto di difficoltà. Hollande, commosso, dice che la storia ricorderà il 2015 come l'anno dell'Accordo di Parigi. Questa è la più bella e la più pacifica delle rivoluzioni. La storia è di chi si impegna, non di chi fa calcoli. Ringrazia Al Gore, un precursore presente in sala. L'assemblea applaude. Copenhagen è dimenticata. La Francia si impegna a rivedere il suo impegno di abbattimento delle emissioni prima del 2020. Sabato 12 Dicembre, ore 11. Il Comitè de Paris consegna il testo finale del Patto di Parigi Tra grandi attese si chiude l'attività del Comitè de Paris con la presentazione da parte del Presidente Laurent Fabius del testo del Patto di Parigi che sarà oggetto dell'approvazione della COP 21 convocata in assemblea plenaria nel pomeriggio alle 15:45. > scarica il Patto di Parigi Fabius dice che è stato fatto un grande lavoro, prima dall'ADP che ha lavorato per quattro anni e ha negoziato per tutta la prima settimana a Parigi, poi dai 150 capi di Stato e di Governo che sono intervenuti a Parigi nei primi due giorni della COP 21 per dare al Patto un impulso decisivo, infine dai Ministri e dai capi delegazione negli ultimi giorni. Il testo che è stato licenziato è quanto si è potuto ottenere di meglio in un contesto difficile: contiene l'indicazione strategica degli 1,5 °C, la conferma del metodo degli INDC con la revisione periodica ogni 5 anni che si richiede che non sia mai regressiva, l'assegnazione formale e vincolante del Fondo per il Clima di 100 Miliardi di dollari entro il 2020, esso pure soggetto a verifica periodica, un fondo iniziale per il loss and damage di un miliardo di dollari, ma, soprattutto, contiene di più prezioso l'accordo pieno di 196 Paesi, con esigenze diversissime, che forse non le troveranno nel patto Fondazione per lo sviluppo sostenibile Cronaca e storia del negoziato climatico pag. 5 tutte quante soddisfatte, ma che condividono la visione strategica di questo storico accordo, così lo definisce. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon dice tra l'altro di non aver mai vissuto un negoziato internazionale così difficile e che questo dà la misura del valore dell'accordo raggiunto. Grandi ringraziamenti e riconoscimenti al Governo Francese. Conclude la seduta del Comitè il Primo Ministro francese Hollande. Dice di non aver voluto mancare alla consacrazione di questo storico Patto, ambizioso e realistico. Merito delle 186 delegazioni nazionali presenti a Parigi, di Fabius e della Figueres. Il Patto contiene solidi e vincolanti meccanismi di revisione, rilancia pienamente e su larga scale le energie rinnovabili e introduce sui mercati il Carbon Pricing. è un accordo decisivo per il pianeta. Vi scongiuro, conclude in nome della Francia e della città martire di Parigi, di adottare e fare vostro questo Patto. GLI IMPEGNI ASSUNTI A PARIGI
11 settembre 2015: Udienza di Papa Francesco in sostegno della lotta mondiale contro i cambiamenti climatici "Siamo qui per rivolgerle umilmente una preghiera: faccia un messaggio, un suo messaggio, alla Conferenza di Parigi. Noi l'aspettiamo e pensiamo che possa fare da contributo importante affinché abbia un esito positivo e veramente importante per tutti". Con queste parole il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi, ha concluso l'11 settembre nella Sala Clementina del Vaticano la sua presentazione dei risultati della due giorni del Convegno sulla giustizia ambientale e i cambiamenti climatici (> ascolta una registrazione di sala della presentazione di Edo Ronchi". La presentazione ha dato spunto alle parole del Santo Padre, che a sua volta ha concluso accogliendo la richiesta di Ronchi "... potete contare sul sostegno mio personale e di tutta la Chiesa, a partire da quello, indispensabile, della preghiera. Fin da ora offro al Signore il nostro comune sforzo, chiedendogli di benedirlo perché l’umanità sappia finalmente dare ascolto al grido della terra - oggi la nostra madre terra è tra i tanti esclusi che gridano al Cielo per un aiuto! La nostra madre terra è un'esclusa! -, anche al grido della terra, nostra madre e sorella e dei più poveri tra coloro che la abitano, e prendersene cura. In questo modo la creazione si avvicinerà sempre di più alla casa comune che l’unico Padre ha immaginato come dono per la famiglia universale delle sue creature". (> leggi il testo dell'allocuzione di Papa Francesco oppure ascolta l'allocuzione). Il Convegno si è tenuto nella sede vaticana a Roma dell'Istituto Patristico Agostiniano dal 10 all'11 settembre. La relazione di apertura della fondazione per lo sviluppo sostenibile è stata tenuta dal Presidente Edo Ronchi (> scarica il testo del documento) che dice: "Dal 1990 al 2014 le emissioni sono cresciute di oltre il 30% e la concentrazione di gas serra ha superato le 400 ppm, la più alta negli ultimi 800 mila anni. La temperatura media è aumentata di 0,85°C dal 1880. Il tasso di crescita annua è passato dalla media dell’1,3% del 1970-2000, al 2,2% del 2000-2010". Le proposte principali sono:
2014: LA COP 20 DI LIMA E LE ATTIVITà PREPARATORIE. Volume II - COP 20
2013: DA BALI A VARSAVIA.
Volume I
COP 13 - COP 19 CONOSCERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Le basi fisiche del cambiamento climatico (ppt, 2018) |
|
|
Comitato Scientifico della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile Via Garigliano 61a, 00198 Roma
www.fondazionesvilupposostenibile.org |
Coordinatore: Toni Federico (email:federico@susdef.it) Storia e tendenze dello sviluppo sostenibile La Green economy Clima Energia Trasporti Territorio |

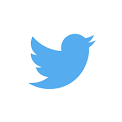
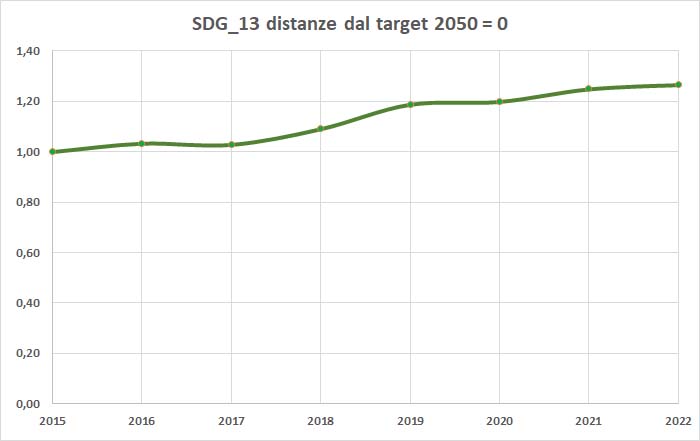

 La
rappresentazione mediatica internazionale dello stato della lotta ai
cambiamenti climatici è stata vastissima. Molti medici sono stati intorno al
letto del malato
La
rappresentazione mediatica internazionale dello stato della lotta ai
cambiamenti climatici è stata vastissima. Molti medici sono stati intorno al
letto del malato
 La questione dei biocombustibili
La questione dei biocombustibili
 Come
si concluderà COP 30? La presidenza ha la possibilità di
redigere un nuovo testo di copertura negoziato: una panoramica
politica generale delle decisioni concordate al vertice, insieme ad altre
questioni non presenti nell’agenda ma che si vogliono mettere in evidenza.
Prima dell’inizio della COP, il presidente do Lago, aveva escluso fermamente
la possibilità di un documento di decisione onnicomprensiva come la solita
soluzione dell’ultimo minuto, la solita raccolta di buone intenzioni, ma ha
poi evitato l’argomento. Altre parti sono state molto meno timide nel
lasciare intendere che un testo di copertura, effettivamente, arriverà. Le
decisioni di copertura sono spesso il risultato di negoziati tesi, alti
rischi, troppo poco tempo e troppe parti da soddisfare. Quest’anno, c’è
un’ulteriore necessità di affrontare ciò che accade nel mondo al di fuori
dei negoziati e per mandare un segnale politico che il processo climatico
ONU è vivo e sta facendo progressi, nonostante il ritiro degli Stati Uniti.
Che elementi potrebbe includere? Misure commerciali ma anche le idee
promosse dal presidente brasiliano Lula per una nuova roadmap di
uscita dai dalla deforestazione, per cui ha lanciato un fondo volontario
dedicato per l’Amazzonia e per dare finalmente concretezza
all’allontanamento dai combustibili fossili di Dubai. Peraltro è flebile la
speranza di concludere qualcosa sulla finanza, sul percorso Baku - Belém e
sul global stocktake degli NDC nuovi e vecchi.
Come
si concluderà COP 30? La presidenza ha la possibilità di
redigere un nuovo testo di copertura negoziato: una panoramica
politica generale delle decisioni concordate al vertice, insieme ad altre
questioni non presenti nell’agenda ma che si vogliono mettere in evidenza.
Prima dell’inizio della COP, il presidente do Lago, aveva escluso fermamente
la possibilità di un documento di decisione onnicomprensiva come la solita
soluzione dell’ultimo minuto, la solita raccolta di buone intenzioni, ma ha
poi evitato l’argomento. Altre parti sono state molto meno timide nel
lasciare intendere che un testo di copertura, effettivamente, arriverà. Le
decisioni di copertura sono spesso il risultato di negoziati tesi, alti
rischi, troppo poco tempo e troppe parti da soddisfare. Quest’anno, c’è
un’ulteriore necessità di affrontare ciò che accade nel mondo al di fuori
dei negoziati e per mandare un segnale politico che il processo climatico
ONU è vivo e sta facendo progressi, nonostante il ritiro degli Stati Uniti.
Che elementi potrebbe includere? Misure commerciali ma anche le idee
promosse dal presidente brasiliano Lula per una nuova roadmap di
uscita dai dalla deforestazione, per cui ha lanciato un fondo volontario
dedicato per l’Amazzonia e per dare finalmente concretezza
all’allontanamento dai combustibili fossili di Dubai. Peraltro è flebile la
speranza di concludere qualcosa sulla finanza, sul percorso Baku - Belém e
sul global stocktake degli NDC nuovi e vecchi. è
è Rivolgendosi
alla conferenza in apertura, il presidente Lula ha dichiarato che la COP 30
sarà la COP della verità in un’epoca di fake news e distorsioni e di rifiuto
delle prove scientifiche. Senza nominare direttamente il presidente Trump,
Lula ha aggiunto: “Controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono
paura.
Rivolgendosi
alla conferenza in apertura, il presidente Lula ha dichiarato che la COP 30
sarà la COP della verità in un’epoca di fake news e distorsioni e di rifiuto
delle prove scientifiche. Senza nominare direttamente il presidente Trump,
Lula ha aggiunto: “Controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono
paura. Ai
margini della foresta pluviale, circa 60 leader mondiali e vari funzionari
delle Nazioni Unite e dei governi hanno dato il via ai lavori della COP
sull’Amazzonia a Belém il giorno 6. La presenza di solo la metà dei capi di
Stato rispetto al vertice dell’anno scorso ha messo in luce le divisioni
globali. I leader dei tre maggiori inquinatori del pianeta, Cina, Stati
Uniti e India, erano completamente assenti dal vertice preliminare. Anche Xi
Jinping, presidente della Cina, non ha partecipato di persona, ma ha preso
parte virtualmente agli incontri preparatori, durante i quali ha promesso
ulteriori azioni per spostare la Cina verso un’economia verde. Da parte sua
l’India ha dato segnali incoraggianti: sebbene il primo ministro Narendra
Modi abbia saltato il vertice, abbia visitato Brasilia a luglio, e il duro
epilogo della COP dell’anno scorso quando i negoziatori indiani si
rifiutarono di accettare quella che consideravano un’inadeguata promessa di
300 miliardi di dollari in finanziamenti climatici da parte dei paesi ricchi
— potrebbe essere evitato questa volta. L’Arabia Saudita, la Russia e alcuni
loro alleati hanno storicamente ostacolato i lavori delle COP, e l’Argentina
potrebbe unirsi a loro. Sono attese tensioni e possibili tattiche di
sabotaggio. Il Brasile, da parte sua, è stato riluttante ad affrontare la
questione dell’insufficienza degli NDC. Il team della presidenza ha
insistito sul fatto che non fanno formalmente parte del mandato della COP
30, poiché spetta ai singoli paesi elaborarli. Solo dopo le proteste è stato
creato uno spazio nell’agenda per discuterne, e resta ancora incerto se
emergerà un risultato che preveda passi concreti per colmare l’enorme
divario delle emissioni tra le promesse attuali e ciò che è realmente
necessario. Il Brasile afferma di voler puntare sull’attuazione, più che
sulle parole pronunciate nelle stanze chiuse dei negoziati.
Ai
margini della foresta pluviale, circa 60 leader mondiali e vari funzionari
delle Nazioni Unite e dei governi hanno dato il via ai lavori della COP
sull’Amazzonia a Belém il giorno 6. La presenza di solo la metà dei capi di
Stato rispetto al vertice dell’anno scorso ha messo in luce le divisioni
globali. I leader dei tre maggiori inquinatori del pianeta, Cina, Stati
Uniti e India, erano completamente assenti dal vertice preliminare. Anche Xi
Jinping, presidente della Cina, non ha partecipato di persona, ma ha preso
parte virtualmente agli incontri preparatori, durante i quali ha promesso
ulteriori azioni per spostare la Cina verso un’economia verde. Da parte sua
l’India ha dato segnali incoraggianti: sebbene il primo ministro Narendra
Modi abbia saltato il vertice, abbia visitato Brasilia a luglio, e il duro
epilogo della COP dell’anno scorso quando i negoziatori indiani si
rifiutarono di accettare quella che consideravano un’inadeguata promessa di
300 miliardi di dollari in finanziamenti climatici da parte dei paesi ricchi
— potrebbe essere evitato questa volta. L’Arabia Saudita, la Russia e alcuni
loro alleati hanno storicamente ostacolato i lavori delle COP, e l’Argentina
potrebbe unirsi a loro. Sono attese tensioni e possibili tattiche di
sabotaggio. Il Brasile, da parte sua, è stato riluttante ad affrontare la
questione dell’insufficienza degli NDC. Il team della presidenza ha
insistito sul fatto che non fanno formalmente parte del mandato della COP
30, poiché spetta ai singoli paesi elaborarli. Solo dopo le proteste è stato
creato uno spazio nell’agenda per discuterne, e resta ancora incerto se
emergerà un risultato che preveda passi concreti per colmare l’enorme
divario delle emissioni tra le promesse attuali e ciò che è realmente
necessario. Il Brasile afferma di voler puntare sull’attuazione, più che
sulle parole pronunciate nelle stanze chiuse dei negoziati. 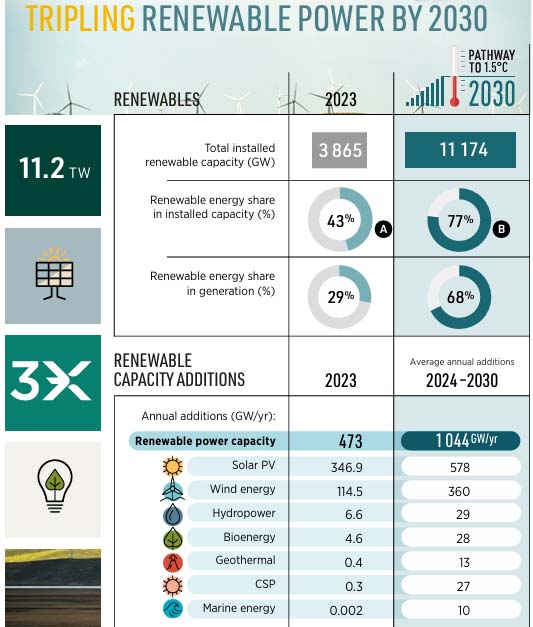 Risale alla
COP 28 di Dubai 2023 lo “storico”
Risale alla
COP 28 di Dubai 2023 lo “storico”
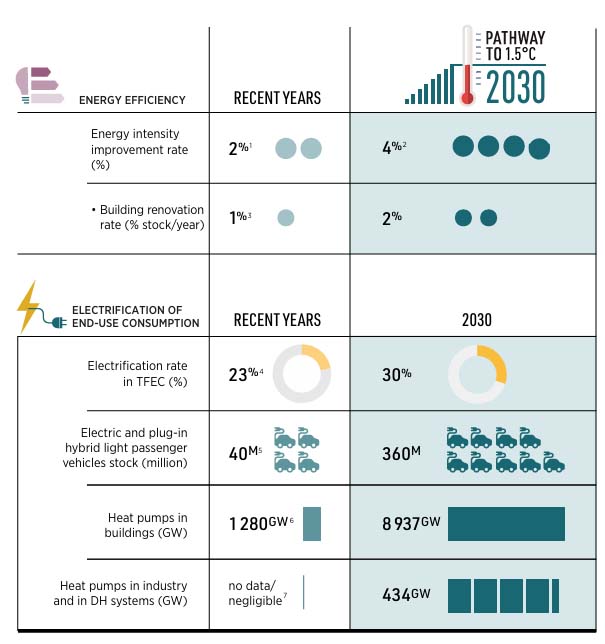 Raddoppiare
l'efficienza energetica
Raddoppiare
l'efficienza energetica  Le
perdite e i danni possono essere classificati come economici o non
economici.
Le
perdite e i danni possono essere classificati come economici o non
economici. Una bozza
delle conclusioni del vertice UE,
Una bozza
delle conclusioni del vertice UE,
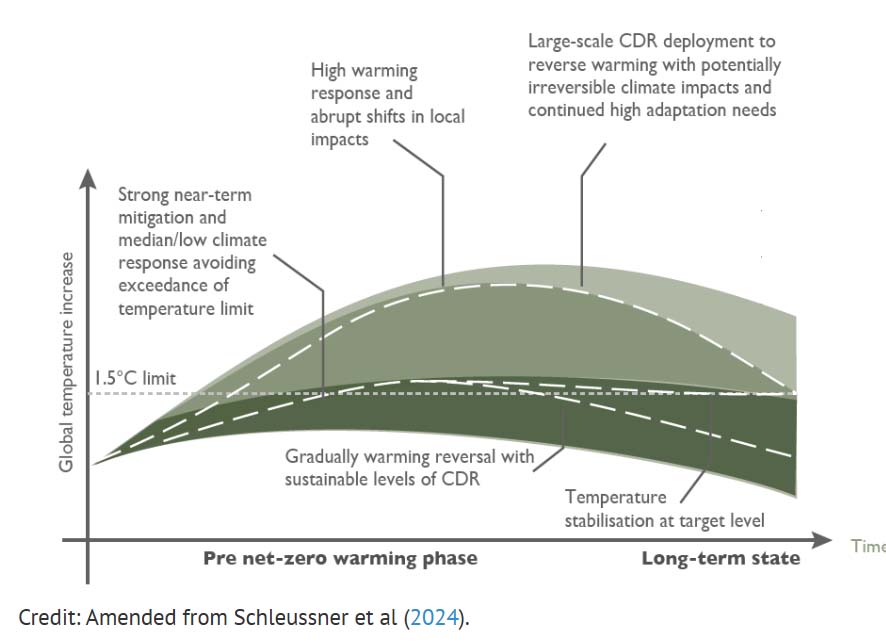 Aprendo
la conferenza,
Aprendo
la conferenza,
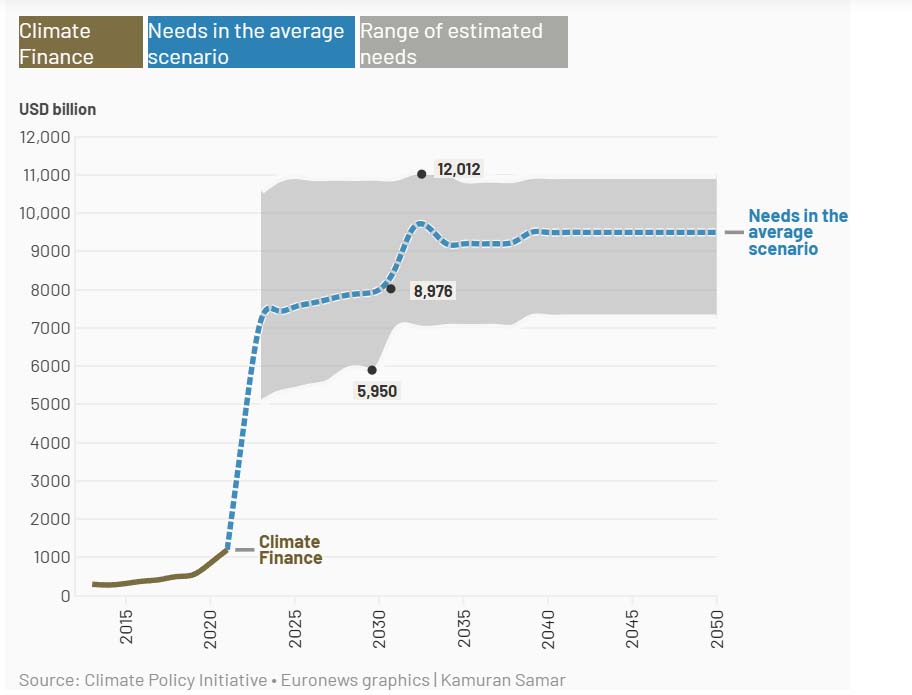
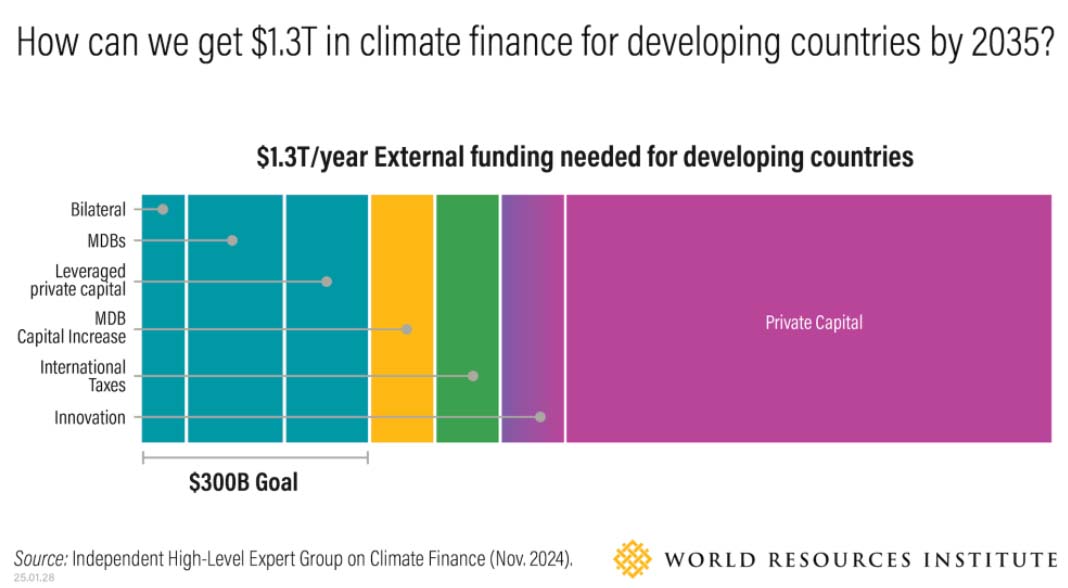
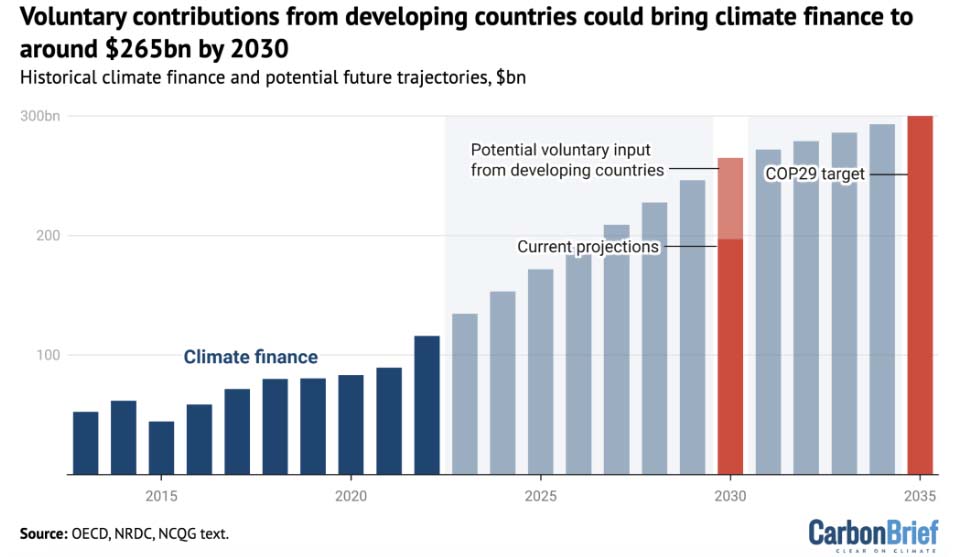 Entrando
nei meriti delle politiche di attuazione la IEA stima che a livello
mondiale, gli investimenti annuali in energia pulita debbano raggiungere i 4
trilioni di dollari — più del triplo dei livelli attuali — per conseguire
emissioni nette pari a zero entro la metà del secolo. Si tenga conto che,
allo stesso tempo, nel solo 2022 i governi hanno speso 7 trilioni di dollari
in sussidi ai combustibili fossili. Lo squilibrio è evidente. Sebbene i
flussi finanziari stiano crescendo nella direzione giusta, una parte
eccessiva continua a sostenere attività ad alta intensità di carbonio,
mentre troppo poco raggiunge le comunità più esposte agli impatti climatici.
Ad esempio, solo una piccola quota (2,5%) dei flussi globali di finanza
climatica arriva all’Africa subsahariana, nonostante le gravi vulnerabilità
della regione. Il
Entrando
nei meriti delle politiche di attuazione la IEA stima che a livello
mondiale, gli investimenti annuali in energia pulita debbano raggiungere i 4
trilioni di dollari — più del triplo dei livelli attuali — per conseguire
emissioni nette pari a zero entro la metà del secolo. Si tenga conto che,
allo stesso tempo, nel solo 2022 i governi hanno speso 7 trilioni di dollari
in sussidi ai combustibili fossili. Lo squilibrio è evidente. Sebbene i
flussi finanziari stiano crescendo nella direzione giusta, una parte
eccessiva continua a sostenere attività ad alta intensità di carbonio,
mentre troppo poco raggiunge le comunità più esposte agli impatti climatici.
Ad esempio, solo una piccola quota (2,5%) dei flussi globali di finanza
climatica arriva all’Africa subsahariana, nonostante le gravi vulnerabilità
della regione. Il 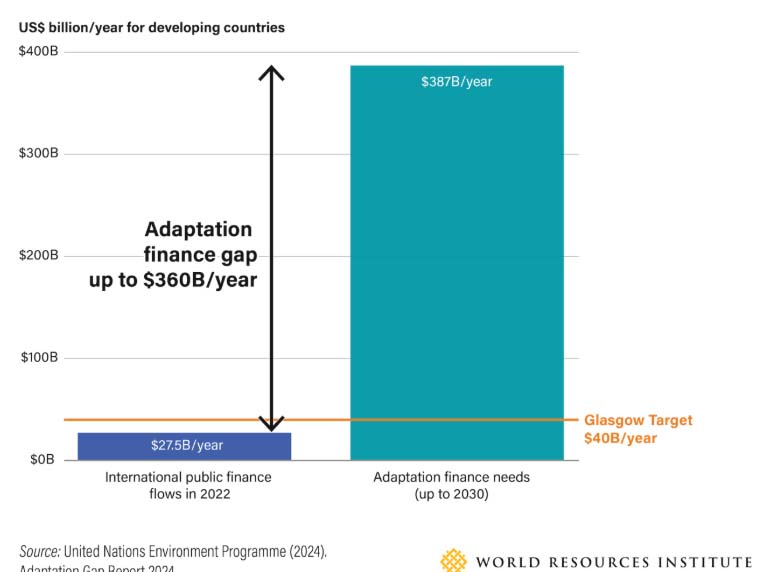
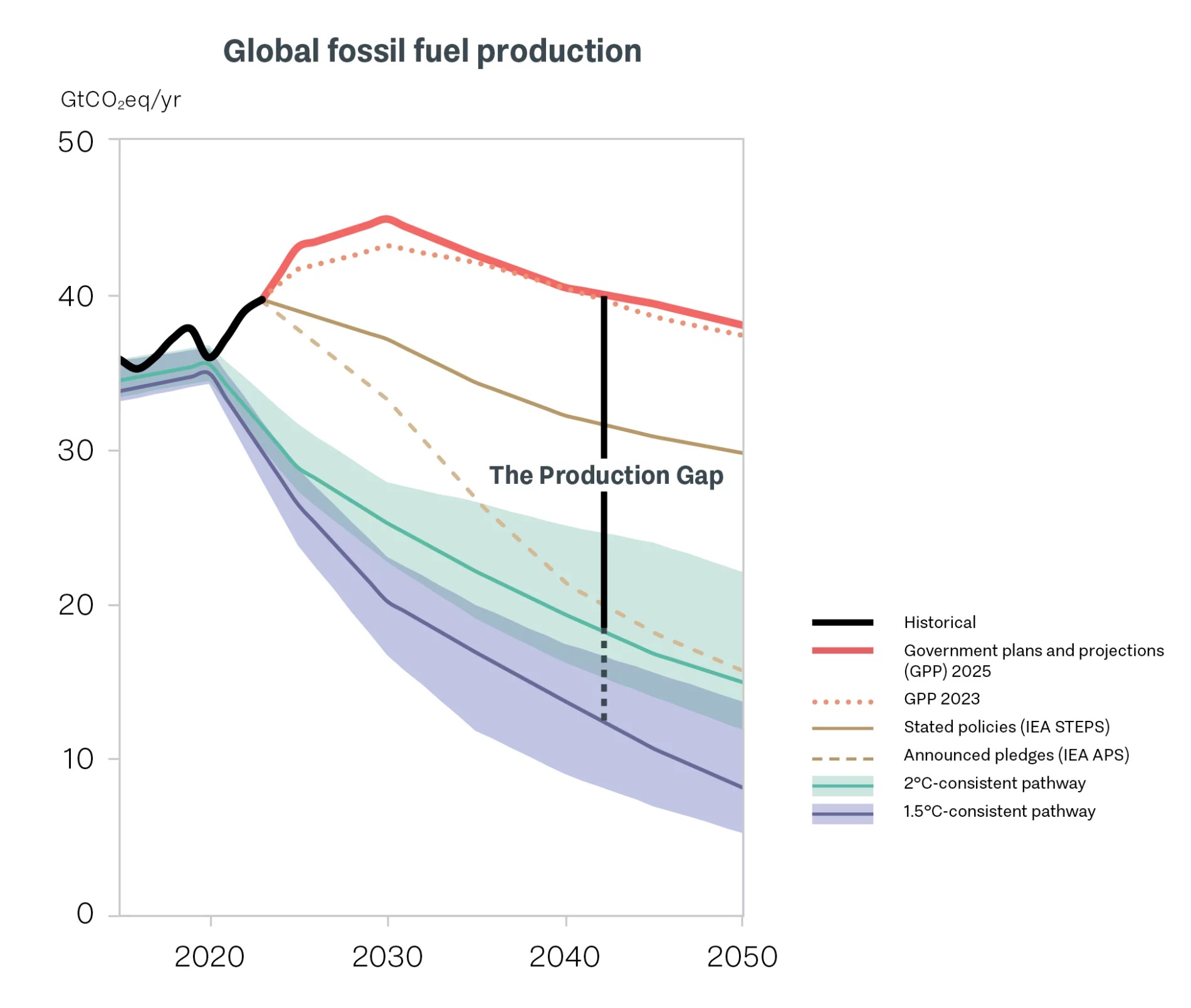 Se
la stabilizzazione delle emissioni totali di CO₂ dovesse continuare, il
Se
la stabilizzazione delle emissioni totali di CO₂ dovesse continuare, il
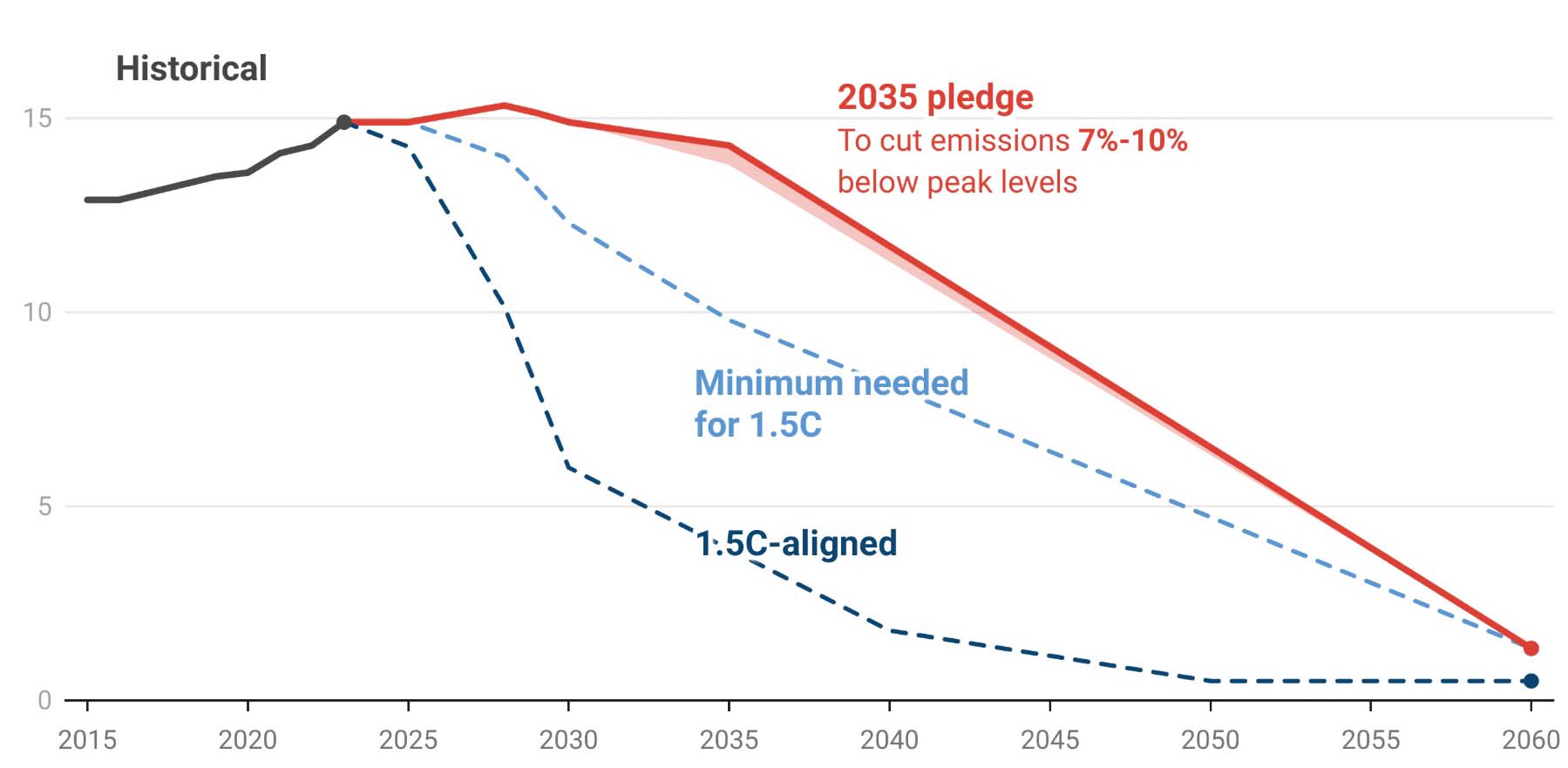 Considerando
gli NDC al netto degli annunci presentati alla chiusura del vertice, i paesi
che hanno pubblicato il loro NDC 2025 sono appena il 74% di quelli che hanno
sottoscritto l'Accordo di Parigi. Le misure collettivamente proposte finora ridurrebbero le emissioni solo di circa
2
gigatonnellate (Gt): appena il 6% di quanto necessario per
l’obiettivo di 1,5 °C e il 10% per quello dei 2 °C.
Considerando
gli NDC al netto degli annunci presentati alla chiusura del vertice, i paesi
che hanno pubblicato il loro NDC 2025 sono appena il 74% di quelli che hanno
sottoscritto l'Accordo di Parigi. Le misure collettivamente proposte finora ridurrebbero le emissioni solo di circa
2
gigatonnellate (Gt): appena il 6% di quanto necessario per
l’obiettivo di 1,5 °C e il 10% per quello dei 2 °C. Nonostante i
benefici conclamati, il mondo si trova di fronte alla sfida della
deforestazione continua, che equivale a non meno del 21% delle emissioni
totali del settore agricolo, forestale e dell’uso del suolo. L’impatto della
deforestazione è grave: indebolisce gli sforzi di resilienza climatica e
minaccia la vita delle comunità che vivono nelle foreste. Le principali
cause della deforestazione tropicale sono la produzione di materie prime
come olio di palma, carne bovina, soia e legname. Per affrontare questa
sfida occorre il rafforzamento delle conoscenze, la creazione di condizioni
favorevoli e la mobilitazione di finanziamenti per la protezione e la
gestione sostenibile delle foreste. Gli sforzi recenti dei Paesi tropicali,
sostenuti da quadri normativi e meccanismi di finanziamento internazionali,
hanno già iniziato a produrre risultati credibili e vantaggiosi in termini
di mitigazione che vanno valorizzati alla COP 30, con l’obiettivo di
compiere progressi significativi entro il 2030.
Nonostante i
benefici conclamati, il mondo si trova di fronte alla sfida della
deforestazione continua, che equivale a non meno del 21% delle emissioni
totali del settore agricolo, forestale e dell’uso del suolo. L’impatto della
deforestazione è grave: indebolisce gli sforzi di resilienza climatica e
minaccia la vita delle comunità che vivono nelle foreste. Le principali
cause della deforestazione tropicale sono la produzione di materie prime
come olio di palma, carne bovina, soia e legname. Per affrontare questa
sfida occorre il rafforzamento delle conoscenze, la creazione di condizioni
favorevoli e la mobilitazione di finanziamenti per la protezione e la
gestione sostenibile delle foreste. Gli sforzi recenti dei Paesi tropicali,
sostenuti da quadri normativi e meccanismi di finanziamento internazionali,
hanno già iniziato a produrre risultati credibili e vantaggiosi in termini
di mitigazione che vanno valorizzati alla COP 30, con l’obiettivo di
compiere progressi significativi entro il 2030.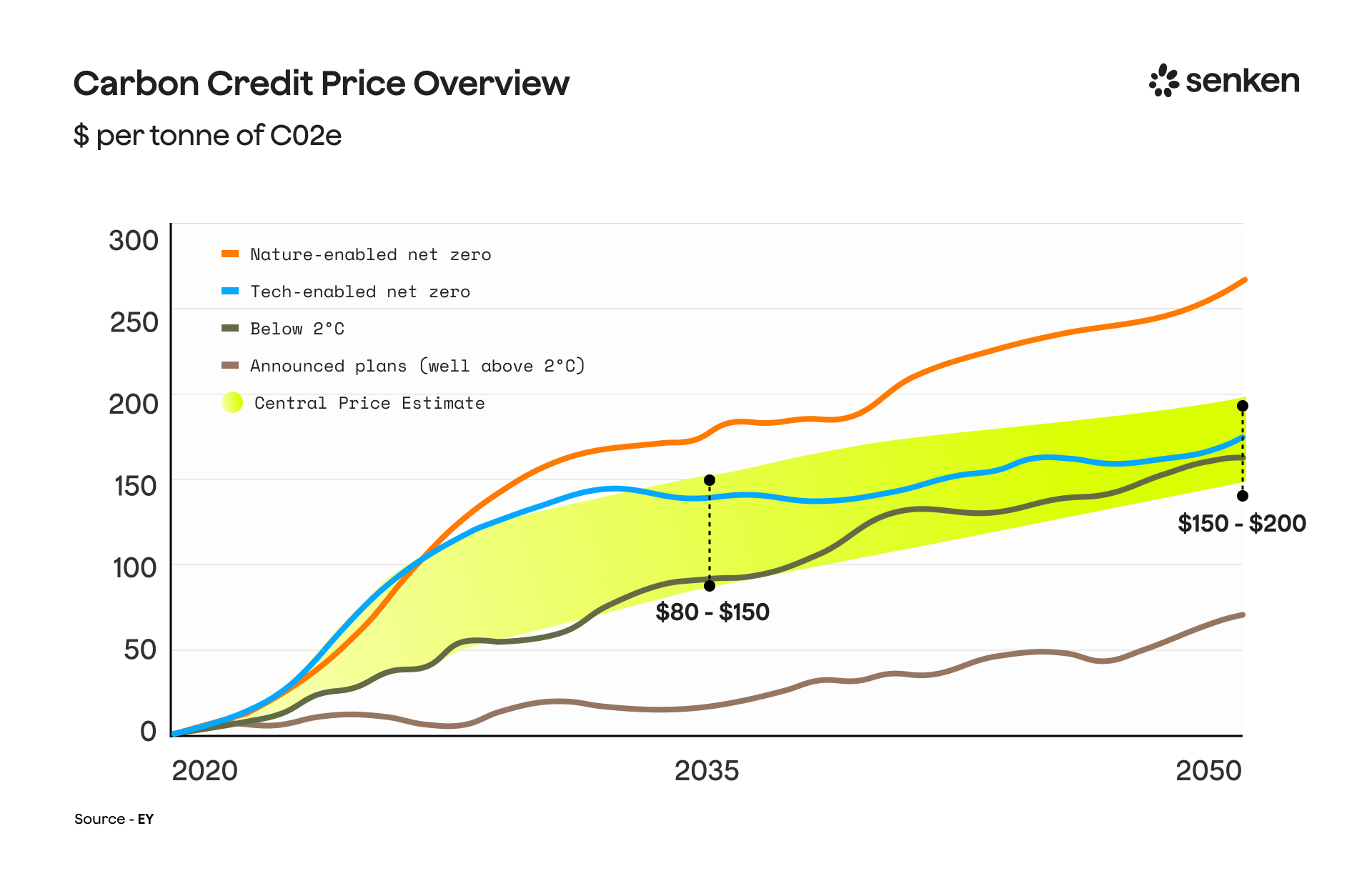 In
vista dei colloqui di Baku, Greenpeace (Nuova Zelanda) ha chiesto ai leader
mondiali di chiamare le imprese agroalimentari a rispondere delle loro
emissioni inquinanti per il clima. Altrove, quasi 500 sostenitori della
cattura del carbonio si sono registrati per partecipare alla COP 29, secondo
un’analisi del CIEL. Tra questi figurano lobbisti di aziende e gruppi che
promuovono la cattura e lo stoccaggio del carbonio. CIEL ha rilevato che
quasi la metà dei partecipanti era accreditata come parte di delegazioni
nazionali e che la presidenza della COP 29 ne ha invitati 55 come ospiti.
In
vista dei colloqui di Baku, Greenpeace (Nuova Zelanda) ha chiesto ai leader
mondiali di chiamare le imprese agroalimentari a rispondere delle loro
emissioni inquinanti per il clima. Altrove, quasi 500 sostenitori della
cattura del carbonio si sono registrati per partecipare alla COP 29, secondo
un’analisi del CIEL. Tra questi figurano lobbisti di aziende e gruppi che
promuovono la cattura e lo stoccaggio del carbonio. CIEL ha rilevato che
quasi la metà dei partecipanti era accreditata come parte di delegazioni
nazionali e che la presidenza della COP 29 ne ha invitati 55 come ospiti. L’adattamento
(UNDP) si riferisce a un'ampia gamma di misure volte a ridurre la
vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici, dalla piantumazione di
varietà di colture più resistenti alla siccità al miglioramento delle
informazioni sul clima e dei sistemi di allerta precoce, fino alla creazione
di difese più forti contro le inondazioni, il sollevamento degli oceani, gli
eventi climatici estremi, le ondate di calore, l’introduzione delle specie
aliene negli ecosistemi e molto altro. L’adattamento non può evidentemente
mettere l’umanità al sicuro dagli impatti climatici senza un livello
adeguato di mitigazione. Inoltre è di per sé un problema globale che si
articola in infinite varianti locali e richiede infinite iniziative diverse.
I paesi ricchi, storicamente emettitori della CO
L’adattamento
(UNDP) si riferisce a un'ampia gamma di misure volte a ridurre la
vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici, dalla piantumazione di
varietà di colture più resistenti alla siccità al miglioramento delle
informazioni sul clima e dei sistemi di allerta precoce, fino alla creazione
di difese più forti contro le inondazioni, il sollevamento degli oceani, gli
eventi climatici estremi, le ondate di calore, l’introduzione delle specie
aliene negli ecosistemi e molto altro. L’adattamento non può evidentemente
mettere l’umanità al sicuro dagli impatti climatici senza un livello
adeguato di mitigazione. Inoltre è di per sé un problema globale che si
articola in infinite varianti locali e richiede infinite iniziative diverse.
I paesi ricchi, storicamente emettitori della CO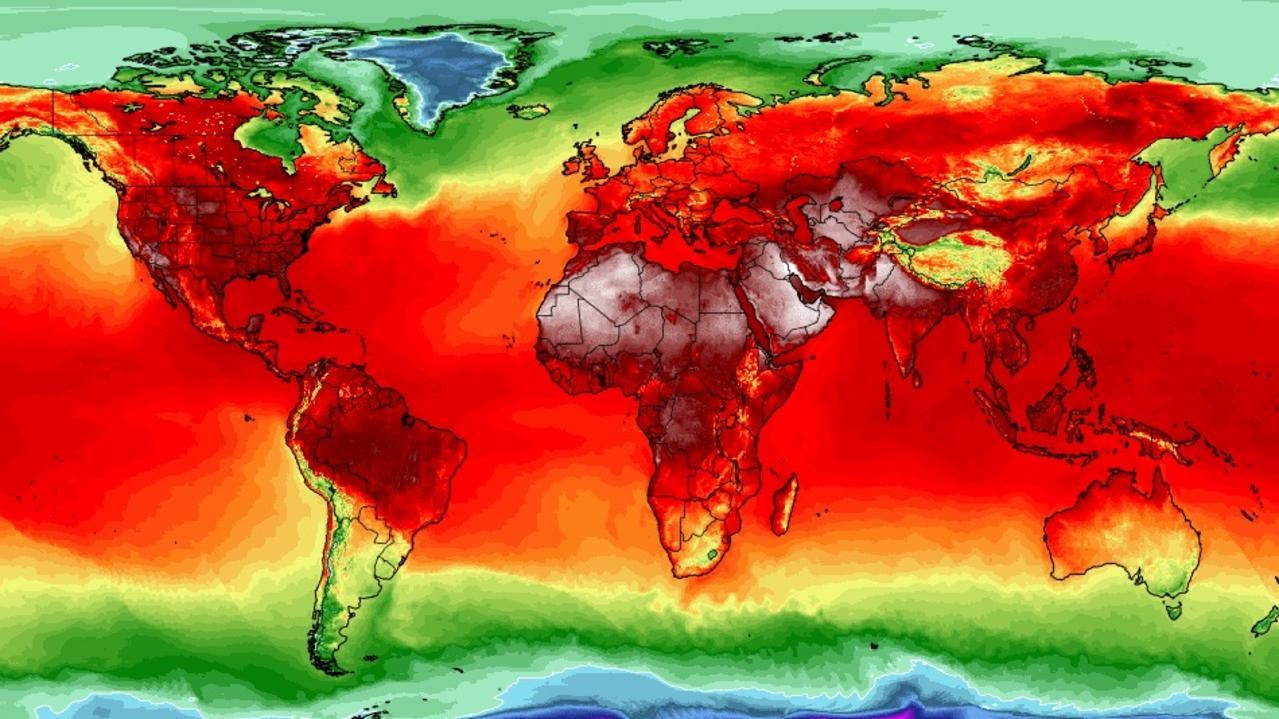 Il
19 giugno è stata pubblicata una prima bozza di testo, che includeva diverse
opzioni su punti chiave, tra cui la struttura degli indicatori, i
finanziamenti (MoI) e i relativi accesso e qualità. È stato raggiunto un
accordo sull’adozione di una lista globale di indicatori ma è rimasto
incerto se e quando si terrebbero ulteriori workshop sugli indicatori prima
della COP 30. Con il progredire dei colloqui, le discussioni si sono poi
spostate su altri elementi chiave del GGA: la Baku Adaptation Roadmap (BAR)
e l’inclusione dell’adattamento “trasformativo”, secondo cui per adattarsi
al riscaldamento globale è necessario un cambiamento fondamentale dei
sistemi socio-ecologici esistenti. Sono emerse opinioni divergenti su cosa
dovrebbe fare la BAR, quale sia il suo mandato e persino quali siano le
prove della necessità di crearla, oltre al suo rapporto con il global
stocktake. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’adattamento
trasformativo, sembrava che non si potesse trovare molto accordo anche
perché la comprensione del concetto e di ciò che comporterebbe non è ancora
sufficientemente matura da consentire una discussione fondata. Ovviamente,
nessun governo vuole che emergano cose di questo genere. L’idea è stata per
ora accantonata. I limiti di tempo a Bonn, e i troppi aspetti da discutere
nell’ambito del GGA. (il BAR, l’adattamento trasformativo e gli altri
aspetti), causeranno il riesplodere delle divergenze a Belém.
Il
19 giugno è stata pubblicata una prima bozza di testo, che includeva diverse
opzioni su punti chiave, tra cui la struttura degli indicatori, i
finanziamenti (MoI) e i relativi accesso e qualità. È stato raggiunto un
accordo sull’adozione di una lista globale di indicatori ma è rimasto
incerto se e quando si terrebbero ulteriori workshop sugli indicatori prima
della COP 30. Con il progredire dei colloqui, le discussioni si sono poi
spostate su altri elementi chiave del GGA: la Baku Adaptation Roadmap (BAR)
e l’inclusione dell’adattamento “trasformativo”, secondo cui per adattarsi
al riscaldamento globale è necessario un cambiamento fondamentale dei
sistemi socio-ecologici esistenti. Sono emerse opinioni divergenti su cosa
dovrebbe fare la BAR, quale sia il suo mandato e persino quali siano le
prove della necessità di crearla, oltre al suo rapporto con il global
stocktake. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’adattamento
trasformativo, sembrava che non si potesse trovare molto accordo anche
perché la comprensione del concetto e di ciò che comporterebbe non è ancora
sufficientemente matura da consentire una discussione fondata. Ovviamente,
nessun governo vuole che emergano cose di questo genere. L’idea è stata per
ora accantonata. I limiti di tempo a Bonn, e i troppi aspetti da discutere
nell’ambito del GGA. (il BAR, l’adattamento trasformativo e gli altri
aspetti), causeranno il riesplodere delle divergenze a Belém.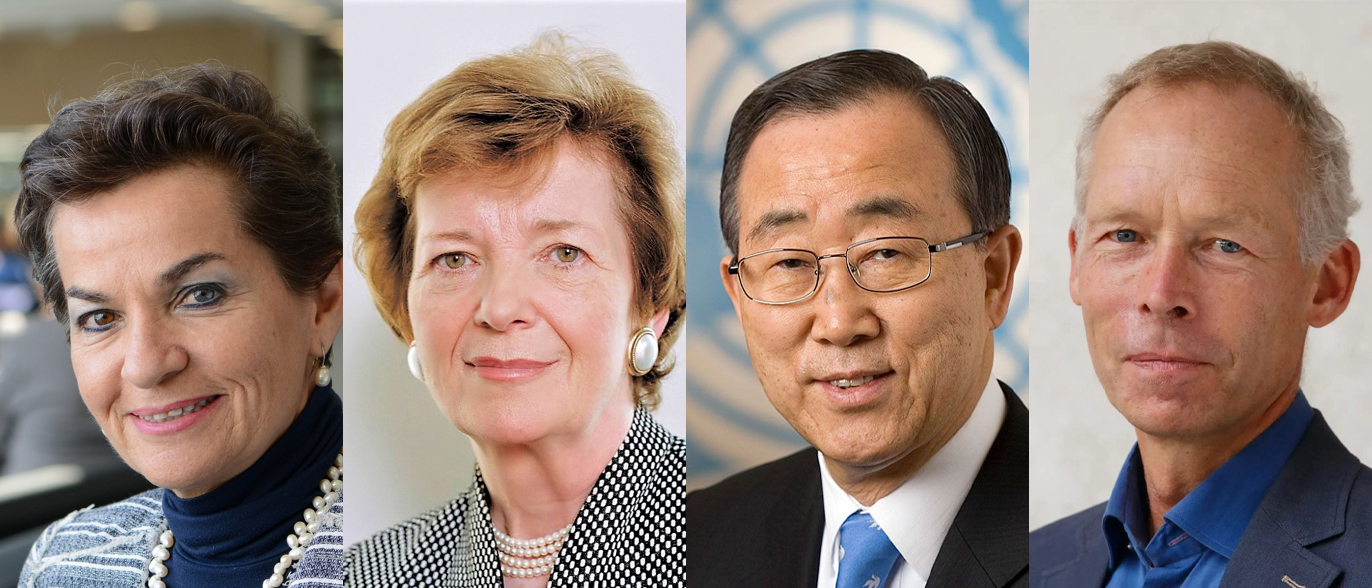
 Peter
Betts, scomparso nell’ottobre 2023, è stato capo negoziatore del Regno Unito
e dell’UE in diverse COP, tra cui la COP 21 di Parigi del 2015, ci ha
lasciato
Peter
Betts, scomparso nell’ottobre 2023, è stato capo negoziatore del Regno Unito
e dell’UE in diverse COP, tra cui la COP 21 di Parigi del 2015, ci ha
lasciato
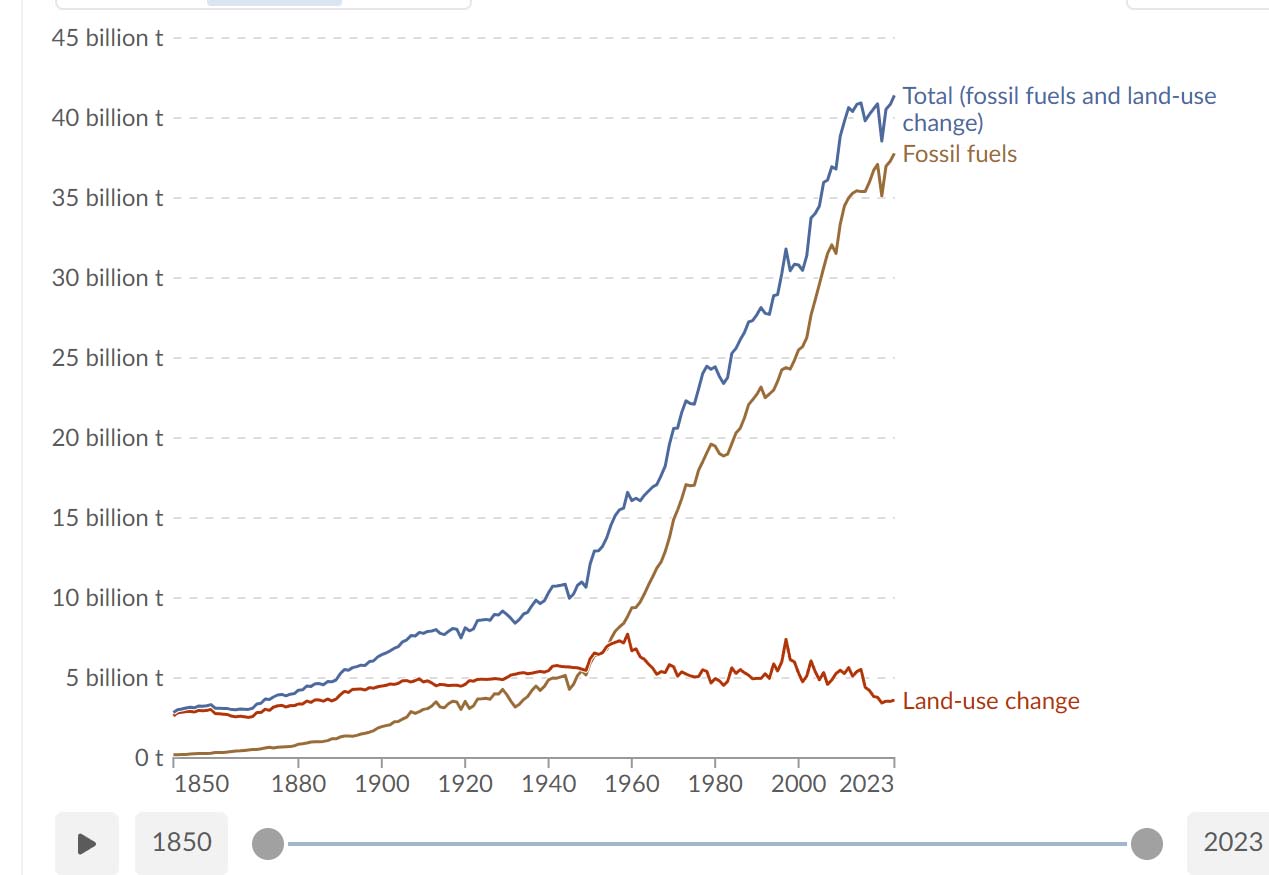
 Troppo
tempo è stato speso nella storia delle COP, prima e dopo Parigi, per
definire puntigliosamente dei testi negoziali che hanno nel seguito avuto
una implementazione incerta. Per questa ragione si parla ormai apertamente a
livello internazionale di riforma e di cambiamento, come vedremo più avanti.
Le istanze sono molteplici e complesse.
Troppo
tempo è stato speso nella storia delle COP, prima e dopo Parigi, per
definire puntigliosamente dei testi negoziali che hanno nel seguito avuto
una implementazione incerta. Per questa ragione si parla ormai apertamente a
livello internazionale di riforma e di cambiamento, come vedremo più avanti.
Le istanze sono molteplici e complesse.





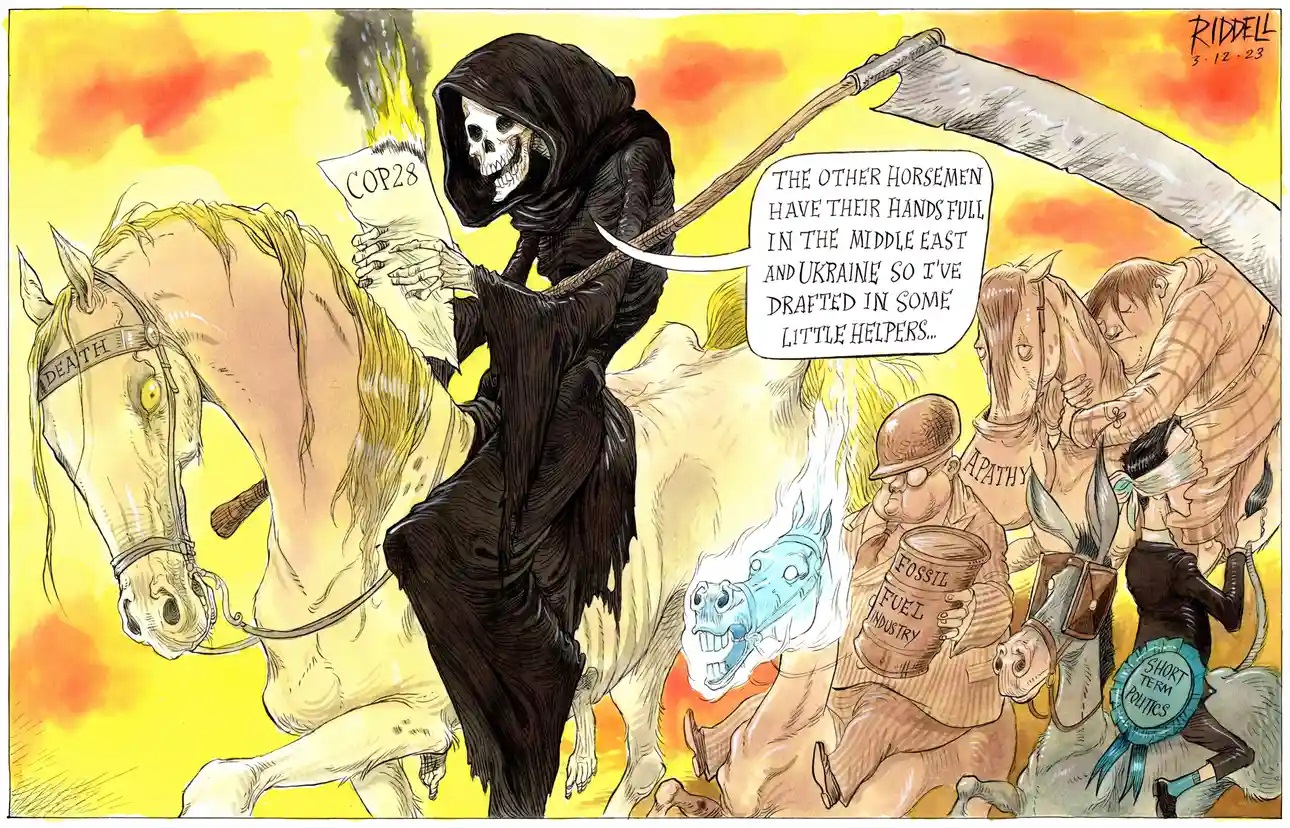
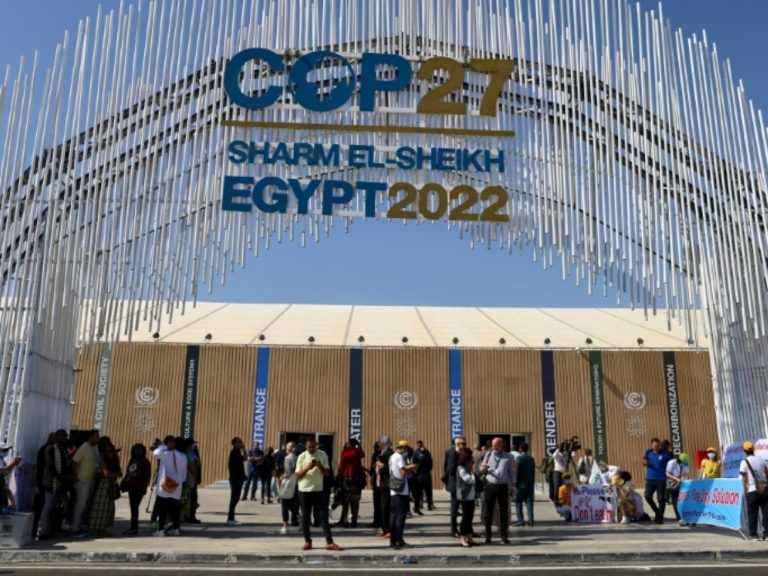
 A conti fatti, i risultati della COP 27
saranno probabilmente sufficienti per mantenere la implementazione sulla
buona strada per un altro anno, e certamente hanno consegnato una
vittoria importante per coloro che già subiscono i devastanti impatti del
cambiamento climatico. Ma molto di più deve essere fatto. Come ha detto il
Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, “La COP 27
conclude con molto da fare e poco tempo a disposizione”. Durante la plenaria
di chiusura di domenica 20 novembre, molti gruppi e paesi hanno dichiarato
di aspettarsi molto dalla COP 28 degli Emirati Arabi Uniti, sia per
l'attuazione che per l'ambizione attraverso il primo Global stocktaking.
Le COP dovranno reinventarsi come luoghi in cui i paesi si riuniscono per
dimostrare progressi, sostenere la trasparenza e la responsabilità, e
aumentare l'ambizione ai livelli richiesti per evitare una crisi climatica.
Molti si chiedono se le COP sono adatte allo scopo, pochi dicono cosa
dovrebbe cambiare.
A conti fatti, i risultati della COP 27
saranno probabilmente sufficienti per mantenere la implementazione sulla
buona strada per un altro anno, e certamente hanno consegnato una
vittoria importante per coloro che già subiscono i devastanti impatti del
cambiamento climatico. Ma molto di più deve essere fatto. Come ha detto il
Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, “La COP 27
conclude con molto da fare e poco tempo a disposizione”. Durante la plenaria
di chiusura di domenica 20 novembre, molti gruppi e paesi hanno dichiarato
di aspettarsi molto dalla COP 28 degli Emirati Arabi Uniti, sia per
l'attuazione che per l'ambizione attraverso il primo Global stocktaking.
Le COP dovranno reinventarsi come luoghi in cui i paesi si riuniscono per
dimostrare progressi, sostenere la trasparenza e la responsabilità, e
aumentare l'ambizione ai livelli richiesti per evitare una crisi climatica.
Molti si chiedono se le COP sono adatte allo scopo, pochi dicono cosa
dovrebbe cambiare.
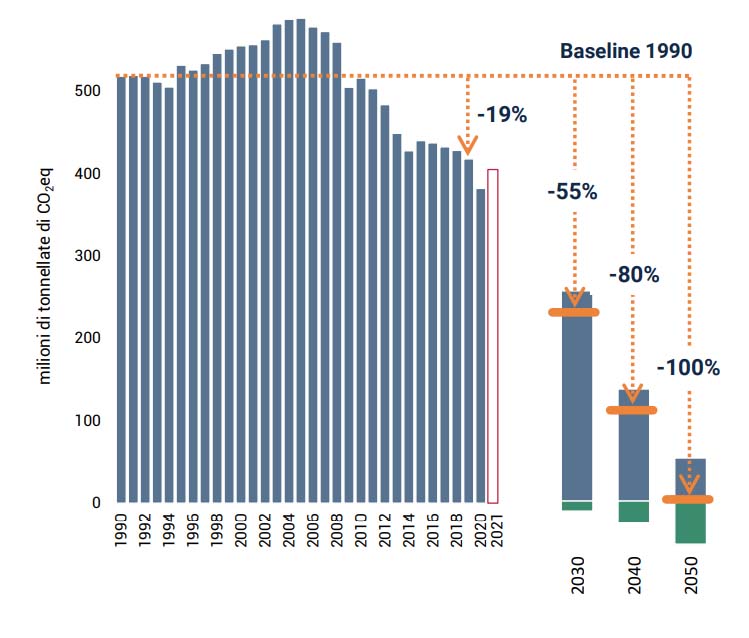 In
Italia dal 1990 al 2019 le emissioni di gas serra si sono ridotte del 19%,
passando da 519 a 418 MtCO2eq attraversando tre fasi distinte.
Fino al 2005 le emissioni sono cresciute stabilmente (+5 MtCO2eq/anno)
per poi ridursi in modo significativo nel decennio 2005 -2014, -160 MtCO2eq
in soli nove anni, 17 per anno. Dal 2014 al 2019 le emissioni si sono
ridotte di soli 2 MtCO2eq/anno: il processo di decarbonizzazione
si è arrestato. Nel 2020, primo anno della pandemia, le emissioni sono
crollate di 40 MtCO2eq, ma le stime preliminari per il 2021
segnalano un deciso rimbalzo, connesso alla ripresa economica seppure ancora
incerta: le emissioni potrebbero recuperare in un solo anno i tre quarti
della caduta del 2020 e attestarsi intorno a 410 MtCO2eq. Per
raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55% rispetto al 1990, le emissioni
GHG devono scendere a 232 MtCO2eq nette entro il 2030,
considerando 11 MtCO2eq di assorbimenti. Si tratta di un taglio
di 186 MtCO2eq da conseguire in poco più di un decennio, a fronte
del taglio di 100 MtCO2eq conseguito negli ultimi trent’anni.
L’obiettivo è estremamente ambizioso e richiede interventi eccezionali in
tutti i settori, che dovranno realizzare una riduzione delle emissioni di
gas serra che va da circa il 30% dei trasporti e dell’agricoltura, al
dimezzamento e oltre dell’industria e del civile (fonte:
In
Italia dal 1990 al 2019 le emissioni di gas serra si sono ridotte del 19%,
passando da 519 a 418 MtCO2eq attraversando tre fasi distinte.
Fino al 2005 le emissioni sono cresciute stabilmente (+5 MtCO2eq/anno)
per poi ridursi in modo significativo nel decennio 2005 -2014, -160 MtCO2eq
in soli nove anni, 17 per anno. Dal 2014 al 2019 le emissioni si sono
ridotte di soli 2 MtCO2eq/anno: il processo di decarbonizzazione
si è arrestato. Nel 2020, primo anno della pandemia, le emissioni sono
crollate di 40 MtCO2eq, ma le stime preliminari per il 2021
segnalano un deciso rimbalzo, connesso alla ripresa economica seppure ancora
incerta: le emissioni potrebbero recuperare in un solo anno i tre quarti
della caduta del 2020 e attestarsi intorno a 410 MtCO2eq. Per
raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55% rispetto al 1990, le emissioni
GHG devono scendere a 232 MtCO2eq nette entro il 2030,
considerando 11 MtCO2eq di assorbimenti. Si tratta di un taglio
di 186 MtCO2eq da conseguire in poco più di un decennio, a fronte
del taglio di 100 MtCO2eq conseguito negli ultimi trent’anni.
L’obiettivo è estremamente ambizioso e richiede interventi eccezionali in
tutti i settori, che dovranno realizzare una riduzione delle emissioni di
gas serra che va da circa il 30% dei trasporti e dell’agricoltura, al
dimezzamento e oltre dell’industria e del civile (fonte:

 A
sei anni dalla COP 21 di Parigi, il Parlamento europeo ha approvato una
legge che rende giuridicamente vincolanti gli obiettivi dell'Unione europea
in materia di emissioni di gas serra, aprendo la strada a una revisione
della politica per ridurre più rapidamente l'inquinamento che provoca il
riscaldamento del pianeta. I negoziatori del Parlamento e dei 27 paesi
membri dell'UE hanno raggiunto un accordo ad aprile sulla legge sul clima,
che pone obiettivi di riduzione delle emissioni più rigorosi al centro del
processo decisionale dell'UE. Il disegno di legge fissa obiettivi per
ridurre le emissioni nette dell'UE del 55% entro il 2030, dai livelli del
1990, ed eliminare le emissioni nette entro il 2050. Il Parlamento ha
formalmente approvato la legge con 442 voti favorevoli, 203 contrari e 51
astenuti. Alcuni parlamentari verdi si sono astenuti, dopo aver cercato un
più ambizioso taglio del 60% delle emissioni entro il 2030. I gruppi di
destra hanno votato contro.
A
sei anni dalla COP 21 di Parigi, il Parlamento europeo ha approvato una
legge che rende giuridicamente vincolanti gli obiettivi dell'Unione europea
in materia di emissioni di gas serra, aprendo la strada a una revisione
della politica per ridurre più rapidamente l'inquinamento che provoca il
riscaldamento del pianeta. I negoziatori del Parlamento e dei 27 paesi
membri dell'UE hanno raggiunto un accordo ad aprile sulla legge sul clima,
che pone obiettivi di riduzione delle emissioni più rigorosi al centro del
processo decisionale dell'UE. Il disegno di legge fissa obiettivi per
ridurre le emissioni nette dell'UE del 55% entro il 2030, dai livelli del
1990, ed eliminare le emissioni nette entro il 2050. Il Parlamento ha
formalmente approvato la legge con 442 voti favorevoli, 203 contrari e 51
astenuti. Alcuni parlamentari verdi si sono astenuti, dopo aver cercato un
più ambizioso taglio del 60% delle emissioni entro il 2030. I gruppi di
destra hanno votato contro.