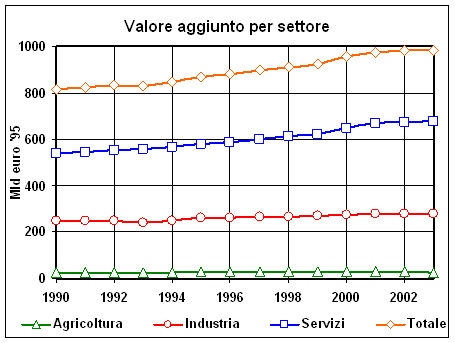
PER LA RIPRESA DELLO SVILUPPO IN ITALIA
Gdl "industria e sostenibilità": Toni Federico (Coordinatore)
Giulia Agrelli (Edilizia), Aurelio Angelini (Turismo), Andrea Barbabella (co-editor), Elisabetta Bottazzoli (Certificazioni ambientali, Servizi ambientali), Natale Massimo Caminiti (Energia), Maurizio Cellura (Ecologia industriale), Claudio Cesaretti (Economia), Cesare Donnhauser (Agricoltura), Carlo Donolo (Società, Distretti industriali), Aldo Jacomelli (Energia, Rinnovabili), Francesco La Camera (Ambiente e Sviluppo sostenibile), Stefania Minestrini (Certificazioni ambientali), Stefano Leoni (IPPC), Riccardo Rifici (GPP), Davide Vassallo (Responsabilità d’impresa)
Il sistema industriale è la chiave dello sviluppo sostenibile su scala mondiale e nazionale.
Profonde trasformazioni sono in atto nel mondo con al centro il fenomeno della globalizzazione e l’emersione dei grandi paesi in via di sviluppo. Gli equilibri globali ne risultano profondamente mutati: quindi è più che mai importante che i cambiamenti vengano guidati e governati in funzione dell’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile. Parole chiave come impronta ecologica, economia delle risorse, dematerializzazione, rinnovabilità, eco-efficienza, disaccoppiamento tra crescita (economica) e degrado (ambientale), riduzione delle emissioni inquinanti, riduzione dei rifiuti, ecologia industriale sono etichette di un complesso di innumerevoli teorie, programmi, progetti che hanno un obiettivo in comune, far bastare le risorse naturali, arrestare il degrado dell’ambiente e consentire lo sviluppo umano in tutte le sue componenti: libertà, benessere, occupazione, ambiente, conoscenza, diritti.
L’Europa si è data una dimensione economico-sociale precisa ed ambiziosa con il programma del Consiglio europeo di Lisbona del 2000, che prefigura una società basata sulla conoscenza, sulla piena e buona occupazione, sul pieno godimento dei diritti civili e dei diritti di accesso alla salute, alle risorse naturali ed alla qualità dell’ambiente, pur se la dimensione ambientale è stata innestata sul programma di Lisbona in tempi successivi, acquisendola entro la strategia europea per lo sviluppo sostenibile, costituita l’anno successivo al Consiglio di Goteborg. Nonostante il rallentamento del processo di integrazione comunitaria degli ultimi anni, la cornice di Lisbona e di Goteborg è ancora il sogno europeo. Il nostro paese ha bisogno di tornare a credere in se stesso e di fissare obiettivi “alti” per lasciarsi alle spalle i fantasmi della recessione e le frustrazioni prodotte dai fallimenti del governo delle destre.
L’Italia attraversa una crisi duplice che ha una componente di natura mondiale, connessa alla sopravveniente scarsità delle risorse energetiche fossili ed alle trasformazioni del mercato mondiale determinate dalla globalizzazione, dalla delocalizzazione dei processi industriali in luoghi dove il costo del lavoro ed i diritti sindacali sono minori, dalla crisi economica dell’est europeo ed alla crescita impetuosa delle economie cino-indiane. Sulla scala globale la situazione è più o meno comune a tutti i paesi membri dell’Unione, essendo le differenze essenzialmente legate alle specializzazioni produttive e commerciali delle diverse economie. Il sistema della moneta unica rende obbligatoria la ricerca di politiche e di soluzioni comuni entro l’Unione e unifica le dinamiche della competitizione, per ora, essenzialmente rispetto agli universi nord-americano e giapponese.
La seconda crisi è di natura interna. Altrettanto delicata, ma certamente più stringente e preoccupante, riguarda la progressiva perdita di qualità industriale e di competitività entro il sistema degli equilibri intra-comunitari. Questo tipo di crisi viene collegata alla perdita di margini di manovra delle politiche macroeconomiche per effetto del debito pubblico accumulato negli anni ‘80 e dal tramonto “del modello di sviluppo dei passati decenni, centrato sui sistemi di piccola impresa e sulla specializzazione nei settori tradizionali del made in Italy”, mascherato solo temporaneamente dalle politiche monetarie “di svalutazione e dal temporaneo rilancio delle esportazioni”[1].
Ai più è apparsa adeguata la definizione di declino dell’economia italiana, testimoniata dall’arretramento degli indici economici e dall’impoverimento del capitale umano e sociale rispetto alle medie europee ed ai grandi paesi dell’Europa, Francia, Germania e Regno unito, ma anche Spagna.
Le figure 1 e 2, relative al valore aggiunto ed all’indice di produzione industriale, testimoniano la stasi recessiva in atto.
Fig. 1 L’arresto della crescita economica: valore aggiunto per settori (Istat, Eurostat)
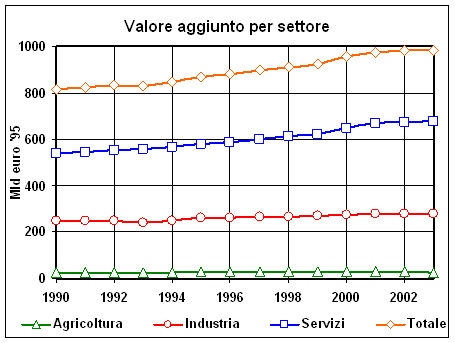
Fig. 2 Inversione degli indici della produzione industriale dopo il 2000 (Istat, Eurostat)
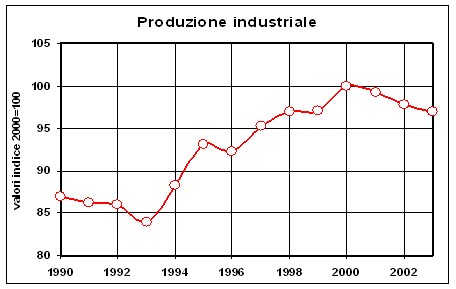
Il rapporto qui presentato esamina a più voci lo stato della sostenibilità del sistema industriale del nostro paese sullo sfondo della crisi conclamata dell’economia nazionale che ha ragioni strutturali oltre che indubbiamente congiunturali. L’esame viene condotto lungo le direttrici tradizionali dello sviluppo sostenibile, economia, ambiente e società per sottolineare gli elementi propositivi delle azioni da intraprendere per superare la congiuntura sfavorevole ed avviare il paese lungo la direttrice di un altro e più sostenibile tipo di sviluppo.
All’analisi di questa fase è dedicata la prima parte del documento che, seguendo le proposte sul tappeto nel dibattito interno al centrosinistra, delinea le tipologie di intervento necessarie a breve ed a medio termine per determinare la inversione degli indici dello sviluppo e l’inizio di una nuova ripresa.
L’esame della storia recente dei distretti industriali, forma caratteristica di aggregazione della piccola impresa nel nostro paese, sembra mostrare l’esaurimento anche di questa spinta, che ha supportato l’economia italiana nel periodo della modernizzazione post-fordista. I distretti hanno spesso dimostrato capacità di stabilire efficaci rapporti tra imprenditoria, territorio e amministrazioni locali, e talvolta la capacità di gestire adeguatamente la dimensione ambientale dei problemi, mettendo a comune parti dei processi di fine ciclo, i trasporti, il marketing, l’uso delle risorse naturali locali. Si vuole che l’esperienza dei distretti sia una prima prova della fattibilità dei paradigmi dell’ecologia industriale. Ciò è vero solo in parte, poiché spesso il distretto si è organizzato sulle affinità dei processi piuttosto che sulla loro complementarità e sulla chiusura dei cicli. Tuttavia dal successo dell’innovazione praticata dai distretti si derivano alcuni insegnamenti indispensabili per guidare l’auspicata trasformazione dimensionale del sistema delle imprese.
Il documento approfondisce nella chiave dello sviluppo sostenibile il problema della competitività del sistema italiano. Viene suggerita una definizione generale di competitività che si riferisce strettamente ai contenuti del Progetto del Consiglio europeo, lanciato a Lisbona nell’anno 2000, che contiene l’idea guida della società della conoscenza. A tale progetto l’Unione ha dato in seguito senso compiuto aggregando alle dimensioni economiche e sociali del progetto di Lisbona le linee di indirizzo del VI Programma di azione ambientale, andando così a costruire una vera e propria strategia europea per lo sviluppo sostenibile. La competitività industriale è definita come cardine della competitività di sistema.
La responsabilità di impresa (Corporate Responsibility) è la manifestazione di una presa d’atto del mondo imprenditoriale a livello internazionale dei problemi dello sviluppo sostenibile nelle dimensioni ambientale e sociale. Sono ormai molte le iniziative che testimoniano questo tipo di svolta. Un’inchiesta di parte terza mette in luce il punto di vista delle imprese analizzando gli elementi di questa trasformazione, in atto anche in Italia, sia pure con qualche ritardo.
Lo strumento della fiscalità ecologica viene analizzato in relazione al quadro complessivo delle politiche e delle misure in favore dello sviluppo sostenibile economico e sociale e della protezione dell’ambiente con riferimento alla situazione europea ed alle proposte comunitarie per l’innovazione. Vengono presentate le linee di orientamento per una riforma ecologica della fiscalità per l’Italia. La fiscalità ha un ruolo prioritario generale per modificare il modello attuale di produzione e consumo e per riavviare lo sviluppo all’interno delle direttrici della sostenibilità.
Il documento esamina i dati e gli indici della competitività in Italia, con riferimento in particolare ai maggiori paesi dell’Unione. I dati mettono in luce una fase di perdita progressiva e perdurante della qualità della nostra economia. I due indici di competitività del World Economic Forum, il BCI e il GCI, denunciano nell’arco del triennio 2002-2004 una sorta di “corsa verso il fondo” dell’economia italiana[2] che, nel ranking di 104 paesi, scala di una quindicina di posizioni, tra il 40° ed il 50° posto. Si consideri che il rapporto sullo sviluppo umano dell’UNDP[3], la cui versione 2005 è stata resa pubblica in settembre, colloca l’Italia al 21° posto nel mondo. Si tratta come si vede, di posizionamenti ben lontani dai primi, tale essendo il rango che ci compete nel G8, il gruppo dei primi otto paesi più industrializzati del mondo.
Fig. 3 Il bilancio import-export di capitali, beni e servizi (Istat, Eurostat)
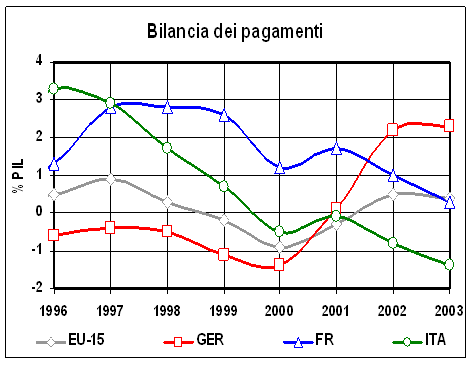
Posto che le origini del declino sono quelle indicate, è l’intero corpo sociale a portarne i segni. Il declino si determina infatti non solo a causa della perdita di competitività e di capacità di innovazione nei diversi settori della produzione, ma anche, sul piano sociale, dal degrado della qualità occupazionale, dalla precarietà giovanile, della fiducia ed, inevitabilmente, sul piano ambientale. Tutte queste tendenze sono state aggravate ed accelerate dall’amministrazione di centro destra, una amministrazione tardo liberista, ostile alle istanze dei diritti umani e sociali, dichiaratamente ed attivamente eco-scettica.
La questione sociale più delicata è quella della occupazione. Richiamata negli obiettivi tra i diritti inalienabili degli europei, l’occupazione è associata a qualità come “piena” e “buona” ma in Italia il disagio sociale cresce nel settore del lavoro, specialmente tra i giovani, le donne e, recentemente, nel settore dell’immigrazione. I differenziali Nord-Sud rimangono abnormi, ma il fenomeno del lavoro nero e dell’economia sommersa è andato fuori controllo ed è una peculiarità essenzialmente italiana nel panorama europeo. I cambiamenti introdotti dal governo nei regimi contrattuali hanno introdotto molta precarietà ed incertezza nel futuro in nome della flessibilità. Le cifre della disoccupazione, calcolate nel nuovo regime, migliorano, ma le cifre dell’occupazione ed i differenziali salariali, regionali, e di genere peggiorano.
La dimensione sociale della competizione viene esaminata nel documento con attenzione particolare ai delicati processi di formazione del capitale umano e sociale ed all’allontanamento in atto nel paese dai target di quella che dovrà essere la società basata sulla conoscenza.
Le criticità ambientali gravi sono nel paese, come nel mondo industrializzato, determinate dal settore dei trasporti e dell’energia. Se si esamina la serie storica delle emissioni di anidride carbonica (Fig. 4) si vede che ci stiamo allontanando pesantemente dall’obiettivo di Kyoto (-6,5% rispetto al 90) per effetto dei trasporti e dell’energia. I settori industriale, edilizia ed agricoltura sono invece sostanzialmente vicini al target, ed avrebbero anzi conseguito l’obiettivo della stabilizzazione al 1990.
Sono settori nei quali si manifestano più direttamente gli effetti della mancata crescita, un certo grado di dematerializzazione assieme a fenomeni come le delocalizzazioni delle lavorazioni industriali gravose in termini di forza lavoro e di risorse naturali, non ancora ben studiati dal punto di vista ambientale. Non vi è però dubbio che questi sono i settori dove hanno operato con maggiore efficacia le politiche ambientali e le regolamentazioni e dove l’innovazione ha dato frutti benefici per l’ambiente, Si osservino i dati degli abbattimenti delle emissioni inquinanti in atmosfera (Fig. 5), per alcuni aspetti confortanti, ed i dati complessivi delle certificazioni ambientali e delle etichettature ecologiche (Fig. 6) in rapida crescita in tutto il settore della produzione di beni e servizi con ritmi buoni, migliori delle medie europee.
Fig. 4 Le emissioni di anidride carbonica dei settori economici (Apat)
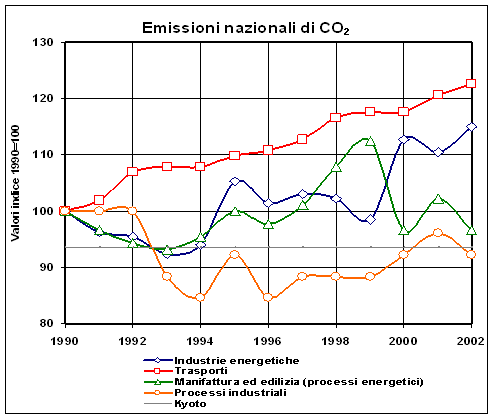
Nelle tre dimensioni della sostenibilità la performance ambientale del comparto industriale sembra la più confortante. Al netto degli avvertimenti già dati va detto che in questo comparto si avvertono meglio i segni dell’innovazione e della modernizzazione ecologica, pressoché ferme entrambe nei settori energia e trasporti.
Per questo motivo, che fa del settore industriale un’area privilegiata per l’innovazione ecologica e le trasformazioni tecnologiche, il documento tratta in maniera privilegiata la questione delle tecnologie ambientali per lo sviluppo sostenibile a partire dalla visione europea del problema, avanzata in un recente documento indirizzato dal CESE, Comitato Economico e Sociale, alla Commissione, nel quale si afferma la coerenza tra gli interessi dello sviluppo e la diffusione di tecnologie e procedure ambientalmente favorevoli, al di la di superate visioni conflittuali che non hanno fatto altro che ritardare la modernizzazione dell’industria continentale.
Fig. 5 Inquinanti atmosferici primari (Apat 2004)
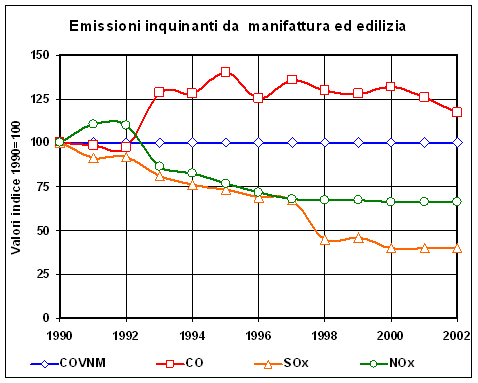
Fig. 6 Indice aggregato delle certificazioni ambientali volontarie (CNEL 2005)
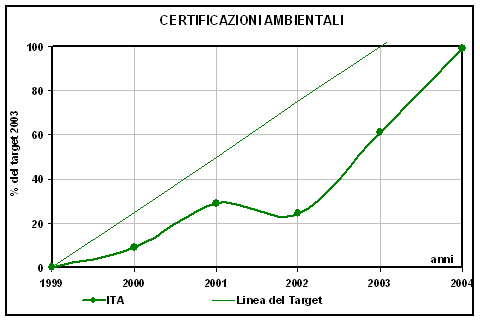
La seconda parte del documento è dedicata ai settori dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura che hanno già intrapreso un modello di sviluppo interno favorevole ai principi della sostenibilità, certamente in nome delle “convenienze” della modernizzazione ecologica, ma anche per adesione soggettiva ed originale alle visioni dello sviluppo sostenibile.
Certamente tali tendenze vanno affermandosi in alcuni settori prima che in altri. Questo gruppo non costituisce certamente un club dal momento che questo tipo di scelte si va affermando in gran parte dei settori produttivi, pur con il proverbiale ritardo nel nostro paese. Sensibilità si evidenzia, ad esempio, nel settore ICT, tra i provider di servizi telematici, nella manifattura e nella fornitura di servizi alle imprese ed al cittadino. Anche nel settore della amministrazione pubblica, in particolare nelle amministrazioni locali, si fa strada per altro verso una sensibilità crescente agli obiettivi della sostenibilità.
Una dimostrazione di adesione viene dai patti volontari con imprese singole, distretti ed associazioni imprenditoriali. La stessa Confindustria ha ormai assunto un ruolo di riferimento per le politiche ambientali dell’amministrazione centrale e si pone , pur se con importanti contraddizioni, come interlocutore effettivo nella discussione e nella ricerca del consenso sulle politiche di sostenibilità. Il documento contiene schede analitiche e programmatiche per i seguenti settori.
q Energie rinnovabili e microgenerazione
q Turismo
q Riciclo
La terza parte del documento è dedicata alla strumentazione per le politiche pubbliche per la protezione dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. La derivazione europea di buona parte di queste procedure è tanto evidente quanto necessaria per il loro possibile successo.
Per l’innovazione dei processi industriali viene prodotta una scheda per la diffusione in Italia del Piano d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP). Sul lato del consumo da tempo si sono introdotte le pratiche di etichettatura ambientale dei prodotti che ora trova riscontro in una cornice comunitaria coerente, la IPP, Politica integrata di prodotto, che definisce i paradigmi dell’innovazione ecologica dei prodotti e dei servizi nel quadro concettuale del cosiddetto life cycle thinking.
Di grande rilievo è il ruolo della pubblica amministrazione come consumatore. Tanto il consumo interno, energia, acqua, trasporti, quanto l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni è ecologicamente inefficiente e, a conti fatti, fortemente foriero di sprechi e di diseconomie, alle quali va posto rimedio con una iniziativa nazionale in favore della committenza ecologica. Il documento espone i termini dell’iniziativa europea per il Green Public Procurement (GPP).
L’innovazione ecologica del sistema industriale segue due linee concettualmente diverse, entrambe indispensabili per lo sviluppo sostenibile.
La prima comporta l’adozione delle normative obbligatorie il rispetto delle regolamentazioni ambientali. Il documento presenta in due schede altrettante procedure di origine comunitaria per la prevenzione, l’autorizzazione ed il controllo della produzione e delle emissioni di sostanze inquinanti. La procedura di controllo integrato delle emissioni inquinanti è IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control. La procedura REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals è in corso di adozione per l’inventario, la registrazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche di produzione industriale.
La seconda via è, all’opposto, quella delle scelte volontarie di soluzioni innovative nella gestione delle imprese e nel marketing dei prodotti. Volontaria è l’adesione al programma della qualità e la adozione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), che procedono lungo due direttrici, le norme ISO, in particolare la ISO 14001, che provengono dal mondo anglosassone sotto forma di iniziative garantite dallo stesso sistema delle imprese e le certificazioni ambientali a standard europeo, EMAS, che prevedono l’autorizzazione da parte di un soggetto indipendente ed in Italia vengono gestite dal sistema pubblico. La promozione della qualità ambientale è affidata al sistema delle etichettature ecologiche, ecolabel, ed in particolare al marchio comunitario.
Il documento propone una serie di incentivi per diffondere questi tipi di procedure i cui effetti sull’ambiente e sulla sostenibilità sono determinate anzitutto dal fatto che le adozioni volontarie delle certificazioni e dei marchi richiedono che le aziende facciano ordine nella sequenza dei processi interni e ne programmino la riqualificazione ambientale. Non è infrequente che queste innovazioni diano luogo ad importanti economie di gestione da parte delle aziende. Le etichette di qualità energetica ed ambientale dei prodotti hanno incontrato il favore dei consumatori, favorevoli alla qualità ed alla innovazione ecologica genuina, garantita e certificata, se non comporta aggravi di spesa eccessivi non compensati da economie di esercizio chiare e dimostrabili.
La quarta parte del documento è dedicata ai primi elementi di una riflessione tentativa sui problemi della semplificazione delle procedure, impostata secondo una visione unitaria basata sull’adozione dei principi e delle modalità di valutazione della sostenibilità. Un capitolo è dedicato al governo della conflittualità sul territorio.
Leggi il rapporto...
PER LA RIPRESA DELL’ECONOMIA IN ITALIA
LO STRUMENTO DELLA FISCALITÀ
LE GUIDE DELLA SOSTENIBILITÀ
DIMENTICARE IL PIL
PRIMA PARTE
I NUMERI DELLA CRISI
LE LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO A BREVE TERMINE
LE LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO A MEDIO TERMINE
PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO
L’INDUSTRIA VERDE
I DISTRETTI INDUSTRIALI ITALIANI IN EVOLUZIONE
I TERRITORI DELLO SVILUPPO
LA EVOLUZIONE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI
IL DISTRETTO CAPACE E SOSTENIBILE COME COSTRUTTO SOCIALE E SOCIETÀ ARTIFICIALE
PROSPETTIVE PER I DISTRETTI INDUSTRIALI
COMPETITIVITà ED ECOEFFICIENZA
LA COMPETITIVITÀ COME PARAMETRO DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ DELL’ECONOMIA
COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
LA FORMAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO
IL PARADOSSO DI KALDOR
POLITICHE ATTIVE PER LA COMPETITIVITÀ
LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA COMPETIZIONE
L’IDEA DI SVILUPPO
LA CRISI ITALIANA
LA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA
TECNOLOGIE AMBIENTALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ECO-EFFICIENZA, TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ
I FATTORI DELL’ECO-EFFICIENZA SECONDO HERMANN DALY
CRESCITA ED ECO-EFFICIENZA
ECOLOGIA INDUSTRIALE
APPLICAZIONI DELL’ECOLOGIA INDUSTRIALE A LIVELLO INTERNAZIONALE
IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE DELLE IMPRESE
LA SOSTENIBILITÀ COME STRATEGIA DI IMPRESA
IL CONTESTO NAZIONALE
LO STRUMENTO DELLA FISCALITÀ ECOLOGICA
DATI EUROPEI ED ITALIANI A CONFRONTO
DATI ED INDICI DELLA COMPETITIVITÀ IN ITALIA
GLI INDICI DEL WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)
IL SISTEMA DI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA
IL SISTEMA ISSI DI INDICATORI CNEL 2005
SECONDA PARTE
COMPETITIVITÀ, ENERGIA ED EMISSIONI SERRA
IL MERCATO DELL’ENERGIA E DELLE FONTI RINNOVABILI
IL QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO
IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL MERCATO ENERGETICO
PRODUZIONE ALIMENTARE E SVILUPPO SOSTENIBILE
SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGRICOLTURA IN ITALIA
AGRICOLTURA DI QUALITÀ
LA QUALITÀ A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROALIMENTARE ITALIANA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE IN AGRICOLTURA
IL COMPARTO PRODUTTIVO VITIVINICOLO
SERVIZI AMBIENTALI ED INDUSTRIA VERDE
EFFICACIA NEL CAMBIAMENTO DEL MODELLO DI PRODUZIONE E CONSUMO E NELLA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI
POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DEL COMPARTO
I CONSORZI OBBLIGATORI: L’INDUSTRIA DEL RICICLO
LO SCENARIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
GLI IMPATTI DEL SETTORE EDILIZIO
GLI EFFETTI AMBIENTALI
SOLUZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ
CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA
CASI STUDIO IN ITALIA
TURISMO SOSTENIBILE
TURISMO, SISTEMA LOCALE E ATTORI SOCIALI
STRATEGIE DI SVILUPPO TURISTICO
TERZA PARTE
SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI E DEI PRODOTTI INDUSTRIALI
SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI INDUSTRIALI
TECNOLOGIE AMBIENTALI
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE: PROCEDURA ISO 14001
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE: SCHEMA DI ECOGESTIONE ED AUDIT (EMAS)
SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI INDUSTRIALI
IPP: POLITICA INTEGRATA DI PRODOTTO
ECOLABEL: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
GREEN PUBLIC PROCUREMENT
ALLEGATO I – Integrazione delle considerazioni ambientali negli appalti pubblici
ALLEGATO II – Appalti pubblici e risparmio energetico
CONTROLLI AMBIENTALI
IPPC: POLITICHE INTEGRATE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO
LA PROCEDURA REACH
QUARTA PARTE
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E LA LEGGE DI DELEGA AMBIENTALE
SEMPLIFICAZIONE E STRUMENTI VOLONTARI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
LA GOVERNANCE DEI CONFLITTI TERRITORIALI